RECENSIONE SAGGIO Raymond Cahn, La fine del divano?
16 marzo, 2014 - 14:35
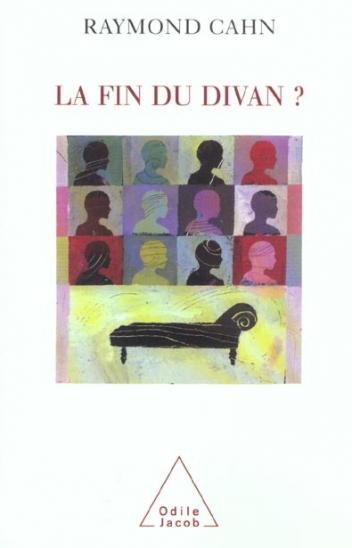
Editore: Borla
Anno: 2004
Pagine: 210
Costo: €19.00
Denso, coraggioso e ancora attualissimo questo lavoro di Raymond Cahn. L’autore, uno psicoanalista della Società Psicoanalitica Francese, analizza con dovizia di particolari le caratteristiche più proprie della pratica psicoanalitica cercando di distinguere, per quanto possibile, gli elementi a cui essa può rinunciare (pur non snaturando l’identità del processo e le sue finalità), da quelli invece fondamentali. Tale distinzione risulta essenziale per un aggiornamento e rafforzamento della psicoanalisi in un’epoca, quella nostra, in cui questa ha dovuto confrontarsi con gli attacchi e le critiche, spesso giuste e comprensibili, che le provenivano dall’esterno ma anche dal proprio interno. Distinguere così ciò che c’è di accessorio da quanto più propriamente definisce il lavoro autenticamente psicoanalitico permette secondariamente di fare chiarezza anche in un mondo, quello attuale delle psicoterapie, sempre più variegato e complesso, ma anche sempre più pieno di trattamenti che non hanno una teoria chiara alla base del proprio operare, che prendono indebitamente spunto da approcci più consolidati, oppure che fanno dell’eclettismo e dell’improvvisazione il proprio marchio di fabbrica.
In particolare Cahn si sofferma sulla questione del setting psicoanalitico, specificatamente in relazione all’utilizzo del lettino e alla frequenza delle sedute, e ne conclude che essi non costituiscono un elemento così determinante affinché possa avviarsi un processo esplorativo autentico, pur ritenendo che, a tale scopo, il dispositivo standard definito da Freud possa ancora costituire lo strumento più potente per avviarlo. La necessità di questo ripensamento scaturisce dal fatto che la psicoanalisi si è dovuta confrontare con rapidi cambiamenti culturali e sociali (basti pensare al mutamento delle risorse economiche e di conoscenza nella popolazione generale e alle caratteristiche intrapsichiche dei pazienti in cura), oltre che scientifici (l’invenzione degli psicofarmaci e il potenziamento di altre tecniche terapeutiche), che hanno modificato la disponibilità e la sensibilità delle persone al suo approccio, così lungo e faticoso, al disagio mentale.
Le strade che tuttora si possono percorrere sono due, secondo l’autore: isolarsi nella torre eburnea dell’ortodossia o adattarsi ai tempi e alla cultura attuali, cercando di mantenere e valorizzare quanto di più specifico denota il lavoro ad orientamento psicoanalitico.
Cahn è assolutamente convinto che la prima sia una strada coerente da un punto di vista teorico ma destinata ad impoverire e limitare lo sviluppo della disciplina; mentre la seconda sia ben più proficua, seppur irta di ostacoli e pericoli per l’integrità della disciplina stessa. In pratica, questo significa limitare l’uso del lettino e permettersi di lavorare a frequenze nettamente inferiori rispetto alle tre/quattro sedute settimanali del trattamento standard, dando inoltre più spazio ad interventi e tecniche che, pur non uscendo dall’alveo dell’esplorazione intrapsichica e dell’analisi dei conflitti propriamente detti, si permettano anche di sostenere maggiormente l’Io del paziente, di dare più spazio alla sua vita reale e alla figura reale del terapeuta, a scapito, magari, di una riduzione del lavoro sul transfert. Tutto ciò si renderebbe necessario anche e soprattutto per la prevalenza delle problematiche prettamente narcisistiche, rispetto a quelle conflittuali-oggettuali, tra i pazienti che arrivano oggi in cura, spesso carenti nelle loro capacità di simbolizzazione e di regolazione della distanza interpersonale e che, proprio per questo, necessitano di un terapeuta che sia fisicamente più presente, più facilmente ritrovabile dinnanzi alla temperie cognitivo-emotiva cui tendono ad andare incontro nel corso del trattamento. Concedersi delle modifiche sostanziali per poter più efficacemente lavorare con altre tipologie di pazienti, probabilmente le più frequenti oggi, costituisce un’opportunità di evoluzione, secondo Cahn, per la psicoanalisi; tale scelta garantirebbe la possibilità di sondare nuovi registri di relazione coi pazienti più gravi e la possibilità di far evolvere e perfino arricchire la teoria.
questo non significa rinunciare agli obiettivi e alle possibilità che offre un lavoro autenticamente analitico, ossia l’elaborazione delle difese e del transfert, ma ottenere ciò per altre vie; oppure, più propriamente, creare le condizioni per poter approntare questo compito in un secondo momento, quando l’evoluzione dello stato intrapsichico del paziente lo permetterà. D’altronde bisogna tener presente che, realisticamente, il lavoro sul transfert non è possibile completarlo, e l’analisi stessa non fa che iniziare e rafforzare un processo - quello della conoscenza e dell’esplorazione di sé e delle proprie relazioni presenti e passate - che il paziente dovrà poi continuare da solo nel corso di tutta la vita. Altro dato non irrilevante, sottolinea Cahn, queste modifiche di atteggiamento e di setting possono permettere allo psicoanalista di uscire da periodi di impasse coi propri pazienti o di non incorrere, specie con alcuni di loro, in pseudo-analisi in cui apparentemente il lavoro procede bene in seduta ma che non portano a cambiamenti di rilievo nella vita del paziente (se non un aumento sterile della sua comprensione di sé, che rimane però ad un livello puramente cognitivo), oppure in quelle analisi che si trasformano in processi interminabili in cui, a causa dell’elevata frequenza delle sedute, delle caratteristiche tipiche del processo oltre che dei due partecipanti, si instaura una collusione vischiosa che impedisce anche solo la possibilità di pensare ad una separazione (le cosiddette analisi interminabili). Non sono pochi i casi, secondo l’autore, di trattamenti standard interrotti o conclusi non proprio proficuamente dopo anni di lavoro, e poi ripresi più efficacemente con un setting che non prevedeva più l’uso del lettino e di una frequenza elevata.
Certo, lavorare con il vis à vis in modo autenticamente analitico comporta notevoli rischi per il terapeuta, che si ritrova più spesso nella condizione di agire il proprio controtransfert perché più sollecitato dall’interazione emotiva e dalle richieste consce o inconsce del paziente. Egli deve così essere ancora più saldo nella consapevolezza del senso del proprio lavoro, cercando di evitare un uso eccessivo della gratificazione, del sostegno non necessario all’Io, della manipolazione pedagogica, della suggestione, aspetti riscontrabili facilmente in altri approcci terapeutici non analitici. E allo stesso tempo non potrà sottrarsi all’arduo compito di svolgere un ruolo più attivo nel processo di elaborazione, specie con pazienti che mostrano gravi carenze nella capacità di metaforizzazione e di mantenimento di un senso di coesione della propria identità. In tali situazioni, il vis à vis, unito ad un atteggiamento più supportivo e chiaramente partecipativo del terapeuta, che può giungere in certi frangenti fino all’autorivelazione, costituisce certamente una nuova possibilità di cura che, mantenendo l’obiettivo finale di un cambiamento strutturale nel paziente e di una sua autentica soggettivazione attraverso la riflessione sui vissuti, la chiarificazione e l’interpretazione - pur usate con parsimonia - si affianca a tutti gli effetti e senza timori reverenziali alla psicoanalisi classica come modalità privilegiata di cura.
Infine, viene affrontato il delicato tema della conclusione del percorso di cura e dei suoi esiti - aspetti non sempre facilmente definibili - oltre che delle differenti tipologie di trattamento e di ciò che ci si può aspettare da essi. In particolare, si evidenzia la netta distinzione tra trattamenti basati su una cura del sintomo, o di quanto fenomenologicamente più visibile, e trattamenti che intendono modificare o ristrutturare in senso più ampio la personalità del soggetto, il suo funzionamento mentale. L’autore rivendica il ruolo preminente delle psicoterapie espressive di ispirazione analitica che, pur prevedendo tempi più dilatati di cura, hanno maggiori possibilità di ottenere risultati stabili e esistenzialmente rilevanti per il paziente, pur nella consapevolezza che la scelta finale su quale tipo di trattamento scegliere spetta al paziente stesso e al terapeuta, nel suo valutare quale sia la natura della domanda e delle possibilità, intrapsichiche e materiali, di quello specifico individuo.
Tra le opzioni terapeutiche non viene dimenticata quella farmacologica, che si staglia al primo posto, quanto a rapidità, tra tutti i procedimenti che promettono una riduzione o cessazione del sintomo. Si evidenzia il riduzionismo di questa prospettiva medicalizzante, insito sia nella scelta privilegiata o esclusiva del trattamento farmacologico del disagio mentale - scelta che non tiene in considerazione le dimensioni della personalità di cui i sintomi sono solo la manifestazione più eclatante - sia nel fatto di considerare l’individuo sofferente come oggetto della sua sofferenza (sofferenza ridotta a sua volta ad una lista di sintomi), come vittima passiva di un qualcosa di alieno da sé che sarebbe la cosiddetta malattia mentale.
Un libro coraggioso, questo di Cahn, che cerca di approfondire sia le questioni di metodo che di contenuto dell’operare terapeutico, e che si interroga intelligentemente sui limiti e sulle possibilità che sono presenti dentro e fuori al mondo psicoanalitico, in un’ottica di integrazione, di apertura e di evoluzione continua dei vari saperi psicologici.
In particolare Cahn si sofferma sulla questione del setting psicoanalitico, specificatamente in relazione all’utilizzo del lettino e alla frequenza delle sedute, e ne conclude che essi non costituiscono un elemento così determinante affinché possa avviarsi un processo esplorativo autentico, pur ritenendo che, a tale scopo, il dispositivo standard definito da Freud possa ancora costituire lo strumento più potente per avviarlo. La necessità di questo ripensamento scaturisce dal fatto che la psicoanalisi si è dovuta confrontare con rapidi cambiamenti culturali e sociali (basti pensare al mutamento delle risorse economiche e di conoscenza nella popolazione generale e alle caratteristiche intrapsichiche dei pazienti in cura), oltre che scientifici (l’invenzione degli psicofarmaci e il potenziamento di altre tecniche terapeutiche), che hanno modificato la disponibilità e la sensibilità delle persone al suo approccio, così lungo e faticoso, al disagio mentale.
Le strade che tuttora si possono percorrere sono due, secondo l’autore: isolarsi nella torre eburnea dell’ortodossia o adattarsi ai tempi e alla cultura attuali, cercando di mantenere e valorizzare quanto di più specifico denota il lavoro ad orientamento psicoanalitico.
Cahn è assolutamente convinto che la prima sia una strada coerente da un punto di vista teorico ma destinata ad impoverire e limitare lo sviluppo della disciplina; mentre la seconda sia ben più proficua, seppur irta di ostacoli e pericoli per l’integrità della disciplina stessa. In pratica, questo significa limitare l’uso del lettino e permettersi di lavorare a frequenze nettamente inferiori rispetto alle tre/quattro sedute settimanali del trattamento standard, dando inoltre più spazio ad interventi e tecniche che, pur non uscendo dall’alveo dell’esplorazione intrapsichica e dell’analisi dei conflitti propriamente detti, si permettano anche di sostenere maggiormente l’Io del paziente, di dare più spazio alla sua vita reale e alla figura reale del terapeuta, a scapito, magari, di una riduzione del lavoro sul transfert. Tutto ciò si renderebbe necessario anche e soprattutto per la prevalenza delle problematiche prettamente narcisistiche, rispetto a quelle conflittuali-oggettuali, tra i pazienti che arrivano oggi in cura, spesso carenti nelle loro capacità di simbolizzazione e di regolazione della distanza interpersonale e che, proprio per questo, necessitano di un terapeuta che sia fisicamente più presente, più facilmente ritrovabile dinnanzi alla temperie cognitivo-emotiva cui tendono ad andare incontro nel corso del trattamento. Concedersi delle modifiche sostanziali per poter più efficacemente lavorare con altre tipologie di pazienti, probabilmente le più frequenti oggi, costituisce un’opportunità di evoluzione, secondo Cahn, per la psicoanalisi; tale scelta garantirebbe la possibilità di sondare nuovi registri di relazione coi pazienti più gravi e la possibilità di far evolvere e perfino arricchire la teoria.
questo non significa rinunciare agli obiettivi e alle possibilità che offre un lavoro autenticamente analitico, ossia l’elaborazione delle difese e del transfert, ma ottenere ciò per altre vie; oppure, più propriamente, creare le condizioni per poter approntare questo compito in un secondo momento, quando l’evoluzione dello stato intrapsichico del paziente lo permetterà. D’altronde bisogna tener presente che, realisticamente, il lavoro sul transfert non è possibile completarlo, e l’analisi stessa non fa che iniziare e rafforzare un processo - quello della conoscenza e dell’esplorazione di sé e delle proprie relazioni presenti e passate - che il paziente dovrà poi continuare da solo nel corso di tutta la vita. Altro dato non irrilevante, sottolinea Cahn, queste modifiche di atteggiamento e di setting possono permettere allo psicoanalista di uscire da periodi di impasse coi propri pazienti o di non incorrere, specie con alcuni di loro, in pseudo-analisi in cui apparentemente il lavoro procede bene in seduta ma che non portano a cambiamenti di rilievo nella vita del paziente (se non un aumento sterile della sua comprensione di sé, che rimane però ad un livello puramente cognitivo), oppure in quelle analisi che si trasformano in processi interminabili in cui, a causa dell’elevata frequenza delle sedute, delle caratteristiche tipiche del processo oltre che dei due partecipanti, si instaura una collusione vischiosa che impedisce anche solo la possibilità di pensare ad una separazione (le cosiddette analisi interminabili). Non sono pochi i casi, secondo l’autore, di trattamenti standard interrotti o conclusi non proprio proficuamente dopo anni di lavoro, e poi ripresi più efficacemente con un setting che non prevedeva più l’uso del lettino e di una frequenza elevata.
Certo, lavorare con il vis à vis in modo autenticamente analitico comporta notevoli rischi per il terapeuta, che si ritrova più spesso nella condizione di agire il proprio controtransfert perché più sollecitato dall’interazione emotiva e dalle richieste consce o inconsce del paziente. Egli deve così essere ancora più saldo nella consapevolezza del senso del proprio lavoro, cercando di evitare un uso eccessivo della gratificazione, del sostegno non necessario all’Io, della manipolazione pedagogica, della suggestione, aspetti riscontrabili facilmente in altri approcci terapeutici non analitici. E allo stesso tempo non potrà sottrarsi all’arduo compito di svolgere un ruolo più attivo nel processo di elaborazione, specie con pazienti che mostrano gravi carenze nella capacità di metaforizzazione e di mantenimento di un senso di coesione della propria identità. In tali situazioni, il vis à vis, unito ad un atteggiamento più supportivo e chiaramente partecipativo del terapeuta, che può giungere in certi frangenti fino all’autorivelazione, costituisce certamente una nuova possibilità di cura che, mantenendo l’obiettivo finale di un cambiamento strutturale nel paziente e di una sua autentica soggettivazione attraverso la riflessione sui vissuti, la chiarificazione e l’interpretazione - pur usate con parsimonia - si affianca a tutti gli effetti e senza timori reverenziali alla psicoanalisi classica come modalità privilegiata di cura.
Infine, viene affrontato il delicato tema della conclusione del percorso di cura e dei suoi esiti - aspetti non sempre facilmente definibili - oltre che delle differenti tipologie di trattamento e di ciò che ci si può aspettare da essi. In particolare, si evidenzia la netta distinzione tra trattamenti basati su una cura del sintomo, o di quanto fenomenologicamente più visibile, e trattamenti che intendono modificare o ristrutturare in senso più ampio la personalità del soggetto, il suo funzionamento mentale. L’autore rivendica il ruolo preminente delle psicoterapie espressive di ispirazione analitica che, pur prevedendo tempi più dilatati di cura, hanno maggiori possibilità di ottenere risultati stabili e esistenzialmente rilevanti per il paziente, pur nella consapevolezza che la scelta finale su quale tipo di trattamento scegliere spetta al paziente stesso e al terapeuta, nel suo valutare quale sia la natura della domanda e delle possibilità, intrapsichiche e materiali, di quello specifico individuo.
Tra le opzioni terapeutiche non viene dimenticata quella farmacologica, che si staglia al primo posto, quanto a rapidità, tra tutti i procedimenti che promettono una riduzione o cessazione del sintomo. Si evidenzia il riduzionismo di questa prospettiva medicalizzante, insito sia nella scelta privilegiata o esclusiva del trattamento farmacologico del disagio mentale - scelta che non tiene in considerazione le dimensioni della personalità di cui i sintomi sono solo la manifestazione più eclatante - sia nel fatto di considerare l’individuo sofferente come oggetto della sua sofferenza (sofferenza ridotta a sua volta ad una lista di sintomi), come vittima passiva di un qualcosa di alieno da sé che sarebbe la cosiddetta malattia mentale.
Un libro coraggioso, questo di Cahn, che cerca di approfondire sia le questioni di metodo che di contenuto dell’operare terapeutico, e che si interroga intelligentemente sui limiti e sulle possibilità che sono presenti dentro e fuori al mondo psicoanalitico, in un’ottica di integrazione, di apertura e di evoluzione continua dei vari saperi psicologici.








