IL SOGGETTO COLLETTIVO
Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale
Sulle narrazioni freudiane
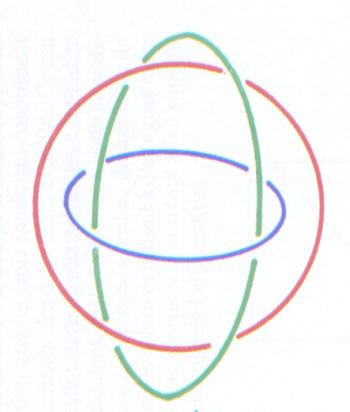
Questo allora è il supremo paradosso del pensiero: voler scoprire qualcosa che esso non può pensare. S.A. Kierkegaard, Briciole filosofiche, 1844
Da quando, circa vent’anni fa, uscii dall’ultima associazione psicanalitica, che pure avevo contribuito a fondare, il mio lavoro teorico e pratico in psicanalisi subì un’impennata. Non più costretto da vincoli istituzionali né all’obbedienza di scuola (di chiesa) né al rispetto del codice di appartenenza, potevo pensare e praticare liberamente la “mia” psicanalisi, reinventandola a ogni occasione sia teorica sia clinica. Nella teoria, importai nel freudismo l’intuizionismo di Brouwer; nella clinica, modulai meglio le sedute brevi secondo Lacan, trasformandole in variabili e allontanandomi sempre più dall’assetto medico della psicoterapia. Mi piaceva definirmi, più che altro per auto-incoraggiarmi: psicanalista free lance.
Non fu l’esito di un’improvvisata rivoluzione intellettuale né di una strisciante eresia; fu un’intuizione, inizialmente incerta ma progressiva: confusamente percepivo che non si può conservare tutto dei grandi autori del passato, nel mio caso Freud e Lacan, un po’ più defilati Jung e la Klein. L’olismo non è fecondo, mi dicevo. Inevitabili contraddizioni a parte, il tutto opprime e ostacola l’affiorare della singolarità nuova. Per contro, vedevo nell’approccio selettivo, scartando molto del vecchio, la possibilità di tentare la ricerca di nuove vie, magari non proprio eterodosse, ma alternative all’ortodossia. La selezione, intesa in senso darwiniano, promuove la diversità, che è vitale anche per la vita del pensiero.
Semplice a dirsi, ma con una difficoltà soggettiva. Stavo perdendo i compagni. Mi trovavo a lavorare da solo; i compagni rimanevano indietro, fissati a tutto di Freud o a tutto di Lacan, addirittura a tutto di Lacan-con-Freud, nell’illusione che l’eclettismo fosse sinonimo di completezza, ma in realtà continuando a rimasticare freudismi e lacanismi (ma solo quelli loro trasmessi dall’autorità di qualche presbitero!). La questione più rilevante era, però, un’altra, più personale. Mi interrogavo: potevo mai continuare a pensare fuori da un legame sociale concreto e riconoscibile? Potevo ancora pensare di pensare il pensiero collettivo, fondato da qualche maestro? Da Freud, in particolare? Cogito, sum significa in realtà cogitamus, sum, ma nel mio caso dove era finito il nos?
Fu una scommessa di cui solo oggi, a distanza di tempo, comincio a intravedere e ad apprezzare i risultati, primo fra tutti – e sorprendente – costatare che non ero mai rimasto veramente isolato, anche se mi vedevo solo. Ero sempre rimasto dentro a un ben determinato collettivo di pensiero, anche se non sempre definito da un’esplicita ideologia e, quindi, fisicamente indeterminato. Val la pena che mi spieghi meglio, perché sta forse qui il mio contributo più importante a questa rubrica.
* * *
Come sa chi ha letto la prima rubrica, provengo dalla cosiddetta “scienza dura”, in generale non molto apprezzata dalla cultura psicanalitica corrente. Con qualche eccezione forse. Quando per la prima volta nel lontano marzo del 1974 mi presentai a Jacques Lacan, al Palace Hotel di Milano, e gli raccontai che la mia formazione scientifica era in biometria e statistica medica, il “dottore” saltò sulla sedia dall’entusiasmo. Mi illudo che pensasse di aver trovato il matematico giusto per dargli una mano nelle sue manipolazioni topologistiche, proprio quelle performance del grande pensatore che oggi apprezzo di meno.
C’è un dato strutturale di partenza da considerare. Chi proviene dalla scienza – hard o soft che sia – non può nutrire spiccati interessi per le narrazioni, in particolare per le mitologie. Perché? Perché tra scienza e narrazione c’è un abisso come tra sapere e verità. La scienza propone un sapere in genere incerto, perché congetturale e probabilistico, cioè senza verità ultima, mentre la narrazione mitologica afferma, per lo più in modo categorico e certo, verità di cui non sa nulla. (Su academia.edu ho di recente postato un testo su questo tema, intitolato Certezza mitica vs incertezza scientifica, pubblicato sull’ultimo numero di “aut aut”). Perciò nella storia della civiltà, quando non si dispone ancora di attrezzi intellettuali e tecnologici sufficienti ad attraversare il sapere nel reale, le savoir dans le réel, come lo chiamò Lacan nella sua lettera agli italiani del 1974 – il sapere delle particelle entangled, per esempio – la confabulazione mitologica precede di necessità la vera e propria pratica scientifica, quella “delle sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni” (Galilei a Cristina di Lorena, 1615). Come purtroppo si sa bene, lo scoglio contro cui urtò la giovane scienza meccanica fu proprio la narrazione del Libro Autorevole, che il “metodo” galileiano sembrava tenere in poca considerazione. In questo senso, la psicanalisi mi sembra ancora boccheggiare in acque prescientifiche e confabulatorie, anche quando squaderna vaste sistemazioni apparentemente rigorose, in realtà solo narrative, come quelle post-freudiane di un Bion o di un Lacan, che autorevoli epigoni si incaricano di rinarrarci quotidianamente. (E sanno quel che fanno perché le narrazioni si vendono meglio delle aride teorie scientifiche).
Vent’anni fa cominciavo lentamente a rendermi conto di un fatto fin troppo evidente, che per i vent’anni precedenti – gli anni necessari alla formazione psicanalitica – non avevo voluto vedere (quando si dice la volontà di ignoranza!). In Freud, nonostante il tentato esordio scientifico, ben documentato per esempio nel Progetto di una psicologia del 1895, successivamente cestinato, c’è più narrazione mitologica che scienza. E aggiungo che Freud sapeva bene di non essere uomo di scienza. Amava definirsi un conquistador e un avventuriero del pensiero, non uno scienziato e neppure un pensatore. (Cfr. Lettera a Fliess del 1 febbraio 1900). Allora il conquistador conquistava terreno mitizzando, cioè confabulando, mentre avanzava in plaghe ignote. Del suo progredire ci lasciava resoconti nei suoi casi clinici, “che si leggono come novelle”, anche a suo dire.
Nella psicanalisi freudiana dominano quattro grandi narrazioni mitologiche, di cui in questa sede affronto le prime due, rimandando l’analisi necessariamente più complessa delle altre due – i miti pulsionali – a un prossimo intervento su questa rubrica.
I due miti fondamentali, che nella lezione xxix del 1933 Freud impose come lo scibbolet della propria proposta di cura delle psiconevrosi, furono il complesso d’Edipo e l’angoscia di castrazione. Per carità, non mi si fraintenda! Non sto facendo un discorso contro Freud. Dovendo conquistare un arduo territorio sconosciuto – quello dell’inconscio – capisco bene e giustifico che il medico di Vienna si aiutasse come poteva, raccogliendo indizi qua e là. Gli indizi della “giovane scienza” – giustamente detta indiziaria – furono le narrazioni del complesso d’Edipo e della castrazione. Sono buoni indizi, che trovano conferma in molte civiltà e in moltissime psiconevrosi. Ma, si sa, nella scienza galileiana le conferme non confermano; si limitano a corroborare congetture che rimangono congetturali e mai definitivamente confermate anche dopo qualche conferma; solo le confutazioni hanno una certa pretesa di confutare, anche se solo in regime deterministico stretto (ma non sempre ci riescono al 100%, vedi il caso delle cosiddette ipotesi zero statistiche).
Di seguito, porto acqua al mulino di Freud; applico ai miti fondanti del pensiero di Freud la stessa metodologia dell’analisi freudiana del sogno. Non è, però, tutta farina del mio sacco quella che esporrò. Attingo a piene mani dal sacco di Charles Seife, autore di un godibile saggio di storia della matematica: Zero. La storia di un’idea pericolosa [angosciosa?] (trad. G. Castellari, Bollati Boringhieri, Torino 2002).
In estrema sintesi, ecco di cosa si tratta. In Occidente, dal 5000 a.C. fino al xiii secolo prima della comparsa del ponderoso Liber abaci di Leonardo Pisano, detto Fibonacci, l’uno la vinceva sullo zero, appunto uno a zero. Solo molto tardi si raggiunse il pareggio, sancito definitivamente dalla numerazione binaria di Leibnitz, dove ogni numero è “cifrato” da una successione di zeri e uni. L’introduzione dello zero da parte di Fibonacci – si badi bene – non fu una mera operazione di semplificazione della contabilità commerciale, come mi hanno insegnato al mio liceo classico. (E lo fu anche, ma nel senso qui rilevante di pratica di un soggetto collettivo, fino allora fondato sulla rimozione dello zero). Dal punto di vista del “lavoro della civiltà” l’introduzione dello zero, dopo millenni di incubazione, fu molto di più di una semplice acquisizione matematica. Tuttavia, devo andare più piano perché è una storia scabrosa per i nostri diffusi e radicati pregiudizi umanistici contro numeri e formule (forse perché i numeri non narrano storie?).
Cosa stava succedendo all’alba del xiii secolo? E cosa c’entra la secolare repressione dello zero, a tutti gli effetti inteso come numero, con la psicanalisi che non era ancora stata inventata? Tenterò di rispondere a modo mio, cioè psicanalitico (un po’ folle), alla domanda peregrina, che mai psicanalista si è posto – che io sappia.
Detto in termini freudiani, nei millenni in Occidente andò istituendosi una colossale megarimozione universale, forse originaria: dalla cultura egizia alla romana, passando per la greca, e fino alla medievale, lo zero fu rimosso dalla serie dei numeri naturali, nel senso che non vi ebbe mai accesso. (Ciò depone per la rimozione primaria e non secondaria.) Poco male, mi direte. Sì, se non fosse che alla rimozione si associò la fuorclusione, come la chiamava Lacan, cioè una rimozione senza ritorno del rimosso. Insieme all’oggetto matematico dello zero, fu dal pensiero simbolico classico fuorcluso il soggetto che praticava il conteggio. Sin dai primordi – 5000 anni fa – in Occidente si cominciò a contare, talvolta in modo bizzarro, a partire dall’uno, con inconvenienti, per esempio, nel computo del calendario – Cristo nacque nell’anno primo o nell’anno prima?
E insieme al soggetto del conteggio fu fuorclusa la dimensione della soggettività che più intimamente riguarda l’essere: la femminilità. Questo è il punto scabroso da cui ripartire: per secoli l’Occidente non ha voluto sapere dello zero come della femminilità. Sul fatto che nella civiltà occidentale la femminilità sia stata pesantemente rimossa, non mi pare il caso di insistere. Insisto, invece, sull’equazione freudiana: zero = femminile.
Sono orientato a pensare che nella civiltà classica e medievale la rimozione dello zero (del femminile) sia stato lo specifico portato dell’ontologia parmenidea, per cui l’essere è… qualcosa, cioè è un uno (un ente, direbbe Heidegger), e il non essere non è, cioè lo zero non esiste, non essendo uno. Insieme allo zero, scacciati dalla prepotenza dell’Uno (vedi le monumentali Enneadi di Plotino), finirono nel sacco del rimosso collettivo della cultura occidentale altri tipici ingredienti oggettuali: l’infinito e il vuoto, ma non solo. Sulla paura dell’infinito ci intratterremo in prossime rubriche, quando parleremo degli altri due miti freudiani propriamente metapsicologici, cioè le pulsioni; sulla repulsione per il vuoto – per il non essere che è – che da Aristotele arrivò a infettare perfino Cartesio, rimando al già citato saggio di Seife.
Qui segnalo solo che la prevalenza dell’essere sul non essere conferisce una connotazione delirante al discorso ontologico occidentale, nel senso che si perde la problematica interazione tra i due, che indebolisce ogni certezza. To be or not to be… è il motore di ricerca della dialettica hegeliana, che tuttavia non uscì mai dal cerchio magico dell’Uno, inteso come Sapere Assoluto. Forse il filosofo che più avvicinò a riconoscere lo zero fu Heidegger, che lo metaforizzò come Lichtung, o radura del bosco, dove si diradano i suoi enti, gli alberi. La radura fa spazio, appunto, all’esserci in negativo dell’essere, che non è un ente, essendo almeno localmente costituita da zero alberi.
Ebbene, ecco in nuce la mia tesi, che forse dà senso alla domanda peregrina di cui sopra. Da esperto di rimozioni individuali e collettive (ma meno di queste che di quelle), Freud ripescò dalla rimozione collettiva della civiltà classica lo zero come rappresentante della femminilità. L’esca per questo ripescaggio dalla rimozione originaria della civiltà occidentale fu il mito principe di Freud, quello che costituisce la verità ultima di tutto il suo pensiero: il mito della castrazione; è il mito della mancanza del pene nella donna, cioè il destino anatomico che consacra la donna alla funzione di rappresentare fallicamente il desiderio per via di quel che non ha, il suo specifico zero.
Cosa vibra, cosa trema, allora, nella realtà psichica del maschio freudiano? Paura di perdere il pisello? Che il padre glielo tagli? Sì, anche e certamente in molti casi è così, ma è soprattutto il ritorno del rimosso collettivo – la femminilità – che inquieta la psiche, non solo maschile. Lo zero diviene l’emblema indecifrabile e perturbante a copertura del mistero dei misteri, forse perché potenziale sede del godimento ultimo e devastante: lo zero assoluto della temperatura soggettiva, simmetrico di un plusgodere non simbolizzabile che, se lo fosse, simbolizzerebbe l’impossibile reale. (Si sente che sono rimasto ancora lacaniano?) Certo, la femminilità rimase il dark continent per il nostro conquistador, e non solo per lui, ma con un correlato ben documentabile nel continente europeo: la generalizzata e millenaria fobia dello zero.
Allora, a sostegno di questa malcerta mitologia negativa, fondatrice di un’improbabile ontologia della mancanza – la donna è non tutta, avrebbe detto Lacan –, Freud convocò una mitologia positiva, che la classicità gli raccontava da tempo, riportandolo in territorio paterno meno sconcertante: il mito dell’Uno simbolico. Era il mito del padre morto o sul punto di morire: il mito di Edipo. Le due mitologie, della castrazione e della paternità, non vanno l’una senza l’altra e senza differenza di genere, come l’uno e lo zero nella numerazione binaria. È sempre lei, la castrazione, non il mito di Elettra matricida, come pretendeva Jung, il pendant femminile del parricidio edipico. Freud la declinò come invidia del pene, variante femminile dell’evirazione maschile, suscitando le ire delle femministe.
Tra i due miti freudiani oscilla il desiderio inconscio, che Freud ci ha insegnato a interpretare come formazione significante (nel senso lacaniano del termine), compresa tra la dimensione materna (castrata) dell’oggetto del desiderio e la dimensione paterna (fallica), che tale desiderio rappresenta. Fallo e castrazione insieme stanno e insieme cadono. Sono loro i protagonisti mitologici delle vicende del desiderio. Allora mi chiedo: si può metaforizzare la vicenda soggettiva in modo meno truce, teatralizzandola in modo meno antropomorfo su quella che Freud chiamava “l’altra scena” (ein anderer Schauplatz) dell’inconscio?
Certo, non avessi avuto alle spalle l’insegnamento di Lacan sulla mancanza a essere del soggetto (alla radice dell’ontologia), in simmetria rispetto al plusgodere dell’oggetto (al vertice del sapere inconscio), non avrei arrischiato queste elucubrazioni, che mi liberano in parte dalla presa immaginaria della mitologia freudiana e mi orientano a un approccio (quasi) scientifico alla psicanalisi. Soggetto in afanisi, o sempre prossimo alla dissoluzione, e oggetto non disponibile a essere afferrato, perché sempre immerso nella Versagung (sich versagen, “non concedersi”), sono i primi tasselli di una possibile psicanalisi scientifica. Allora si possono lasciar decadere il parricidio e la castrazione come gusci vuoti di un seme che sta per marcire e dare i suoi frutti.
Come proseguire? Dopo il taglio del bosco mitologico (e quello junghiano è ancora più fitto di quello freudiano e c’è più lavoro di sgombero da fare), come e dove costruire l’edificio psicanalitico?
Da freudiano convinto partirei da una semplice triangolazione interna alla dottrina freudiana: l’esistenza dell’inconscio, o di un sapere che non si sa di sapere; l’esistenza della rimozione originaria, o di rappresentazioni che non saranno mai acquisite dalla coscienza, le parti “oscure” dell’essere che sfuggono al cogito – le “ombre” di Jung; l’esistenza del differimento (o del ritardo) temporale nell’acquisizione del sapere. Sono questi tre i postulati freudiani – li chiamerei gli assiomi dell’ignoranza psicanalitica – che mi sembrano necessari per inaugurare una psicanalisi più scientifica e meno mitologica. Se, poi, ne occorresse un quarto, assente dall’elucubrazione freudiana, ma forse opportuno (quattro gambe sono meglio di tre per dare stabilità al tavolo), assumerei come ulteriore assioma l’esistenza dell’oggetto infinito come “causa” del desiderio. Ma di questo prossimamente.
* * *
Postilla conclusiva non polemica sul pensiero d’autore.
Con buona pace dell’accademia, lo dico ad alta voce: almeno per un po’ basta autori, basta ipse dixit (magari un ipse contro un ille), basta miti personali firmati da questo o da quello, basta ortodossie con le connesse inevitabili scomuniche, ça suffit, es reicht, enough! Respiriamo, cioè pensiamo. Aria fresca in mezzo a tanti indottrinamenti.
Non è un’affermazione di ostilità né verso gli autori la mia né verso chi li coltiva nel proprio orticello. Forse è solo vox clamans in deserto. Tuttavia, non polemizzo contro questo o contro quello. Mi vanno (più o meno) bene tutti gli autori, senza osannare nessuno, senza stigmatizzare nessun altro. Allora, ben vengano anche gli autori di narrazioni. Riconosco che gli autori ci vogliono per catalizzare il pensiero ma, una volta avvenuta la reazione chimica del pensiero, come la chiamava Nietzsche (v. il primo aforisma di Umano, troppo umano, 1878), ritengo che tutti gli autori possano essere messi da parte, come veri e propri catalizzatori. (Allora, saranno stati “catalizzautori”). Si può continuare a pensare senza citare a ogni piè sospinto o questo o quello (gli autori come idola theatri, secondo sir Francis Bacon), finalmente liberi da ortodossie imposte da discutibili maîtres à penser e loro successori. O Cartesio e Spinoza non ci hanno aperto la mente alla libertà del pensiero, che è anche libertà di errare? Non ci hanno stretto, all’alba dell’era scientifica, nel vero doppio legame tra libertà e ragione? Sì, ci hanno messo a servizio del pensiero, non dei pensatori.
Controprova singolare. Le equazioni della teoria della relatività ristretta e generale non sono mai state veramente di Einstein. Rispetto a Einstein Poincaré anticipò (di qualche giorno) quelle della relatività ristretta; Hilbert quelle della relatività generale (di qualche settimana). Certo, tutti furono preceduti da Riemann (di decenni) e dai nostri Levi Civita e Ricci Curbastro (di anni). Il soggetto collettivo della scienza è anonimo e collettivo, anche quando assume provvisoriamente il nome proprio di un soggetto individuale: Einstein, Freud, Lacan... Ma è lui, l’anonimo collettivo, che ci ospita, a non farci sentire isolati, quando elaboriamo le nostre congetture o traffichiamo ai nostri esperimenti terapeutici (ecco una nozione tipicamente freudiana da rilanciare!), che altri ci hanno trasmesso e che altri ancora porteranno avanti magari con più successo di noi.









Commenti
Forse che un'anticipazione della Lichtung heideggeriana possiamo trovarla nel pensiero dei sofisti? Protagora afferma che l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono e di quelle che non sono. Si può affermare che per i Sofisti lo zero fosse appunto il soggetto - o, meglio, il suo cogito immaginativo - il punto sorgivo degli enti e dei non enti ? Certo, mi si può ricordare che i greci ( e quindi anche i sofisti) non conoscevano lo zero inteso in senso moderno; ma: lo conosceva, al di là della metafora della Lichtung, Heidegger ? il quale ha fatto della "ripresa" dell'ascolto del canto delle origini greche del pensiero dell'essere un suo motivo dominante ? A favore dell'ipotesi dello "zero" sofista ricordo la posizione ambigua di Platone, nel quale l'Horror Vacui dello zero e di un infinito inferno in cui convive l'"è" e il "non é", non impedisce che l'ultimo suo dialogo ,se non ricordo male, sia proprio il Sofista. I Sofisti propugnavano una pratica intellettuale bottom-up, erano dei pragmatisti ante litteram; per loro non esisteva una cosa ideale chiamata Bene, assoluta, categorica, immutabile; a cui ci si poteva solo, ri-conoscendola, adeguarsi. Per Platone (e anche per Heidegger) ontologia significa riconoscimento, ritrovamento, e risposta adeguata, eccheggiante al/del modello ideale. Per i sofisi ontologia significa costruzione intellettuale di modelli ipotetico/operativi, di oggetti intellettuali; costruzione che viene messa di volta in volta alla prova dell'utilizzo concreto nella vita politica, economica, giuridica e culturale della Polis. L'ontologia ipotetica e mobile dei sofisti veniva messa di volta in volta alla prova del soggetto collettivo. Viceversa le idee platoniche vengono calate dall'alto sul soggetto collettivo con l'intento di dominarlo.
Aggiungerei che i sofisti non furono nichilisti. La loro intuizione oscura della zero, in Gorgia soprattutto, li tenne lontani dalla "nichilazione", un'operazione tutto sommato ancora ontologica.
Condivido con Sciacchitano la questione del pensiero libero, che si libera, o libra, al di là dei dogmi e dei gusci vuoti. Per me i gusci vuoti sono le generalizzazioni. Per esempio, la grande metafora di Edipo, come proposta da Freud, diventa un guscio vuoto quando si trasforma in un concetto che spiega la condizione umana e si trasforma in "misura di tutte le cose". Ammiro di Sciacchitano l'attaccamento alla scienza, che presuppone un metodo, nel contempo il suo metodo, per quanto mi è dato da intendere, non è semplice, è complesso. A quanto ricordo, il mio professore di statistica, un "olandese volante", mi aveva insegnato che la statistica può perfettamente essere antiscientifica, la statistica, diceva, non è un metodo, è una tecnica. Ci insegnò, per esempio, che ci sono due procedure per una tecnica inferenziale detta "analisi fattoriale". Lui ci spiegava come con la tecnica esplorativa si può dimostrare tutto e il suo contrario, perché i nomi dei fattori che escono, dopo la procedura matematica, li dà il ricercatore. Mentre l'analisi fattoriale confermativa costringe il ricercatore a formulare un'ipotesi antecedente alla procedura, che poi si conferma, appunto, o smentisce. La scienza funziona per congetture e confutazioni. Ma questo professore, che era un po' folle, per spiegarci, ad esempio, le matrici di correlazione, si soffermava ore sulla meraviglia dei numeri complessi o immaginari, era incantato dalla genialità della scoperta delle soluzioni di x al quadrato più 1 uguale 0, la radice quadrata di meno 1 (non trovo i simboli matematici). Qui scienza e immaginario si incontrano. Mi pare che queste creazioni matematiche, somiglino un po' alle anti-narrative: gli aforismi di Nietzsche, l'opera di Joyce o di Musil, i "Sei personaggi" di Pirandello. Allora, potremmo dire che la scienza normale contiene una scienza anti-normale, così come la narrativa contiene un'anti-narrativa? Ricoeur in "Tempo e racconto" parla della schiavitù del personaggio nella narrazione, Musil, Joyce e gli altri menzionati avevano cercato la via della liberazione del personaggio dalla narrazione. Pirandello, a proposito dei "Sei personaggi", disse che aveva cercato di trasformare i personaggi in persone, ma la trama narrativa si sfalda, la storia rallenta, fino a farci passare la vita a leggere ciò che accadde a Leopold Bloom, Stephen Daedalus e Molly Bloom il giorno 16 giugno del 1904. La freccia è ferma.
Rileggendo oggi il commento di Barbetta mi colpisce con la forza di un ceffone l'esordio: "Condivido con Sciacchitano la questione del pensiero libero, che si libera o libra, al di là dei dogmi e dei gusci vuoti."... bello davvero. E sorge una domanda che mi pongo: il pensiero che si libera o libra al di là dei dogmi non dovrebbe essere anche liberante ?
Altrimenti detto: che fine ha fatto la promessa della "liberazione" ? che fine hanno fatto le questioni della ragione e della libertà, agitate soprattutto negli anni '60 e '70, prima del cosidetto ripiegamento edonistico-consumistico iniziato negli '80? Come posso pensare un pensiero libero che non sia anche liberante ? Sono difficoltà mie personali o sono invece ancora problemi pubblici-collettivi rimasti lì, sotto la cenere (a Venezia direbbero "Bronze coerte") o come appesi nell'aria frenetica eppure immobile di questi anni ?
La psicanalisi che ho conosciuto negli anni '70 conteneva a mio avviso una promessa intellettual-politica, appunto di liberazione. Che ne è stato, cosa ne hanno fatto, per esempio, gli psicanalisti che avvertivano più o meno chiaramente questa promessa? A questa promessa sono stati dedicati tutti gli strumenti intellettuali (e morali) necessari a tentarne un percorso condiviso di esplorazione, se non di adempimento ?
Sono queste questioni, solo mie personali, di un presente solo mio, rimasto incagliato nelle promesse non mantenute di un passato? Il mio è solo un problema "biografico" (difficoltà del soggetto) o è anche un problema (difficolta di struttura collettiva...della "società") "pubblico" ?
Buono il riferimento a Fachinelli. La freccia è ferma ma il tempo non è quello senza misura dell'ossessivo, magistralmente riproposto da Elvio. Optare per la sincronia significa dare un diverso significato alla diacronia. Da tempo del divenire la diacronia diventa tempo del sapere. Con la sincronia si transita dall'ontologia all'epistemologia.
Però scusami Antonello, ma forse c'e qualcosa che mi sfugge. Accetto pienamente il tuo invito a "continuare a pensare senza citare a ogni piè sospinto o questo o quello", ma nel formulare questo invito e dargli forza noto che in venticinque righe hai citato, nell'ordine: Nietzsche, Francis Bacon, Cartesio, Spinoza, Einstein, Poincaré, Hilbert, Riemann, Levi Civita, Ricci Curbastro, (di nuovo) Einstein, Freud e finanche Lacan. Allo stesso modo, citando, ha continuato Barbetta pur dichiarandosi d'accordo con te. Evidentemente la pulsione a citare nel nostro campo -quello del Soggetto, mi pare- è così forte che si cita anche quando si invita a procedere senza citare questo o quello. E infatti forse l'unico modo per esprimere un pensiero proprio al riparo dal furor citandi è quello di riallacciarsi alla propria clinica e di darne testimonianza.. Così, tanto per riprendere il tuo invito, e non certo per polemizzare. Anche perché sarei davvero contento di confrontarmi con te, con Barbetta e anche con altri attraverso le rispettive cliniche e non attraverso i riferimenti agli Autori che abbiamo studiato, e continuiamo a studiare e a... citare.
Concedimi un minimo di paradossalità, Egidio. Gli autori esistono; sono catalizzatori o catalizzatori del pensiero, come tento di chiamarli spiritosamente; per metterli da parte occorre chiamarli per nome e dire che ne abbiamo abbastanza di loro. Trovo utile il riferimento di Barbetta alle retoriche non narrative da Nietzsche a Joyce via Musil, la tecnica aforistica del primo e il romanzo-saggio dell'ultimo. Quanto alla clinica il riferimento a Lacan è significativo. Dopo il caso Aimée della sua tesi di psichiatria, Lacan non ha più narrato casi clinici, pur continuando la consuetudine psichiatrica della presentazione di casi. Appunto, presentazione, cioè evento del tempo presente, che interroga il passato, sospendendo la narrazione. Le stesse sedute brevi sono state da Lacan escogitate, oltre che per far fronte all'esorbitante domanda d'analisi, anche per "tagliare" il filo narrativo del paziente e avvicinare l'operazione analitica alla fulminazione del Witz, che è tutto tranne che racconto. Ma la teoria psicanalitica del Witz non può, ovviamente, prescindere da Freud. E' il Witz – che in tedesco nell’espressione "der Witz der Sache" significa anche “il cuore della cosa” o "das Bedeutende," “il significativo” – a trasformare il paziente in analizzante da semplice autobiografo in cui lo cala la psicanalisi secondo Freud. Insomma, è il Witz che fa deragliare l'analisi e la sposta su un altro binario, a destinazione spesso sorprendente e inattesa. E per questo evento non c’è tecnica o professionalità che possa determinarlo in base a schematismi a priori.
Mi azzardo a soffermarmi su un punto che mi piacerebbe discutere. "Il soggetto collettivo della scienza è anonimo e collettivo, anche quando assume provvisoriamente il nome proprio di un soggetto individuale". Vorrei proporre questa idea: quando un soggetto collettivo assume il nome di un soggetto individuale e l’atteggiamento di “rigida osservanza” alle sue teorie va molto al di là dell’ ortodossia in un gruppo di terapeuti, si produce per enantiodromia l'incarnazione della propria nemesi: un individuo che emerge provvisoriamente dalla massa anonima dei pazienti, la cui costellazione archetipica è più vulnerabile ad essere inflazionata dalla polarità opposta (ombra) rispetto ai costrutti della "teoria principale".
Una volta un'analista, che doveva presentare un mio libro, mi chiese come prima cosa, per presentarci, a quale gruppo "appartenessi". Il moderatore, che mi conosceva un po' meglio e che soprattutto conosceva il testo, la guardò un po' imbarazzato (era un altro psicoterapeuta), mentre io lo anticipavo rispondendo che non appartenevo a nessuno e che non mi piacevano affatto le "parrocchie" (gelo tra di noi).
Ecco, io credo che non tanto il citare, quanto il parlare con un certo lessico predefinito (freudiano, lacaniano ecc) con gli altri o della realtà, sia indice di una sclerotizzazione dell'identità individuale su certi cardini teorici e clinici, un processo che è una conseguenza quasi inevitabile, a mio avviso, di un percorso formativo lungo e rigido come quello psicoanalitico tradizionale. Questo irrigidimento, che si può pensare anche come ad una nascita di una pseudoidentità analitica, è rinforzato ulteriormente dal fatto che essere un analista/psicoterapeuta "ortodosso" permette di entrare e rimanere più facilmente in certi "giri": invio di pazienti, agganci istituzionali, clientelismo: soldi insomma. E il denaro, che ha a che fare direttamente con la sopravvivenza individuale, materiale e sociale (riconoscimento collettivo, prestigio), è il movente più forte che io conosca nell'influenzare il pensiero e le azioni degli uomini.
L'irrigidimento identitario professionale ha a che fare con la sopravvivenza, è un aggrapparsi del singolo all'Istituzione che egli ritiene gli potrà garantire una certa sicurezza esistenziale.
Proprio così. Siamo tutti molto infantili. Abbiamo bisogno di certezze, cioè che il papà ci tenga per mano. Dov’è l’Io autonomo, che cammina con le sue gambe e pensa con la sua testa? In fondo, la tanto vituperata attività scientifica (perché venduta agli interessi del capitale e del profitto) non è altro che pensare con la propria testa in risposta alle proposte del collettivo. La scienza promuove la cooperazione, non la dipendenza. Ma di scienza in psicanalisi ne vedo poca. Sarà per l’enantiodromia di cui parla Lanzaro. Ciò non toglie che gli psicanalisti restino asserviti al discorso del padrone nella misura in cui si prodigano a conformare i soggetti, che entrano in psicoterapia, alle prescrizioni della vita civile. Di sovversione soggettiva ne vedo poca emergere dal movimento psicanalitico, che ormai si muove poco.
Proprio così: se gli psicanalisti restano asserviti al discorso del padrone (la psicoterapia come "cura" conformizzante del soggetto) non fanno....psicanalisi. La psicanalisi "scioglie" l'anima in quanto tale e la libera dai suo legami, la psicoterapia si limita a "curarla" Lo so è desolante ma lampante. Se c'è conformizzazione del soggetto alle ideologie del vivere civile, non solo non c'è sovversione soggettiva, ma neanche libertà intellettuale, intesa come gestione razionale (e quindi scientifica) dell'incertezza: insomma non c'è analisi. Se papà ci tiene per mano è per rassicurarci (poverino: sicuramente lui ha più paura del bimbo di cui tiene la mano), per darci certezze che controbilancino le incertezze epistemiche che il solo esistere continuamente procura. Papà, quasi sempre, non è uno scienziato, e se anche lo fosse, quando fa il papà, smette di esserlo e con la scusa di proteggerci si rassicuracon pseudocertezze: diventa un ideo-ontologo (vedasi la "Filosofia spontanea degli scienziati" di Althusser). Ecco, la psicanalisi (non la psicoterapia) dovrebbe condurre ad una riforma intellettuale del soggetto individuale che gli consenta di aprirsi al soggetto collettivo. Farci scorgere, gettandoci a nuotare nel mare delle incertezze e abbandonando la mano paterna, un metodo per la gestione delle incertezze che sia fallibilista (quindi scientifico), sempre pronto ad autoconfutarsi, o a farsi confutare dagli altri.
Bye Bye Daddy.