Fare i conti con l’inorganico (Recensione a “La tentazione dello spazio”)
31 luglio, 2018 - 13:43
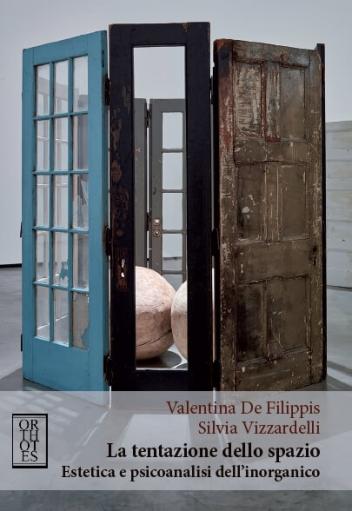
Editore: Orthotes
Anno: 2018
Pagine:
Costo: €18.00
Il climax tragico di Rushmore (1998), film culto del regista americano Wes Anderson, viene senza dubbio raggiunto quando Rosemary, la giovane insegnante del prestigioso college Rushmore, spazientita dagli istrionici tentativi di Max di conquistarla, perde la pazienza e, dopo avergli ribadito con gelida concisione che tra loro non ci sarà mai nulla che vada oltre l’amicizia, lo mette con le spalle al muro chiedendogli: “cosa credevi? Che avremmo forse fatto sesso?”. Dinnanzi a queste parole, Max accusa il colpo e indietreggia inorridito. A prima vista, si direbbe che gli sceneggiatori abbiano voluto enfatizzare l’importanza di questo snodo narrativo ricorrendo al meccanismo convenzionale della disillusione: lo scenario di amore platonico eretto da Max viene brutalmente tirato giù, rivelando la cruda verità che, per quanto lui possa amare Rosemary, è profondamente irrealistico che tra loro potrà mai esserci una storia. La natura traumatica della disillusione consiste nello svelamento dell’illogicità della credenza di Max. Le dure parole di Rosemary infatti diradano le cortine immaginarie e ripristinano la durezza nichilistica della norma simbolica: al posto dell’utopistico e fantasioso delirio pansessuale dei cliché hollywoodiani (della serie “al cuor non si comanda” o “l’amore non ha età”), subentrano le inaggirabili leggi dei legami di parentela, al posto dello slancio maniacale di un desiderio che non conosce compromessi si riafferma l’intransigente proibizione della Cosa-Rosemary. Insomma, il cosiddetto trauma da disillusione corrisponderebbe al simulacro narrativo dell’amore impossibile. Per rimarcare questa logica da copione low-cost, un esempio paradigmatico ci viene offerto da I love Lisa (1993)[i]: è il giorno di San Valentino e Lisa, per placare la solitudine di Ralph, decide di recapitare anche a lui una lettera d’amore. L’imbroglio della sinossi si basa su di una pantomima del fraintendimento ferencziano de La confusione delle lingue: alla domanda di affetto di Lisa, Ralph risponde con una richiesta di (in questo caso asessuato) amore. O meglio, mentre l’atto di Lisa era puramente simbolico – la lettera non aveva valore in sé, come effettivo pegno d’amore, ma si voleva come semplice segnale amichevole -, Ralph interpreta il gesto in maniera performativa – vede nella consegna della lettera una sincera dichiarazione d’amore. Nel momento in cui Lisa, oppressa dalle melense romanticherie di Ralph perde le staffe e gli urla in faccia tutta la verità (per di più in diretta televisiva, come dinnanzi ad un grande Altro che possa validare simbolicamente le sue parole, in modo da renderle non ulteriormente fraintendibili) la fantasia si sgretola e la sua polverizzazione induce il break-down traumatico che Bart si diverte a riprodurre sadicamente in slow-motion.[ii] Eppure, dovendo soppesare i nostri riferimenti interpretativi, non è corretto dire che l’escamotage della disillusione agisca tramite lo smembramento della fantasia “fondamentale” del soggetto (il centro attrattivo attorno a cui si struttura il suo desiderio). Piuttosto, essa trae il proprio funzionamento dalla natura alienante del linguaggio. A nutrire il potenziale traumatico del “momento della verità” sarebbe sì il cedimento dello schermo fantasmatico, la rivelazione della realtà brutale e scevra da compromessi di sorta, ma il suo principale carburante, il meccanismo di accumulo che produce il contraccolpo, è fornito dal linguaggio e dal suo costitutivo fraintendimento immaginario. Come sottolinea Chiesa[iii], linguaggio e significazione, seppur strettamente correlati, non coincidono mai perfettamente tra loro, questo per due motivi principali:
- anzitutto perché l’articolazione del desiderio in parole costituisce un progetto sempre fallimentare: per quanto sopraffina possa essere la mia dimestichezza espressiva, la traduzione del desiderio in domanda, la sua messa in parole, non potrà che lasciar cadere un resto negativo, un caput mortuum inespresso che rimane preso fuori dall’articolazione della domanda che rivolgo all’Altro
- in secondo luogo, sebbene le mie parole da un lato non riescano a catturare esaustivamente il mio desiderio, dall’altro esse dicono sempre più di quanto vogliano dire: l’altra faccia della declinazione del desiderio in domanda, in pari tempo, produce sempre anche un resto positivo, un surplus eccedente il mio messaggio.
È l’intreccio di queste due impasse ad intessere le maglie del muro del linguaggio, quella barriera che impedisce al soggetto di poter interagire con l’Altro secondo le convenzionali regole dell’intersoggettività habermasiana. L’errore di qualunque rilancio dell’intersoggettivismo convenzionale, secondo cui l’altro soggetto è il partner del mio dialogo, un doppio fenomenologico in grado di condividere con me l’esperienza dell’interazione linguistica, consiste proprio nella scotomizzazione di questa sovrapposizione strutturale tra, rispettivamente, due carenze (punto 1) e due eccedenze (punto 2), errore che la psicoanalisi lacaniana ovvia ponendo l’indecifrabilità ultima del desiderio come preliminare monadico a qualunque intersoggettività.
Tornando al meccanismo della disillusione, il potenziale di straripazione traumatica corrisponderebbe allora all’accumulo esponenziale di questi intoppi della comunicazione. Tale tesi produce una notevole risonanza con la formula lacaniana del “soggetto che riceve il proprio messaggio dall’Altro in forma invertita”. Difatti, con Rushmore, ci ritroviamo in una situazione paradossale: le parole di Rosemary non sono traumatiche perché rivelano a Max, sit venia verbo, che lei non lo ama, ma perché gli annunciano che è lui stesso in realtà a non amare lei. Le sue affilate parole, lacanianamente parlando, è questo che dicono: “sei un illuso, ma non perché hai frainteso l’affetto che provo per te, scambiandolo per amore, ma perché hai la sfacciataggine di spacciare quel marasma di sentimenti confusi ed incoerenti per vero amore.” A riguardo, il Lacan dialettico dei primi Seminari ribalterebbe l’interpretazione della scena e direbbe che non è Rosemary a spezzare il cuore di Max, ma il contrario, come a dire: “tu mi ferisci, perché osi vendermi questa tua insulsa cotta adolescenziale per vero amore.”
Ma, da una differente prospettiva, la portata tragica della scena è destabilizzante per un altro motivo, radicalmente opposto al precedente. Il meccanismo della disillusione, se portato alle sue estreme conseguenze, rivela il fondo decisamente paranoide, autoriferito dell’alienazione immaginaria prodotta dal linguaggio: il messaggio traumatico, abbiamo detto, da “non è lei che non mi ama” si trasforma in “sono io che non la amo.” In tal caso, Max cadrebbe nel tranello di avere a che fare con la realtà, mentre invece è immerso nel daydreaming, nel sogno ad occhi aperti della fantasia. La caduta di questo sipario è allora traumatica nella misura in cui rivela non solo la faccia feroce della bruta realtà, ma anche il doppio fondo di un desiderio che è al di là di me, più di me. Per cogliere l’altra prospettiva invece dobbiamo concentrarci sulla nozione strettamente psicoanalitica dell’Immaginario.
Una corretta analisi del potenziale strutturante dell’Immaginario deve evitare di ridurre questo registro alla classica funzione di velo, alla fantasia che offusca l’orrore quotidiano. Innanzitutto, come puntualizza Žižek, la funzione immaginaria non si limita unicamente a soddisfare il desiderio in modo allucinatorio (attraverso il daydreaming e la fantasticheria) ma, letteralmente, ci insegna come desiderare: “l’immaginario fa da mediatore tra la struttura formale simbolica e la concretezza degli oggetti che incontriamo nella realtà.”[iv] Ma su quale base, è a questo punto lecito chiedersi, l’Immaginario eserciterebbe la sua funzione pedagogica? Rispetto a cosa creerebbe la nostra cornice desiderante? Questo punto mette in risalto la natura (lacanianamente) intersoggettiva dell’Immaginario e, con esso, del fantasma. Infatti, la formazione fantasmatica è da intendersi, alla lettera, come “una risposta all’enigma del ‘Che vuoi?’”[v], un tentativo di colmare la propria mancanza assumendo come desiderio ciò che manca all’Altro. La funzione del fantasma, in sintesi, è quella di dirmi chi sono/devo essere per gli altri e, su questa base, chi o cosa desiderare.
Eppure, se come detto poco fa il desiderio dell’Altro non può che darmisi nella sua impenetrabilità, allora non varrà più la formula hegelo-kojeviana del desiderio (che si umanizza) come desiderio dell’Altro - con tutte le ambiguità che il genitivo comporta. Non sarà più sufficiente che io desideri il desiderio altrui, perché questa ragnatela intersoggettiva, nella logica del fantasma, è rimossa, impenetrabile: è necessario che sia io stesso a farmi oggetto del desiderio dell’Altro e, di conseguenza, che strutturi il mio fantasma (immaginario) secondo il suo desiderio. Questo excursus ci riporta a Rushmore e ad una distinzione fondamentale che ora possiamo avanzare tra due diversi tipi di dissoluzione dello schermo fantasmatico:
Tornando al meccanismo della disillusione, il potenziale di straripazione traumatica corrisponderebbe allora all’accumulo esponenziale di questi intoppi della comunicazione. Tale tesi produce una notevole risonanza con la formula lacaniana del “soggetto che riceve il proprio messaggio dall’Altro in forma invertita”. Difatti, con Rushmore, ci ritroviamo in una situazione paradossale: le parole di Rosemary non sono traumatiche perché rivelano a Max, sit venia verbo, che lei non lo ama, ma perché gli annunciano che è lui stesso in realtà a non amare lei. Le sue affilate parole, lacanianamente parlando, è questo che dicono: “sei un illuso, ma non perché hai frainteso l’affetto che provo per te, scambiandolo per amore, ma perché hai la sfacciataggine di spacciare quel marasma di sentimenti confusi ed incoerenti per vero amore.” A riguardo, il Lacan dialettico dei primi Seminari ribalterebbe l’interpretazione della scena e direbbe che non è Rosemary a spezzare il cuore di Max, ma il contrario, come a dire: “tu mi ferisci, perché osi vendermi questa tua insulsa cotta adolescenziale per vero amore.”
Ma, da una differente prospettiva, la portata tragica della scena è destabilizzante per un altro motivo, radicalmente opposto al precedente. Il meccanismo della disillusione, se portato alle sue estreme conseguenze, rivela il fondo decisamente paranoide, autoriferito dell’alienazione immaginaria prodotta dal linguaggio: il messaggio traumatico, abbiamo detto, da “non è lei che non mi ama” si trasforma in “sono io che non la amo.” In tal caso, Max cadrebbe nel tranello di avere a che fare con la realtà, mentre invece è immerso nel daydreaming, nel sogno ad occhi aperti della fantasia. La caduta di questo sipario è allora traumatica nella misura in cui rivela non solo la faccia feroce della bruta realtà, ma anche il doppio fondo di un desiderio che è al di là di me, più di me. Per cogliere l’altra prospettiva invece dobbiamo concentrarci sulla nozione strettamente psicoanalitica dell’Immaginario.
Una corretta analisi del potenziale strutturante dell’Immaginario deve evitare di ridurre questo registro alla classica funzione di velo, alla fantasia che offusca l’orrore quotidiano. Innanzitutto, come puntualizza Žižek, la funzione immaginaria non si limita unicamente a soddisfare il desiderio in modo allucinatorio (attraverso il daydreaming e la fantasticheria) ma, letteralmente, ci insegna come desiderare: “l’immaginario fa da mediatore tra la struttura formale simbolica e la concretezza degli oggetti che incontriamo nella realtà.”[iv] Ma su quale base, è a questo punto lecito chiedersi, l’Immaginario eserciterebbe la sua funzione pedagogica? Rispetto a cosa creerebbe la nostra cornice desiderante? Questo punto mette in risalto la natura (lacanianamente) intersoggettiva dell’Immaginario e, con esso, del fantasma. Infatti, la formazione fantasmatica è da intendersi, alla lettera, come “una risposta all’enigma del ‘Che vuoi?’”[v], un tentativo di colmare la propria mancanza assumendo come desiderio ciò che manca all’Altro. La funzione del fantasma, in sintesi, è quella di dirmi chi sono/devo essere per gli altri e, su questa base, chi o cosa desiderare.
Eppure, se come detto poco fa il desiderio dell’Altro non può che darmisi nella sua impenetrabilità, allora non varrà più la formula hegelo-kojeviana del desiderio (che si umanizza) come desiderio dell’Altro - con tutte le ambiguità che il genitivo comporta. Non sarà più sufficiente che io desideri il desiderio altrui, perché questa ragnatela intersoggettiva, nella logica del fantasma, è rimossa, impenetrabile: è necessario che sia io stesso a farmi oggetto del desiderio dell’Altro e, di conseguenza, che strutturi il mio fantasma (immaginario) secondo il suo desiderio. Questo excursus ci riporta a Rushmore e ad una distinzione fondamentale che ora possiamo avanzare tra due diversi tipi di dissoluzione dello schermo fantasmatico:
- nel primo caso, che corrisponde all’esempio della disillusione stricto sensu, abbiamo lo squarcio dello scenario immaginario e, ad essere traumatica, è l’emersione dirompente del (mio desiderio come) Reale;
- il secondo caso, che mi accingo ora ad illustrare, è ascrivibile non tanto ad una vera e propria dissoluzione, quanto all’esplicitazione del carattere soggettivo dello schermo fantasmatico, il suo apparirci come soggettivamente oggettivo.
Se prima abbiamo detto che, psicoanaliticamente parlando, è errato ridurre l’Immaginario al velo che copre in modo allucinatorio l’orrore del Reale, è ora necessario specificare che esso, allo stesso tempo, “ha la pretesa di nascondere il proprio punto di riferimento ‘rimosso’”.[vi] L’allusione delle parole di Rosemary, in questo secondo caso, anziché puntare alla ri-significazione retroattiva indotta dalla caduta del velo (la disillusione), sono da recepire scevre da ogni storicizzazione, nella loro ingombrante immediatezza. “Credevi veramente che avremmo fatto sesso?” punta dritto ad un (altro) nocciolo aforistico lacaniano: quello del “non c’è rapporto sessuale”. Se nella prima analisi a fare problema era l’ambiguità del messaggio, la cui pletora polisemica ha contribuito alla composizione della fantasia, qui a suscitare angoscia è l’inesorabile coincidenza tra l’enunciato e l’enunciazione. Ad essere traumatica non è l’irruzione del Reale, ma l’esplicitazione del supporto intrinseco che sorregge il fantasma. Come spiega Lacan infatti, affinché sia operativo, il fantasma deve rimanere implicito: tra esso e il tessuto simbolico deve essere mantenuta una distanza di sicurezza, un gap strutturale che impedisca al primo di collassare sul secondo: “l’Immaginario stesso è una bugia primordiale, uno schermo che maschera l’impossibilità fondamentale”.[vii] Nel caso del giovane Max, ciò corrisponde alla realizzazione dell’idea fantasmatica che il suo amore per Rosemary, il massimo compimento della trascendenza amorosa, non possa che culminare nella volgare brutalità dell’atto sessuale. La differenza è cruciale: il soggetto non fugge dalla fantasia per ripararsi dalle soverchianti minacce del Reale (nonostante alcuni segnali tradiscano una certa reciproca intimità, vi è una chiara impossibilità relazionale, una sorta di blocco edipico, che sussiste tra i due a causa dell’età) ma, al contrario, si rifugia nel Reale dopo che la fantasia, rendendo esplicito il proprio supporto intrinseco, si fa insostenibile (se Rosemary ricambiasse il suo amore, allora sarebbero costretti a contaminare la sacralità di questo sentimento con del disgustoso, tremendo sesso). Il nodo tragico di Rushmore consiste nell’esplicitazione della distanza che separa il nucleo fantasmatico dell’essere del soggetto dalle sue identificazioni superficiali. Questa coincidenza stridente tra la realtà oggettiva noumenica (come le cose sono veramente, al di là dello schermo edulcorante fantasmatico) e la sembianza soggettiva (come credo che le cose mi appaiano) è inammissibile (nel senso kantiano del termine, come superamento dello schematismo trascendentale e fronteggiamento della Cosa in sé senza schermi protettivi) perché ad essere traumatico, e questo è il punto fondamentale della discussione, non è lo svelamento delle cose per come sono realmente, ma per come esse mi appaiono veramente, cioè nella loro sembianza reale. La Cosa allora non corrisponde all’entità positiva e concreta la cui vista mi rende inerme, ma all’inaccessibilità reale delle mie più intime e soggettive fantasie. Anzi, si potrebbe dire che sia proprio questa inaccessibilità la conditio sine qua non dell’inconscio freudiano.
Quando si rimprovera al soggetto cartesiano di essere l’epitome dell’antropocentrismo è proprio questo punto che si manca clamorosamente: il decentramento cartesiano non fa riferimento all’incapacità di cogliere le cose nella loro incontaminata oggettività, ma ad una non-coincidenza ancor più fondamentale, che mi priva delle mie più intime esperienze soggettive. Che non possa assumere il supporto intrinseco della mia cornice fantasmatica vuole dire, in ultima istanza, che non posso mai esperire (oggettivamente) la mia esperienza (soggettiva), che il clamore della soggettività (intesa come l’esperienza organica del sentirmi padrone delle mie rappresentazioni), centrale nell’antropocentrismo, non è altro che la deviazione da un fondo inorganico inammissibile ed inassimilabile. Ma del resto, non è forse l’attraversamento del fantasma stesso, l’ideale di fine analisi, una presa di posizione dinnanzi al vuoto evento decorativo attorno a cui si struttura l’esperienza fantasmatica? E soprattutto, considerate le note impasse della definizione di “fine analisi”, esiste un modo alternativo per aprirsi a questa esperienza di sospensione dei sembianti?
A tal proposito, vi è un’ampia e variegata letteratura che prende in considerazione le vicissitudini dell’interminabilità dell’analisi come impossibilità di venire definitivamente a patti con la nostra costitutiva inaccessibilità. Per quanto mi riguarda, nel finale di Aporie del senso[viii], ho dimostrato come la tensione intrinseca al termine “fine analisi” sia tutt’altro che risolta, mentre in …Eppur sublimo[ix], con il ricorso a Pasolini, ho messo in evidenza come la mancanza-ad-essere, la fessura ontologica che definisce il cosiddetto soggetto della pulsione, possa essere temporaneamente sorretta attraverso la reciproca sovrapposizione di due sublimazioni (anziché due mancanze). Oggi, porto avanti questi due discorsi approcciandoli da una prospettiva differente ma, per certi versi, a loro complementare. Svilupperò la discussione attraverso una mia personale lettura di La tentazione dello spazio (Orthotes, 2016, 174 pp.), di Valentina De Filippis e Silvia Vizzardelli. Il punto di partenza degli autori è che l’esperienza estetica mainstream ci abbia abituato a calibrare le nostre facoltà empiriche all’insegna dell’espressività soggettiva e del vitalismo incondizionato, della vita che afferma se stessa imponendosi sulla natura come lo specchio dell’interiorità. Secondo il senso comune infatti, l’opera d’arte ci chiama ad una partecipazione sensibile di pienezza totale, ad un coinvolgimento attivo che ripudia l’immobilità e celebra l’estasi fascinosa di un trasporto ipertrofico. Un pervasivo organicismo (estremizzato, se non quasi parodiato, dalla strumentalizzazione quasi-mistica delle esperienze di arousal descritte dal neurocognitivismo) ha finito, a poco a poco, per monopolizzare qualsiasi riferimento antropologico, imponendo alla filosofia accademica uno scomodo aut-aut: o l’estetica o l’inorganico. Il programma degli autori prevede di restituire all’inorganico una dignità in primo luogo storica (da Worringer a Lacan, passando per Sabina Spielrein e Freud) e concettuale (dalla spinta inerziale alla pulsione di morte) e, in seconda e non per nulla trascurabile istanza, una veste critica nonché, a mio avviso, in parte etico-politca (il collasso inorganico come scegliere di non scegliere).
Ma in cosa consiste esattamente questo programma? E quali sono i suoi assunti di base? Il sedicente “impulso di vita, di animazione, di appropriazione spirituale e dinamica del mondo” ha imposto la propria doxa spiritual-animista occludendo la tendenza inerziale e regressiva insita nel fondo della soggettività umana. Ad una prima impressione, potrebbe sembrare che la spinta al ritorno alla materia non sia altro che il ribaltamento geometrico della sfera vitale in quella del mortifero. Detto altrimenti, è sufficiente cambiare di segno Eros e ottenere Thanatos per uscire dal vitalismo e poter finalmente dire di avere a che fare con l’inorganico? La giusta (ma onerosa) misura per non cadere nel tranello di una mera conversione di segno, come se tra i due registri sussistesse una differenza di grado – e non di natura – deve passare per l’ammissione del soggetto come vuoto, mancanza, iato ontologico che si frappone tra “le sfere del vitale e del mortifero” come una “zona d’ombra”.[x] Le ripercussioni ontologiche del “non c’è rapporto sessuale” affrontate in apertura ci permettono ora di stilare un programma preliminare a qualsiasi formalizzazione dell’inorganico: l’assioma lacaniano infatti, denotando la natura ontologicamente non-tutta del Reale (la nostra incapacità di coglierlo come un Tutto) giustifica la stessa nozione di soggetto come vuoto, interruzione mai pienamente esaurita dal rimando di un significante ad un altro significante. Insomma, il preambolo che stringe la sessualità all’ontologia non rappresenta altro che l’antagonismo reale che inaugura la soggettività come doppia implicazione di questo rapporto:
Quando si rimprovera al soggetto cartesiano di essere l’epitome dell’antropocentrismo è proprio questo punto che si manca clamorosamente: il decentramento cartesiano non fa riferimento all’incapacità di cogliere le cose nella loro incontaminata oggettività, ma ad una non-coincidenza ancor più fondamentale, che mi priva delle mie più intime esperienze soggettive. Che non possa assumere il supporto intrinseco della mia cornice fantasmatica vuole dire, in ultima istanza, che non posso mai esperire (oggettivamente) la mia esperienza (soggettiva), che il clamore della soggettività (intesa come l’esperienza organica del sentirmi padrone delle mie rappresentazioni), centrale nell’antropocentrismo, non è altro che la deviazione da un fondo inorganico inammissibile ed inassimilabile. Ma del resto, non è forse l’attraversamento del fantasma stesso, l’ideale di fine analisi, una presa di posizione dinnanzi al vuoto evento decorativo attorno a cui si struttura l’esperienza fantasmatica? E soprattutto, considerate le note impasse della definizione di “fine analisi”, esiste un modo alternativo per aprirsi a questa esperienza di sospensione dei sembianti?
A tal proposito, vi è un’ampia e variegata letteratura che prende in considerazione le vicissitudini dell’interminabilità dell’analisi come impossibilità di venire definitivamente a patti con la nostra costitutiva inaccessibilità. Per quanto mi riguarda, nel finale di Aporie del senso[viii], ho dimostrato come la tensione intrinseca al termine “fine analisi” sia tutt’altro che risolta, mentre in …Eppur sublimo[ix], con il ricorso a Pasolini, ho messo in evidenza come la mancanza-ad-essere, la fessura ontologica che definisce il cosiddetto soggetto della pulsione, possa essere temporaneamente sorretta attraverso la reciproca sovrapposizione di due sublimazioni (anziché due mancanze). Oggi, porto avanti questi due discorsi approcciandoli da una prospettiva differente ma, per certi versi, a loro complementare. Svilupperò la discussione attraverso una mia personale lettura di La tentazione dello spazio (Orthotes, 2016, 174 pp.), di Valentina De Filippis e Silvia Vizzardelli. Il punto di partenza degli autori è che l’esperienza estetica mainstream ci abbia abituato a calibrare le nostre facoltà empiriche all’insegna dell’espressività soggettiva e del vitalismo incondizionato, della vita che afferma se stessa imponendosi sulla natura come lo specchio dell’interiorità. Secondo il senso comune infatti, l’opera d’arte ci chiama ad una partecipazione sensibile di pienezza totale, ad un coinvolgimento attivo che ripudia l’immobilità e celebra l’estasi fascinosa di un trasporto ipertrofico. Un pervasivo organicismo (estremizzato, se non quasi parodiato, dalla strumentalizzazione quasi-mistica delle esperienze di arousal descritte dal neurocognitivismo) ha finito, a poco a poco, per monopolizzare qualsiasi riferimento antropologico, imponendo alla filosofia accademica uno scomodo aut-aut: o l’estetica o l’inorganico. Il programma degli autori prevede di restituire all’inorganico una dignità in primo luogo storica (da Worringer a Lacan, passando per Sabina Spielrein e Freud) e concettuale (dalla spinta inerziale alla pulsione di morte) e, in seconda e non per nulla trascurabile istanza, una veste critica nonché, a mio avviso, in parte etico-politca (il collasso inorganico come scegliere di non scegliere).
Ma in cosa consiste esattamente questo programma? E quali sono i suoi assunti di base? Il sedicente “impulso di vita, di animazione, di appropriazione spirituale e dinamica del mondo” ha imposto la propria doxa spiritual-animista occludendo la tendenza inerziale e regressiva insita nel fondo della soggettività umana. Ad una prima impressione, potrebbe sembrare che la spinta al ritorno alla materia non sia altro che il ribaltamento geometrico della sfera vitale in quella del mortifero. Detto altrimenti, è sufficiente cambiare di segno Eros e ottenere Thanatos per uscire dal vitalismo e poter finalmente dire di avere a che fare con l’inorganico? La giusta (ma onerosa) misura per non cadere nel tranello di una mera conversione di segno, come se tra i due registri sussistesse una differenza di grado – e non di natura – deve passare per l’ammissione del soggetto come vuoto, mancanza, iato ontologico che si frappone tra “le sfere del vitale e del mortifero” come una “zona d’ombra”.[x] Le ripercussioni ontologiche del “non c’è rapporto sessuale” affrontate in apertura ci permettono ora di stilare un programma preliminare a qualsiasi formalizzazione dell’inorganico: l’assioma lacaniano infatti, denotando la natura ontologicamente non-tutta del Reale (la nostra incapacità di coglierlo come un Tutto) giustifica la stessa nozione di soggetto come vuoto, interruzione mai pienamente esaurita dal rimando di un significante ad un altro significante. Insomma, il preambolo che stringe la sessualità all’ontologia non rappresenta altro che l’antagonismo reale che inaugura la soggettività come doppia implicazione di questo rapporto:
- da un lato, possiamo cogliere il soggetto come vuoto, mancanza-ad-essere, solo postulando questo antagonismo originario
- dall’altro, abbiamo bisogno del ricorso alla nozione di soggetto per non ridurre questa opposizione a mera immanenza sessuata, biologica (e dunque organica).
Ritengo tale preambolo fondamentale per non fraintendere la complessa prospettiva aperta dagli autori: la (ri)adozione dell’inorganico infatti (che Vizzardelli, come vedremo tra poco, porterà ad ulteriore sviluppo delineando la nozione di imminenza), abbandonando le teorie umaniste della soggettività e postulando un soggetto come zona d’ombra, non predica un ritorno al decostruttivismo, il quale vedrebbe il soggetto alla stregua di una fumosa evanescenza[xi], ma richiede l’attiva assunzione di tale mancanza che, non essendo mai definitivamente conseguita, apre la strada ad una vera e propria etica della responsabilità.[xii]
I prolegomeni di un’esperienza estetica così definita discostano quest’ultima in primo luogo dalle teorie che incardinano il proprio programma fenomenologico in una specie di dinamicità assoluta dell’organico (ascrivibili alla “vitalizzazione” dell’oggetto da parte del soggetto creativo), ma anche – per continuare a respingere ogni rischio di ridurre l’opposizione in oggetto al binarismo vitale-antivitale - all’esperienza dell’estatico inteso come intensificazione spirituale, dispersione oceanica del soggetto (la cui esasperazione arriva a coincidere con l’iper-naturalismo panteistico e le esperienze di comunione totale col proprio Umwelt: si pensi, ad esempio, agli happening di Yoko Ono come fuga dall’opera, anziché abbandono saturante in essa. La terza via aperta dagli autori (parlo di “terza via” perché il loro merito di riportare l’inorganico su di un binario che non deragli nelle suddette logiche oppositive va esplicitamente riconosciuto) prevede piuttosto un vero e proprio “risucchio” verso l’oggetto che trovi la propria causa formale nel soggetto stesso, “una pulsione di morte che porta l’uomo a voler uscire fuori di sé”[xiii] senza consegnarlo alle conseguenze irreparabili della rovina e della decadenza. Un esempio letterario di (fallita) emancipazione dell’inorganico altamente rappresentativo è certamente quello di Artaud, uno straordinario precursore del “non c’è rapporto sessuale”. Come scrive Lorenzo Chiesa nella sua monografia sul controverso drammaturgo francese, l’intera opera di Artaud può essere riletta come la denuncia della storia della sessualità (in quanto) organica. Il corpo sessuato organicamente, sostiene Artaud, costituisce una chiusura paradossale perché, anziché significare apertura e prossimità (secondo non solo la connotazione biologista, ma anche quella platonica), imprigiona il corpo in una “casa di carne chiusa”[xiv] (tesi non lontana dal Deleuze che De Filippis rievoca nel capitolo sesto: “l’organismo non è la vita, bensì la imprigiona”, e di seguito “il corpo è interamente vivo, e tuttavia non organico”[xv]). L’organicità è astrazione, ricerca di una vacillante stabilità metafisica, mentre è l’inorganico ad aprire il corpo. È importante qui notare come l’opposizione tra il corpo gerarchicamente ordinato, ben strutturato dell’Anti-Edipo e quello liscio e senza organi, “al di là dell’organismo”[xvi] sia inscindibile da quella dell’astrazione organica e dell’anarchia de-individuata dell’inorganico di Artaud. Secondo quest’ultimo infatti, l’organicità è una pseudologia (ideologica) fondata sulla rimozione dell’inorganico originario e sulla concretizzazione del fallocentrismo come suo sembiante. La sessualità organica è castrazione, rigido conformismo che presuppone la divisione a partire da “un tutto originariamente unito”.[xvii] A riguardo, la castrazione, che dovrebbe agire come negazione del fallicismo, si rivela essere un suo meccanismo intrinseco e, anziché operare contro di essa, finisce per fungere da suo principale promotore: “la sessualità organica è castrazione (…), una sindrome conformistico-erotomane”.[xviii] Infatti, lungi dal costituire un’armonizzazione sintetica tra i due sessi, la castrazione fallirebbe il suo (fittizio) scopo – rivelando così la sua logica cortocircuitante – nella misura in cui “(ri)trovando la donna, con lo stesso atto, perde l’uomo.”[xix] Similmente alla logica del non-tutto del significante fallico, l’indice della castrazione non è il razionale che mette i due sessi direttamente in relazione, ma l’immagine ultima del loro non-rapporto, della loro relazione disgiuntiva.[xx]
Poiché la sessualità come organicità è anzitutto l’epitome della separazione uomo-donna, il programma anarchico di Artaud prevede l’abolizione del conformismo organico mediante la riappropriazione di una verginità (androgina) mai perduta ma sempre da riguadagnare mediante la castrazione della castrazione: “verginità che quindi non si perda ma si conquista durante una lotta antierotomane da non interrompere mai”.[xxi]
Riassumendo, i punti salienti della paradossale filosofia pratica artaudiana sono almeno tre:
I prolegomeni di un’esperienza estetica così definita discostano quest’ultima in primo luogo dalle teorie che incardinano il proprio programma fenomenologico in una specie di dinamicità assoluta dell’organico (ascrivibili alla “vitalizzazione” dell’oggetto da parte del soggetto creativo), ma anche – per continuare a respingere ogni rischio di ridurre l’opposizione in oggetto al binarismo vitale-antivitale - all’esperienza dell’estatico inteso come intensificazione spirituale, dispersione oceanica del soggetto (la cui esasperazione arriva a coincidere con l’iper-naturalismo panteistico e le esperienze di comunione totale col proprio Umwelt: si pensi, ad esempio, agli happening di Yoko Ono come fuga dall’opera, anziché abbandono saturante in essa. La terza via aperta dagli autori (parlo di “terza via” perché il loro merito di riportare l’inorganico su di un binario che non deragli nelle suddette logiche oppositive va esplicitamente riconosciuto) prevede piuttosto un vero e proprio “risucchio” verso l’oggetto che trovi la propria causa formale nel soggetto stesso, “una pulsione di morte che porta l’uomo a voler uscire fuori di sé”[xiii] senza consegnarlo alle conseguenze irreparabili della rovina e della decadenza. Un esempio letterario di (fallita) emancipazione dell’inorganico altamente rappresentativo è certamente quello di Artaud, uno straordinario precursore del “non c’è rapporto sessuale”. Come scrive Lorenzo Chiesa nella sua monografia sul controverso drammaturgo francese, l’intera opera di Artaud può essere riletta come la denuncia della storia della sessualità (in quanto) organica. Il corpo sessuato organicamente, sostiene Artaud, costituisce una chiusura paradossale perché, anziché significare apertura e prossimità (secondo non solo la connotazione biologista, ma anche quella platonica), imprigiona il corpo in una “casa di carne chiusa”[xiv] (tesi non lontana dal Deleuze che De Filippis rievoca nel capitolo sesto: “l’organismo non è la vita, bensì la imprigiona”, e di seguito “il corpo è interamente vivo, e tuttavia non organico”[xv]). L’organicità è astrazione, ricerca di una vacillante stabilità metafisica, mentre è l’inorganico ad aprire il corpo. È importante qui notare come l’opposizione tra il corpo gerarchicamente ordinato, ben strutturato dell’Anti-Edipo e quello liscio e senza organi, “al di là dell’organismo”[xvi] sia inscindibile da quella dell’astrazione organica e dell’anarchia de-individuata dell’inorganico di Artaud. Secondo quest’ultimo infatti, l’organicità è una pseudologia (ideologica) fondata sulla rimozione dell’inorganico originario e sulla concretizzazione del fallocentrismo come suo sembiante. La sessualità organica è castrazione, rigido conformismo che presuppone la divisione a partire da “un tutto originariamente unito”.[xvii] A riguardo, la castrazione, che dovrebbe agire come negazione del fallicismo, si rivela essere un suo meccanismo intrinseco e, anziché operare contro di essa, finisce per fungere da suo principale promotore: “la sessualità organica è castrazione (…), una sindrome conformistico-erotomane”.[xviii] Infatti, lungi dal costituire un’armonizzazione sintetica tra i due sessi, la castrazione fallirebbe il suo (fittizio) scopo – rivelando così la sua logica cortocircuitante – nella misura in cui “(ri)trovando la donna, con lo stesso atto, perde l’uomo.”[xix] Similmente alla logica del non-tutto del significante fallico, l’indice della castrazione non è il razionale che mette i due sessi direttamente in relazione, ma l’immagine ultima del loro non-rapporto, della loro relazione disgiuntiva.[xx]
Poiché la sessualità come organicità è anzitutto l’epitome della separazione uomo-donna, il programma anarchico di Artaud prevede l’abolizione del conformismo organico mediante la riappropriazione di una verginità (androgina) mai perduta ma sempre da riguadagnare mediante la castrazione della castrazione: “verginità che quindi non si perda ma si conquista durante una lotta antierotomane da non interrompere mai”.[xxi]
Riassumendo, i punti salienti della paradossale filosofia pratica artaudiana sono almeno tre:
- l’attiva promozione di un godimento virtuale e sviscerato dalle zavorre conservative delle moderne politiche di desessualizzazione ideologica, dalla cyber-sessualità ai movimenti emancipativi androgini
- In secondo luogo, avanzando l’assunzione di una nuova ed autentica verginità che non riduca la sessualità al taglio anatomico della Legge della castrazione (Edipo compreso), né ad una pratica di fede attiva (secondo il modello fideistico pascaliano, per cui la nostra essenza verrebbe risignificata dai nostri atteggiamenti e credenze superficiali), la proposta di un nuovo sbocco all’insufficiente antagonismo tra l’essenzialismo e il culturalismo nella battaglia per soggettivazione della propria identità sessuale, mossa che apre alla nozione di scelta e quindi di soggettivazione
- in ultimo, pone la riaffermazione dell’inorganico come processo interminabile, che deve essere attivamente sostenuto.
Eppure, l’errore di Artaud, motivo probabilmente per cui la sua operazione anarchica è rimasta intrappolata nella decadente rovina dell’internamento manicomiale, non è stato tanto quello di avanzare una proposta del tutto irrazionale ma ritengo, viceversa, di non essere andato abbastanza infondo: considerando la sessualità tout court un prodotto unicamente meta-strutturale degli “strangolanti” vincoli socio-simbolici, un althusseriano apparato ideologico di stato (che vedrebbero nel binomio cromosomiale xx e xy l’ipostasi della materialità ideologica - “sono i genitori a reprimere la sessualità organica, ma è questa che essi creano dal nulla per definirsi in quanto tali, per definire il soggetto”[xxii]) il drammaturgo francese non ha colto il potere sovversivo di quest’ultima, il suo fondo inorganico essenziale quanto irriducibile. In poche parole, il limite di Artaud sarebbe stato nella grossolana riduzione della sessualità ad un sotto-prodotto della Legge (“l’incesto c’è soltanto se si vuole vederlo da una prospettiva organica”[xxiii]), errore che l’ha intrappolato nello stesso dispositivo ideologico che si prefiggeva di demolire. Questo breve excursus ci svela come qualunque approccio all’inorganico che voglia scotomizzare la dimensione pulsionale dell’esperienza sia destinato a naufragare nella pura speculazione o, come puntualizzano Vizzardelli e De Filippis: “l’inorganico lo si può frequentare all’interno di una teoria dell’esperienza, anzi a rigore pensiamo che solo nell’ambito di una concezione pulsionale (…) l’esperienza possa gestire la sua feconda combutta con la durezza delle materie.”[xxiv] Non colpisce, a questo punto, che uno dei capitoli più densi del libro sia proprio quello dedicato alla psicotraumatologia. Effettivamente, chi più del trauma può rendere l’idea di “un’improvvisa e spaventosa penetrazione” dell’inorganico nel tessuto rappresentativo organico, di “un impianto o intromissione non metabolizzabile” che rimane incagliato nella matrice di senso del mio esperire quotidiano?[xxv]
Due sono gli elementi di massimo interesse che si evincono dall’analisi del trauma compiuta dagli autori:
Due sono gli elementi di massimo interesse che si evincono dall’analisi del trauma compiuta dagli autori:
- esso rappresenta senza dubbio il principale cristallo di resistenza a qualunque tentativo del vitalismo di barricare l’esperienza dell’inorganico nel senso o in una teoria rappresentazionale (“per molto tempo ci è sembrato che l’estetico avesse a che fare con la soggettività, con l’espressività, con l’erompere della vita nelle sue forme più espansive, e ora lo osserviamo invece dalla parte di una strana attrazione per l’inerzia e per la durezza della materia”[xxvi]);
- la fondamentale non coincidenza del nocciolo traumatico con se stesso, la sua distanza intrinseca dal proprio concetto, costringe ad adottare nei suoi confronti una prospettiva capace di cogliere l’inorganico a partire da balzi ed opportunità.
Il trauma infatti si presenta immediatamente come un’entità paradossale, il non simbolizzabile per antonomasia, ma non nel ridondante senso che esso è il reale che sfugge alla rappresentazione, il non elaborabile che contamina abusivamente i miei vissuti. Volendo prendere a prestito i termini di Quentin Meillassoux, il trauma è allo stesso tempo quella fantomatica X che agisce da esterno radicale ed interno claustrale. Esso costituisce un esterno radicale perché è l’elemento opaco e inavvicinabile che si sottrae ad ogni mio tentativo di elaborazione, ma è anche un nocciolo interno claustrale perché questa scaglia aliena, incistata nelle profondità del mio essere, è ciò che distorce invasivamente ogni mia esperienza. Je t’aime, je t’aime (1968) è forse il film che descrive al meglio la doppia natura dell’indigeribilità del trauma. Il film ha inizio con Claude Ridder, il protagonista, che tenta il suicidio. Fallito il tentativo, poiché dimostra di non avere nulla da perdere, viene assoldato da alcuni scienziati che, per testare un esperimento sinora riuscito solo sulle cavie, lo mandano indietro nel tempo. Purtroppo però il meccanismo si inceppa e Claude si ritrova inghiottito in un loop temporale che lo trascina avanti e indietro nei suoi ricordi per pochissimi secondi alla volta. Vista la situazione, approfitta del malfunzionamento per tentare di ritornare al momento che ha decretato il suo tentativo di suicidio (da come suggerisce il film, il presunto omicidio della sua fidanzata), ma non vi riesce. Pur essendo in grado di far ritorno a molti altri ricordi, quella X gli è vicinissima quanto asintotica. Dall’ossessivo zig-zag del film, notiamo come il trauma non si limiti a costituire un centro di shut-down dell’esperienza cosciente, un collasso della memoria nel punto che ha subito la massima effrazione dell’evento, ma lavori attivamente affinché la rimozione della fantomatica X ritorni in una miriade di impressioni, di piccole x non simbolizzate che, oltre a contaminare il mio qui ed ora, riscrivono irrazionalmente ogni mio lì e allora. Insomma, il trauma di Claude Ridder è ad un tempo il punto insondabile/irraggiungibile della sua esperienza e, contemporaneamente, il centro di distorsione di ogni suo altro ricordo (quest’ultimo punto viene rimarcato dal fatto che, quando verso la fine del film i tentativi di Claude diventano più ostinati, i suoi ricordi cominciano ad intersecarsi tra loro: più mi avvicino al trauma, più la sua distorsione è violenta). Je t’aime, je t’aime ci mostra come l’arte possa far valere la propria prossimità all’esperienza traumatica solo nella misura in cui si astiene dalla sua rappresentazione e si impegna a fornirne una “testimonianza”: “non perché la [possa] sintomaticamente raccontare, ma perché la sua stessa natura [gli è] affine.”[xxvii] Insomma, la natura costitutivamente aliena del trauma fa sì che, come annuncia la celebre chiusura del Tractatus di Wittgenstein, esso non possa essere detto (rappresentato o simbolizzato), ma solo dimostrato. Ovvero, l’evidenza del soggetto traumatizzato non risiede tanto nella sua capacità di raccontare con vividezza il proprio evento traumatico ma, al contrario, nella sua impossibilità di proferirne parola. Con il trauma ci troviamo dinnanzi ad un ulteriore paradosso: più appare chiaro il messaggio proferito dal soggetto dell’enunciato (il contenuto delle mie dichiarazioni, ciò che effettivamente dico), maggiormente appare sfumata l’attendibilità dell’enunciazione e, viceversa, maggiormente l’enunciato è poroso, inconsistente, più l’enunciazione sarà (ahimé) attendibile. Come scrive Vizzardelli: “l’immaginario dell’esperienza del trauma sarà tanto più prossimo alla sensibilità traumatica quanto più rinuncerà alla logica della rappresentazione.”[xxviii] In un certo senso, se ammettiamo che “nell’esperienza artistica [autentica] la vita fa un passo indietro e collassa fino ad arrivare al suo punto d’inizio”[xxix] – assunto contrario ad ogni cliché che vede l’arte come mimesi, riproduzione dell’impulso vitale – , possiamo anche dire (per quanto l’affermazione possa sembrare controversa) che il trauma costituisca la quintessenza della mineralizzazione dell’esperienza e, di conseguenza, un triste ma potentissimo esempio della complessa estetica dell’inorganico, della “potenza dei materiali espressivi [da esso] utilizzati”.[xxx]
Ciascuna teoria inerziale dell’immagine quindi si fonda sull’isolamento di un eccesso di non-vita, ma affinché questa fissazione minerale possa essere esperita, essa deve radicare tale cuore opaco nel fondo pulsionale di una sostanza vivente, elastica, marcata dalla negatività, perché “persino parlando di non-vita non si riesce a balzar fuori dall’esperienza.”[xxxi]
Le teorie vitaliste traggono la propria ragion d’essere da un fraintendimento metodologico: l’impudente sostituzione della fluidificazione vitale al senso. O meglio, ciò che imbeve di vita l’oggetto non è l’impulso vitalistico, ma quello ermeneutico/epistemofilico che tenta di turare le falle fenomeniche con la melassa del senso. L’impasse del vitalismo consiste così nel ritenersi portatore di una fenomenologia dell’immediato, della pura intenzionalità, quando invece la sua politica è immersa nell’ermeneutica fino all’osso: in tal caso, lo pseudo-vitalismo ermeneutico sarebbe la formaldeide delle “cattive” estetiche perché, pur avanzando un programma che dall’husserliana riduzione trascendentale (e dunque sedicentemente slegata dai vincoli rappresentazionali) conduca all’estasi mistica dell’autocoinvolgimento ipertrofico, può tenere in piedi il proprio edificio teorico solo per mezzo del ricorso aprioristico al senso e all’antropomorfizzazione.
Effettivamente, saremmo tentati di chiederci, per quale motivo le filosofie della vita ripudierebbero a tal punto l’inorganico? Quale ragione si cela dietro una così strenua resistenza all’accoglimento della materia puramente inerte? Paradossalmente, la risposta non è da ricercarsi nella logica oppositiva del contrasto (l’accettazione dell’inorganico è una minaccia agli assunti basilari della filosofia della vita). Piuttosto, la verità è che l’inorganico, psicoanaliticamente parlando, lungi dall’essere un incursore esterno, spacca il discorso vitalista dall’interno: la sua economia è sostenibile solo a patto della presupposizione di un coefficiente mortifero (come inerzia della vita) sempre-già rimosso. Anzi, a voler essere più lacaniani, l’inorganico è l’oggetto a delle teorie vitaliste, l’oggetto parziale che emerge solo come perso, scarto irrecuperabile. In un suo scritto del 1988, Estasi metropolitane, Elvio Fachinelli coglie splendidamente questo punto. Cosa si intende per estasi metropolitana? Una linea che “trova o cerca di trovare una situazione estatica proprio dove meno si penserebbe di trovarla”, ovvero “nella promiscuità della folla”, nel suo “brulichio”, “nella vita stessa della situazione metropolitana.”[xxxii] Ma, analogamente, questo eccesso di vita che necessita di autoperpetuarsi ciecamente si basa su di un misunderstanding sintattico: queste dottrine fraintendono l’”a causa di” dell’inorganico con il “nonostante” e, di conseguenza, finiscono per ritenere che esse abbiano a che fare con la vita nonostante la morte, anziché a causa di essa. I miti della velocità, dello slancio, dell’accelerazione propulsiva sono “miti obbligati di un mondo affollato, semibloccato”, un rimosso che ritorna in forma negata, “quello che, con una parola sola, sintetizzerei con il termine imbottigliamento”.[xxxiii] Insomma, il freudiano tratto unario (eine ziger Zug) che sostiene l’identificazione col mito vitalista non poggia sui grandi stendardi di generatività ed espansività antropologica/organismica, ma sul diniego della materia inerziale che (proprio in quanto tocca la morte), come un elastico, rifugge nell’eccesso di vitalismo. D’altro canto, sono proprio i miti consumistico-progressisti a fornire lo scenario maniacale di una vita che, anziché generarsi dalla morte, dalla negatività pura, la censura, ne fa il suo stesso fondamento denegato. Volendo ora formulare quanto ho sinora solo accennato senza formularlo esplicitamente: la filosofia della vita, propinando lo slancio vitale come principio ontologico trascendentale (e non come una concreta formazione sociale) si rivela uno pseudo-concetto (un concetto latente, che si manifesta solo attraverso la critica)[xxxiv] al servizio di una macchina puramente ideologica, un simulacro che trova il proprio sostegno soltanto nel riferimento (rimosso) all’elemento inorganico.
Tornando alle precedenti glosse del fantasma immaginario, potremmo riformulare questo discorso così: affinché il vitalismo sia operativo, occorre che il suo supporto inorganico intrinseco rimanga implicito. Se da un lato quest’ultimo punto ci svela il volto inautentico dell’esperienza estetica, dall’altro ci sprona a ricercarne il rovescio autentico. Questa considerazione ci obbliga a passare per un riesame del concetto di bellezza.
Nonostante il libro affronti l’argomento con ammirevole perizia, credo che il discorso aperto da Vizzardelli sulla bellezza trovi la sua perfetta chiusura solo in un suo saggio recente (Immanenza/imminenza: una “i” ci libera dall’uno[xxxv]). Questo excursus ci permette di chiederci in maniera critica: fino a che punto è oggi possibile preservare il discorso rilkiano-lacaniano della bellezza come ultimo velo prima dell’orrendo? Ma soprattutto, è possibile ridefinire un approccio che non riduca la bellezza ad una funzione valvolare, di transito dal concetto alla sua caduta, ma che invece riesca a dare di quest’ultima una formalizzazione frontale? L’introduzione della nozione di imminenza, a mio avviso, ci permette di uscire dalle impasse che il concetto di bellezza chiama in causa nel quinto capitolo de La tentazione dello spazio. Cosa cambia tra i due scritti?
Ritengo che la prima formulazione filo-lacaniana della bellezza estetica soffra di una forzatura teoretica (che però non credo sia da intendere come blocco, falla dell’impianto filosofico dell’autore, ma al contrario come momento logico di transizione da una rivalutazione del pensiero lacaniano ad una sua diretta critica): l’esperienza della bellezza è per Vizzardelli, in sintesi
Ciascuna teoria inerziale dell’immagine quindi si fonda sull’isolamento di un eccesso di non-vita, ma affinché questa fissazione minerale possa essere esperita, essa deve radicare tale cuore opaco nel fondo pulsionale di una sostanza vivente, elastica, marcata dalla negatività, perché “persino parlando di non-vita non si riesce a balzar fuori dall’esperienza.”[xxxi]
Le teorie vitaliste traggono la propria ragion d’essere da un fraintendimento metodologico: l’impudente sostituzione della fluidificazione vitale al senso. O meglio, ciò che imbeve di vita l’oggetto non è l’impulso vitalistico, ma quello ermeneutico/epistemofilico che tenta di turare le falle fenomeniche con la melassa del senso. L’impasse del vitalismo consiste così nel ritenersi portatore di una fenomenologia dell’immediato, della pura intenzionalità, quando invece la sua politica è immersa nell’ermeneutica fino all’osso: in tal caso, lo pseudo-vitalismo ermeneutico sarebbe la formaldeide delle “cattive” estetiche perché, pur avanzando un programma che dall’husserliana riduzione trascendentale (e dunque sedicentemente slegata dai vincoli rappresentazionali) conduca all’estasi mistica dell’autocoinvolgimento ipertrofico, può tenere in piedi il proprio edificio teorico solo per mezzo del ricorso aprioristico al senso e all’antropomorfizzazione.
Effettivamente, saremmo tentati di chiederci, per quale motivo le filosofie della vita ripudierebbero a tal punto l’inorganico? Quale ragione si cela dietro una così strenua resistenza all’accoglimento della materia puramente inerte? Paradossalmente, la risposta non è da ricercarsi nella logica oppositiva del contrasto (l’accettazione dell’inorganico è una minaccia agli assunti basilari della filosofia della vita). Piuttosto, la verità è che l’inorganico, psicoanaliticamente parlando, lungi dall’essere un incursore esterno, spacca il discorso vitalista dall’interno: la sua economia è sostenibile solo a patto della presupposizione di un coefficiente mortifero (come inerzia della vita) sempre-già rimosso. Anzi, a voler essere più lacaniani, l’inorganico è l’oggetto a delle teorie vitaliste, l’oggetto parziale che emerge solo come perso, scarto irrecuperabile. In un suo scritto del 1988, Estasi metropolitane, Elvio Fachinelli coglie splendidamente questo punto. Cosa si intende per estasi metropolitana? Una linea che “trova o cerca di trovare una situazione estatica proprio dove meno si penserebbe di trovarla”, ovvero “nella promiscuità della folla”, nel suo “brulichio”, “nella vita stessa della situazione metropolitana.”[xxxii] Ma, analogamente, questo eccesso di vita che necessita di autoperpetuarsi ciecamente si basa su di un misunderstanding sintattico: queste dottrine fraintendono l’”a causa di” dell’inorganico con il “nonostante” e, di conseguenza, finiscono per ritenere che esse abbiano a che fare con la vita nonostante la morte, anziché a causa di essa. I miti della velocità, dello slancio, dell’accelerazione propulsiva sono “miti obbligati di un mondo affollato, semibloccato”, un rimosso che ritorna in forma negata, “quello che, con una parola sola, sintetizzerei con il termine imbottigliamento”.[xxxiii] Insomma, il freudiano tratto unario (eine ziger Zug) che sostiene l’identificazione col mito vitalista non poggia sui grandi stendardi di generatività ed espansività antropologica/organismica, ma sul diniego della materia inerziale che (proprio in quanto tocca la morte), come un elastico, rifugge nell’eccesso di vitalismo. D’altro canto, sono proprio i miti consumistico-progressisti a fornire lo scenario maniacale di una vita che, anziché generarsi dalla morte, dalla negatività pura, la censura, ne fa il suo stesso fondamento denegato. Volendo ora formulare quanto ho sinora solo accennato senza formularlo esplicitamente: la filosofia della vita, propinando lo slancio vitale come principio ontologico trascendentale (e non come una concreta formazione sociale) si rivela uno pseudo-concetto (un concetto latente, che si manifesta solo attraverso la critica)[xxxiv] al servizio di una macchina puramente ideologica, un simulacro che trova il proprio sostegno soltanto nel riferimento (rimosso) all’elemento inorganico.
Tornando alle precedenti glosse del fantasma immaginario, potremmo riformulare questo discorso così: affinché il vitalismo sia operativo, occorre che il suo supporto inorganico intrinseco rimanga implicito. Se da un lato quest’ultimo punto ci svela il volto inautentico dell’esperienza estetica, dall’altro ci sprona a ricercarne il rovescio autentico. Questa considerazione ci obbliga a passare per un riesame del concetto di bellezza.
Nonostante il libro affronti l’argomento con ammirevole perizia, credo che il discorso aperto da Vizzardelli sulla bellezza trovi la sua perfetta chiusura solo in un suo saggio recente (Immanenza/imminenza: una “i” ci libera dall’uno[xxxv]). Questo excursus ci permette di chiederci in maniera critica: fino a che punto è oggi possibile preservare il discorso rilkiano-lacaniano della bellezza come ultimo velo prima dell’orrendo? Ma soprattutto, è possibile ridefinire un approccio che non riduca la bellezza ad una funzione valvolare, di transito dal concetto alla sua caduta, ma che invece riesca a dare di quest’ultima una formalizzazione frontale? L’introduzione della nozione di imminenza, a mio avviso, ci permette di uscire dalle impasse che il concetto di bellezza chiama in causa nel quinto capitolo de La tentazione dello spazio. Cosa cambia tra i due scritti?
Ritengo che la prima formulazione filo-lacaniana della bellezza estetica soffra di una forzatura teoretica (che però non credo sia da intendere come blocco, falla dell’impianto filosofico dell’autore, ma al contrario come momento logico di transizione da una rivalutazione del pensiero lacaniano ad una sua diretta critica): l’esperienza della bellezza è per Vizzardelli, in sintesi
- sia l’indugiare sul bordo tra l’organico e l’inorganico, “il luogo in cui una mancanza si traduce in mancamento”[xxxvi], o altresì il “non rimuovere il risucchio della pulsione di morte”[xxxvii], la frequentazione della soglia che preannuncia l’esperienza della caduta
- sia la caduta stessa, “la dimensione che si incontra al fondo di un’esperienza collassante”[xxxviii]
La nozione di imminenza ci permette invece di reintegrare questa sincronicità assoluta tra la caduta e la sua anticipazione nella “necessità dell’inorganico inscritto nel nostro corpo”, e ci mostra al contempo lo stacco anticipatorio della caduta e il suo “a venire” come possibilità di “riuscita”. Solo nello spazio di tale sincronia, a mio avviso, è ora possibile reintegrare la bellezza lacaniana come oltraggio “oltrepassamento di una linea, varco di un confine”.[xxxix]
Per rinforzare quanto sto qui dicendo, può esserci utile fare riferimento all’ultimo scritto di Benvenuto (La bellezza e l’orrore)[xl], in cui l’autore, denunciando grossomodo la stessa colonizzazione dell’organico ai danni dell’inorganico (Benvenuto parla di una tendenza ad “estend[ere] agli oggetti artificiali criteri di valutazione biologici”[xli], Vizzardelli fa riferimento all’inorganico come al tema del “grande rimosso”[xlii]), avanza una tesi simile. Giocando sui capovolgimenti polisemici del latino horror (che si estende dal “diventar ispido al “timor sacro”, e dunque dall’”orribile, spaventoso” al “mirabile, bellissimo”[xliii]), il programma di Benvenuto consiste nel “riport[are] l’esperienza della bellezza a qualcosa che chiameremo orrore”.[xliv] Ma questa operazione, se da un lato necessiterà di una chiarificazione del concetto di orrore, dall’altro avrà bisogno – soprattutto – di una rivalutazione della bellezza estetica. Suscitare il sentimento (apparentemente ossimorico) della bellezza orrorifica è per Benvenuto far risaltare l’incommensurabilità “tra la rappresentazione da una parte e l’evento o cosa horrenda dall’altra”.[xlv] Questo perché, così come la filosofia della vita tende a valorizzare l’impulso vitale sbarazzandosi dell’inorganico, così “l’arte volgare ha la pretesa di liberarci definitivamente dal reale risolvendolo nella rappresentazione”.[xlvi] Anche per Benvenuto insomma la colonizzazione ipertrofica del senso, la cattura inautentica del reale ad opera della significazione a tutti i costi, strozza l’esperienza estetica, che è invece fruizione dell’(anticipazione dell’)incommensurabile. Ma se la scrupolosità rappresentativa - che Benvenuto riconduce in primis alle “cattive” applicazioni delle matematizzazioni neoplatoniche - è il trionfo dell’arte volgare, questo vuole allora dire che il godimento estetico è un’esperienza obbligatoriamente ohne Begriff (senza concetto)? Prendere per vero questo punto corrisponderebbe precisamente all’errore di Artaud. Come commenta più avanti nel saggio l’autore “l’incommensurabilità (…) è una non-intelligibilità nel cuore dell’intelligibile che risulta evidente solo all’intelligibilità”.[xlvii] Sarebbe a dire che anche la più pura e autentica esperienza di “orrore estetico” è costretta a passare entro i cardini della rappresentazione, perché è proprio questo dislivello, tale “differenza sconvolgente” ad aprire l’orizzonte di “un piacere indescrivibile”. A sostegno della sua accattivante tesi, l’autore cita la Flagellazione di Piero della Francesca, e si chiede se la scrupolosità matematica che sorregge l’intelaiatura del dipinto non sia, anziché “un modo per distoglierci dall’oggetto patetico”, “un modo per farci accedere diversamente all’orrore rappresentato”.[xlviii] Infatti, è proprio lo scrupoloso codice di rappresentazione matematica che, anziché soffocare, sprigiona la cifra perturbante del quadro. La rappresentazione della Flagellazione allora ci trasmetterebbe il messaggio inverso a quello dell’arte volgare: mentre la seconda ci dice che è possibile riportare l’evento nel registro rappresentativo per trarne un godimento sereno e pacificante (e dunque un falso godimento), la seconda ci verrebbe a dire “non credere che te la caverai beandoti di una magnifica e bella rappresentazione dell’Orrore!”.[xlix] La bellezza autentica non è più l’impatto diretto con l’ordine e l’armonia geometrica, ma la spirale che conduce verso un resto inorganico inassimilabile. Nel caso di Rushmore, è come se la volgare cotta di Max fosse stata scossa, con le parole di Rosemary, dall’emersione scabra e sconvolgente dell’incommensurabilità del rapporto sessuale con qualsiasi rappresentazione edulcorata di esso. Tornando a Vizzardelli, l’imminenza fungerebbe allora da apertura all’avvenire dell’inorganico, la spirale che, per mezzo della pulsione di morte, attraversa la bellezza (limite rappresentativo che è al tempo stesso annunciazione e cancellazione dell’estasi estetica) come quella differenza sconvolgente che ribalta “l’essere sul punto di” della fessura nella caduta atemporale e aconcettuale dell’esperienza dell’inesorabile. È per questo che l’autore, ritengo, possa dire che “avere dimestichezza con l’imminenza significa saperci fare con l’inorganico”.[l] Ma mentre per Vizzardelli al soggetto è concesso “collassare” nella fessura, per Benvenuto l’orizzonte del piacere indescrivibile rimane sempre in un al di là noumenico irraggiungibile e la bellezza orrorifica vale come allusione.
Per Vizzardelli e De Filippis, è esattamente nel punto di collasso, a livello di una perdita precipitante che il soggetto, sospendendo le proprie identificazioni immaginarie ed uscendo dalla logica del sembiante, tappa il vuoto della struttura evanescente del fantasma con la sua stessa caduta, “si presenta là dove pensavamo ci fosse una mancanza”.[li] Alla luce di queste conclusioni, mi permetto di riformulare (lacanianamente) la teoria inerziale dell’immagine in questo modo: il lasciarsi cadere in quanto non solamente sottrazione dall’identificazione rappresentativa (e quindi immaginaria), ma anche vera e propria sospensione del suo supporto (simbolico), coincide con l’interruzione stessa della cornice fantasmatica. La sospensione dello schermo fantasmatico è un concetto problematico, perché la nostra relazione diretta col Reale senza le soglie pacificatrici del fantasma può essere colta solo retroattivamente (si veda il Seminario XI, in particolare le lezioni su alienazione e separazione): da come mi sembra, l’ipotesi d Vizzardelli e De Filippis sarebbe volta ad aprire una dimensione di mediazione diretta che si prolunghi al di là dello schermo fantasmatico – senza dover rilanciare quest’ultimo attraverso un continuo processo di retroazione. In quale modo ciò sarebbe possibile? Perché la fessura ontologica lasciata aperta dal (temporaneo) sollevamento del fantasma viene turata dalla caduta del soggetto stesso. Ovvero, l’esperienza del collasso si distinguerebbe da quella dell’attraversamento analitico del fantasma perché:
Per rinforzare quanto sto qui dicendo, può esserci utile fare riferimento all’ultimo scritto di Benvenuto (La bellezza e l’orrore)[xl], in cui l’autore, denunciando grossomodo la stessa colonizzazione dell’organico ai danni dell’inorganico (Benvenuto parla di una tendenza ad “estend[ere] agli oggetti artificiali criteri di valutazione biologici”[xli], Vizzardelli fa riferimento all’inorganico come al tema del “grande rimosso”[xlii]), avanza una tesi simile. Giocando sui capovolgimenti polisemici del latino horror (che si estende dal “diventar ispido al “timor sacro”, e dunque dall’”orribile, spaventoso” al “mirabile, bellissimo”[xliii]), il programma di Benvenuto consiste nel “riport[are] l’esperienza della bellezza a qualcosa che chiameremo orrore”.[xliv] Ma questa operazione, se da un lato necessiterà di una chiarificazione del concetto di orrore, dall’altro avrà bisogno – soprattutto – di una rivalutazione della bellezza estetica. Suscitare il sentimento (apparentemente ossimorico) della bellezza orrorifica è per Benvenuto far risaltare l’incommensurabilità “tra la rappresentazione da una parte e l’evento o cosa horrenda dall’altra”.[xlv] Questo perché, così come la filosofia della vita tende a valorizzare l’impulso vitale sbarazzandosi dell’inorganico, così “l’arte volgare ha la pretesa di liberarci definitivamente dal reale risolvendolo nella rappresentazione”.[xlvi] Anche per Benvenuto insomma la colonizzazione ipertrofica del senso, la cattura inautentica del reale ad opera della significazione a tutti i costi, strozza l’esperienza estetica, che è invece fruizione dell’(anticipazione dell’)incommensurabile. Ma se la scrupolosità rappresentativa - che Benvenuto riconduce in primis alle “cattive” applicazioni delle matematizzazioni neoplatoniche - è il trionfo dell’arte volgare, questo vuole allora dire che il godimento estetico è un’esperienza obbligatoriamente ohne Begriff (senza concetto)? Prendere per vero questo punto corrisponderebbe precisamente all’errore di Artaud. Come commenta più avanti nel saggio l’autore “l’incommensurabilità (…) è una non-intelligibilità nel cuore dell’intelligibile che risulta evidente solo all’intelligibilità”.[xlvii] Sarebbe a dire che anche la più pura e autentica esperienza di “orrore estetico” è costretta a passare entro i cardini della rappresentazione, perché è proprio questo dislivello, tale “differenza sconvolgente” ad aprire l’orizzonte di “un piacere indescrivibile”. A sostegno della sua accattivante tesi, l’autore cita la Flagellazione di Piero della Francesca, e si chiede se la scrupolosità matematica che sorregge l’intelaiatura del dipinto non sia, anziché “un modo per distoglierci dall’oggetto patetico”, “un modo per farci accedere diversamente all’orrore rappresentato”.[xlviii] Infatti, è proprio lo scrupoloso codice di rappresentazione matematica che, anziché soffocare, sprigiona la cifra perturbante del quadro. La rappresentazione della Flagellazione allora ci trasmetterebbe il messaggio inverso a quello dell’arte volgare: mentre la seconda ci dice che è possibile riportare l’evento nel registro rappresentativo per trarne un godimento sereno e pacificante (e dunque un falso godimento), la seconda ci verrebbe a dire “non credere che te la caverai beandoti di una magnifica e bella rappresentazione dell’Orrore!”.[xlix] La bellezza autentica non è più l’impatto diretto con l’ordine e l’armonia geometrica, ma la spirale che conduce verso un resto inorganico inassimilabile. Nel caso di Rushmore, è come se la volgare cotta di Max fosse stata scossa, con le parole di Rosemary, dall’emersione scabra e sconvolgente dell’incommensurabilità del rapporto sessuale con qualsiasi rappresentazione edulcorata di esso. Tornando a Vizzardelli, l’imminenza fungerebbe allora da apertura all’avvenire dell’inorganico, la spirale che, per mezzo della pulsione di morte, attraversa la bellezza (limite rappresentativo che è al tempo stesso annunciazione e cancellazione dell’estasi estetica) come quella differenza sconvolgente che ribalta “l’essere sul punto di” della fessura nella caduta atemporale e aconcettuale dell’esperienza dell’inesorabile. È per questo che l’autore, ritengo, possa dire che “avere dimestichezza con l’imminenza significa saperci fare con l’inorganico”.[l] Ma mentre per Vizzardelli al soggetto è concesso “collassare” nella fessura, per Benvenuto l’orizzonte del piacere indescrivibile rimane sempre in un al di là noumenico irraggiungibile e la bellezza orrorifica vale come allusione.
Per Vizzardelli e De Filippis, è esattamente nel punto di collasso, a livello di una perdita precipitante che il soggetto, sospendendo le proprie identificazioni immaginarie ed uscendo dalla logica del sembiante, tappa il vuoto della struttura evanescente del fantasma con la sua stessa caduta, “si presenta là dove pensavamo ci fosse una mancanza”.[li] Alla luce di queste conclusioni, mi permetto di riformulare (lacanianamente) la teoria inerziale dell’immagine in questo modo: il lasciarsi cadere in quanto non solamente sottrazione dall’identificazione rappresentativa (e quindi immaginaria), ma anche vera e propria sospensione del suo supporto (simbolico), coincide con l’interruzione stessa della cornice fantasmatica. La sospensione dello schermo fantasmatico è un concetto problematico, perché la nostra relazione diretta col Reale senza le soglie pacificatrici del fantasma può essere colta solo retroattivamente (si veda il Seminario XI, in particolare le lezioni su alienazione e separazione): da come mi sembra, l’ipotesi d Vizzardelli e De Filippis sarebbe volta ad aprire una dimensione di mediazione diretta che si prolunghi al di là dello schermo fantasmatico – senza dover rilanciare quest’ultimo attraverso un continuo processo di retroazione. In quale modo ciò sarebbe possibile? Perché la fessura ontologica lasciata aperta dal (temporaneo) sollevamento del fantasma viene turata dalla caduta del soggetto stesso. Ovvero, l’esperienza del collasso si distinguerebbe da quella dell’attraversamento analitico del fantasma perché:
- permette la sospensione della cornice senza intraprendere un nuovo assoggettamento al Significante-Padrone
- e, di conseguenza, essendo puramente evenemenziale e sorretta dal collasso nella materia, permette di esperire questo mancamento sotto forma di temporanea auto-alienazione
O per lo meno, affinché “il mancamento o collasso inerziale” illustrato nel capitolo quinto possa rappresentare “l’unica risposta possibile quando sembra che non ci sia altra risposta”[lii] e non una mera destituzione soggettiva, è necessario che sia il soggetto stesso, divenendo oggetto, a chiudere la sua stessa falla di senso. In poche parole, la mia ipotesi è che quell’”oggetto-calamita (…) sufficientemente opaco e residuale”[liii] sia proprio quel soggetto che, oggettivandosi, viene a coincidere temporaneamente con a.
Ma perché, affinché questa ipotesi regga, è necessario portare sino infondo il ricorso alla pulsione di morte? Perché è la funzione slegante della pulsione di morte a permettere che “la tentazione di farsi sfondo, di sparire nello sfondo” si tramuti in un vero e proprio magnetismo per la “vertiginosa seduzione dello spazio.”[liv] Cercherò di essere più chiaro.
Possiamo rileggere le dure parole di Rosemary come un calzante esempio di analisi selvaggia: rivolgendosi in quel modo a Max, è come se Rosemary avesse stoccato un’interpretazione fatale, diritta verso il nucleo inconscio del suo “paziente” che, lungi dal dis-alienarlo dal suo significante primordiale, non ha fatto altro che confrontarlo brutalmente con l’abisso ontologico che il fantasma sarebbe deputato a velare. Il controcanto ideale di questa situazione è quello del desiderio dell’analista, quel “desiderio di ottenere la differenza assoluta”[lv] che mira sì alla dis-alienazione, ma solo allo scopo di produrre un nuovo assoggettamento ad un altro significante primordiale (è questo che intende Lacan quando dice che il fantasma “deve essere attraversato più volte”[lvi]). La terza ipotetica via che il saggio di De Filippis-Vizzardelli mi fa venire in mente è quella di uno slegamento assistito dall’oggetto che viene promosso da un’esperienza estetica talmente forte e sublime da produrre (adottando l’accento deleuziano di De Filippis) un’effimera ma sublime “manifestazione della vita pura slegata da ogni individuazione”.[lvii] Il contributo di Benvenuto, che esalta la necessità della dimensione rappresentativa per lo sprigionamento dell’incommensurabile, apre allora alla possibilità di un contatto con l’inorganico che avverrebbe prima di tutto per la via legante (attraverso il legame dell’impasto Eros-Thanatos) della rappresentazione e, solo in secondo luogo, si consacrerebbe allo sprofondamento e al collasso. Infatti, quella che Vizzardelli chiama inerzia dello slancio vitale sarebbe l’esito di uno “slancio [che tira] prima potentemente verso la vita”, ovvero verso la funzione legante di Eros come codifica della rappresentazione figurale]” per poi “come un elastico rilasciato, torna[re] indietro a uno stato di quiete”[lviii], sprofondando nello slegamento pervasivo di Thanatos, come pura deindividuazione. La tentazione dello spazio consisterebbe allora in una magnetizzazione imminente da parte dello sfondo (il farsi macchia), una convocazione talmente intensa (appunto orribile, mortifera) da aprire nell’orizzonte la fessura di una (auto)dis-alienazione. Nell’esperienza estetica del torpore, dell’inorganico come caduta vertiginosa al di là di ogni simbolizzazione, il mancamento su cui il soggetto si depone non è niente altro che la sua propria mancanza-ad-essere: difatti, è proprio la possibilità della conversione della mancanza in mancamento a rendere il soggetto lacaniano non un soggetto mancante, ma il soggetto della mancanza.
Bibliografia
Benvenuto S., La bellezza e l’orrore, in P. Pascarelli (a cura di), Orrore, Grenelle Potenza 2018, pp. 57-94.
Chiesa L., Antonin Artaud. Verso un corpo senza organi, Ombre Corte, Verona, 2002.
De Filippis V., Vizzardelli S., La tentazione dello spazio. Estetica e psicoanalisi dell’inorganico, Orthotes, Napoli-Salerno 2016.
Fachinelli E., Estasi metropolitane, in Fachinelli E., Borso D. (a cura di), Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989), Derive e Approdi, Roma 2016 pp. 230-233.
Lacan J., Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, Einaudi, Torino 2003.
Vizzardelli S., Immanenza/imminenza: una ‘i’ ci libera dall’uno, in A. Campo (a cura di), L’uno perverso, Textus, L’Aquila 2018, pp. 179-204.
Žižek S., Che cos’è l’immaginario, Il Saggiatore, Milano 2016.
Ma perché, affinché questa ipotesi regga, è necessario portare sino infondo il ricorso alla pulsione di morte? Perché è la funzione slegante della pulsione di morte a permettere che “la tentazione di farsi sfondo, di sparire nello sfondo” si tramuti in un vero e proprio magnetismo per la “vertiginosa seduzione dello spazio.”[liv] Cercherò di essere più chiaro.
Possiamo rileggere le dure parole di Rosemary come un calzante esempio di analisi selvaggia: rivolgendosi in quel modo a Max, è come se Rosemary avesse stoccato un’interpretazione fatale, diritta verso il nucleo inconscio del suo “paziente” che, lungi dal dis-alienarlo dal suo significante primordiale, non ha fatto altro che confrontarlo brutalmente con l’abisso ontologico che il fantasma sarebbe deputato a velare. Il controcanto ideale di questa situazione è quello del desiderio dell’analista, quel “desiderio di ottenere la differenza assoluta”[lv] che mira sì alla dis-alienazione, ma solo allo scopo di produrre un nuovo assoggettamento ad un altro significante primordiale (è questo che intende Lacan quando dice che il fantasma “deve essere attraversato più volte”[lvi]). La terza ipotetica via che il saggio di De Filippis-Vizzardelli mi fa venire in mente è quella di uno slegamento assistito dall’oggetto che viene promosso da un’esperienza estetica talmente forte e sublime da produrre (adottando l’accento deleuziano di De Filippis) un’effimera ma sublime “manifestazione della vita pura slegata da ogni individuazione”.[lvii] Il contributo di Benvenuto, che esalta la necessità della dimensione rappresentativa per lo sprigionamento dell’incommensurabile, apre allora alla possibilità di un contatto con l’inorganico che avverrebbe prima di tutto per la via legante (attraverso il legame dell’impasto Eros-Thanatos) della rappresentazione e, solo in secondo luogo, si consacrerebbe allo sprofondamento e al collasso. Infatti, quella che Vizzardelli chiama inerzia dello slancio vitale sarebbe l’esito di uno “slancio [che tira] prima potentemente verso la vita”, ovvero verso la funzione legante di Eros come codifica della rappresentazione figurale]” per poi “come un elastico rilasciato, torna[re] indietro a uno stato di quiete”[lviii], sprofondando nello slegamento pervasivo di Thanatos, come pura deindividuazione. La tentazione dello spazio consisterebbe allora in una magnetizzazione imminente da parte dello sfondo (il farsi macchia), una convocazione talmente intensa (appunto orribile, mortifera) da aprire nell’orizzonte la fessura di una (auto)dis-alienazione. Nell’esperienza estetica del torpore, dell’inorganico come caduta vertiginosa al di là di ogni simbolizzazione, il mancamento su cui il soggetto si depone non è niente altro che la sua propria mancanza-ad-essere: difatti, è proprio la possibilità della conversione della mancanza in mancamento a rendere il soggetto lacaniano non un soggetto mancante, ma il soggetto della mancanza.
Bibliografia
Benvenuto S., La bellezza e l’orrore, in P. Pascarelli (a cura di), Orrore, Grenelle Potenza 2018, pp. 57-94.
Chiesa L., Antonin Artaud. Verso un corpo senza organi, Ombre Corte, Verona, 2002.
De Filippis V., Vizzardelli S., La tentazione dello spazio. Estetica e psicoanalisi dell’inorganico, Orthotes, Napoli-Salerno 2016.
Fachinelli E., Estasi metropolitane, in Fachinelli E., Borso D. (a cura di), Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989), Derive e Approdi, Roma 2016 pp. 230-233.
Lacan J., Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, Einaudi, Torino 2003.
Vizzardelli S., Immanenza/imminenza: una ‘i’ ci libera dall’uno, in A. Campo (a cura di), L’uno perverso, Textus, L’Aquila 2018, pp. 179-204.
Žižek S., Che cos’è l’immaginario, Il Saggiatore, Milano 2016.
[i] Si tratta del quindicesimo episodio della quarta stagione de I Simpson.
[ii] “Guarda qui Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà”.
[iii] Cfr. L. Chiesa, Subjectivity and Otherness, MIT press, 2007, pp. 41-46.
[iv] S. Žižek (2016), p.24.
[v] Ivi, p.27.
[vi] Ivi, p.23.
[vii] Ivi, p.45.
[viii] Cfr. G.P. Cima, Aporie del senso, in www.psychiatryonline.it/node/7490.
[ix] Cfr. G.P. Cima, ...Eppur sublimo, in www.psychiatryonline.it/node/7504.
[x] De Filippis, Vizzardelli (2016), p.48. “Dobbiamo abbandonare il terreno sicuro di una soggettività sempre affermativa e vitale” (Ibidem).
[xi] Decostruzionismo e vitalismo personalista sono due modi di inquadrare la soggettività che, soprattutto dopo l’avvento della psicoanalisi francese, non possono che destare un certo sospetto, oltre che una più generale insoddisfazione epistemologica.
[xii] Come vedremo più avanti, è proprio perché il collasso nell’inorganico asseconda (anziché ostacolare) il desiderio che l’esperienza estetica liminale proposta dagli autori oltrepassa i propri limiti teoretici e si apre ad un discorso di portata più ampia.
[xiii] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), p.57.
[xiv] L. Chiesa (2001), p.28.
[xv] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), p.137.
[xvi] Ivi, p.136.
[xvii] L. Chiesa (2002), p.29.
[xviii] Ivi, p.34.
[xix] Ibidem.
[xx] È interessante notare come questo primissimo testo di Chiesa presenti già, in germe, le argomentazioni che confluiranno, quattordici anni dopo, in The not-two. Logic and God in Lacan (MIT Press, 2016).
[xxi] Ivi, p.36.
[xxii] Ivi, p.49.
[xxiii] Ivi, p.54.
[xxiv] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), pp. 5-6.
[xxv] Ivi, p.25.
[xxvi] Ivi, p.24.
[xxvii] Ivi, p. 27.
[xxviii] Ivi, p.28.
[xxix] Ivi, p.12.
[xxx] Ivi, p.27.
[xxxi] Ivi, p.7.
[xxxii] E. Fachinelli (2016), p.231.
[xxxiii] Ivi, p.233.
[xxxiv] Cfr. L. Chiesa (2002), p.16.
[xxxv] S. Vizzardelli (2018).
[xxxvi] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), p.111.
[xxxvii] Ivi, p. 106.
[xxxviii] Ivi, p.110.
[xxxix] Ivi, p.113.
[xl] S. Benvenuto (2018).
[xli] Ivi, p. 83.
[xlii] S. Vizzardelli (2018), p.180.
[xliii] S. Benvenuto (2018), p.58.
[xliv] Ivi, p.57.
[xlv] Ivi, p.85.
[xlvi] Ibidem.
[xlvii] Ivi, p.88.
[xlviii] Ivi, p.73.
[xlix] Ivi, p.76.
[l] S. Vizzardelli (2018), p.187.
[li] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), p.13.
[lii] Ivi, p.117.
[liii] Ivi, p.114.
[liv] Ivi, p.67.
[lv] J. Lacan (2003), p.271.
[lvi] Ivi, p.269.
[lvii] V. De Filippis, S. Vizzardelli (2016), p.147.
[lviii] Ivi, p.97.








