COVID-19, dal diario di uno specializzando in trincea

La mia casa è sempre la stessa.
Due stanze e pochi angoli che ormai conosco a memoria e che custodiscono le storie dimenticate di polvere e progetti scartati che si succedono incessantemente in questi giorni di quarantena. Ho un piccolo balconcino che rimane sempre chiuso.
Mi sento come in un sarcofago, mi manca l’aria.
Le sedie sono diventate una palestra domestica, il letto un rifugio alla sera e il piumone un abbraccio materno dal quale non voglio più allontanarmi al mattino.
Tutto è ingrandito e troppo vicino. Mi sento come in un assedio e io con le spalle al muro e i pugni chiusi. Mentre ceno, in silenzio, leggo le parole che trovo scritte sulle confezioni dei dolci e della pasta fatta in casa. Esse diventano il mio romanzo, la mia intima tragedia in questi giorni di disperata solitudine. Mi soffermo poi sui colori delle buste lasciate in giro e mi interrogo in che modo possano stare in sintonia con il tono cromatico delle pareti o dei giacconi appesi. Sembra che tra di loro ci sia stato da sempre un tacito dialogo di cui non ero a conoscenza, e che appena porgo l’orecchio per ascoltarlo, di colpo s’interrompa.
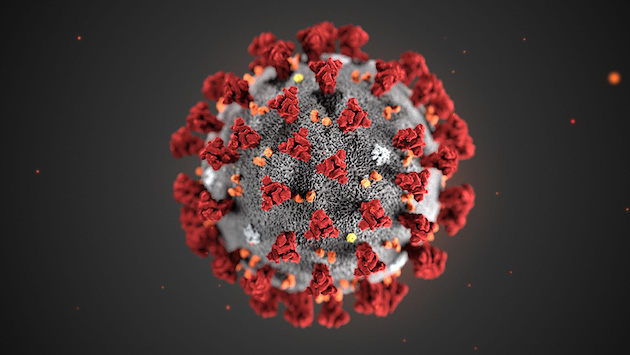
La strada è un deserto. Le uniche oasi hanno preso la forma di pattuglie di militari che vogliono conoscere i miei spostamenti e a volte me li impongono; le vetrine sono serrande abbassate, le piazze sono dei cimiteri silenziosi pieni di lapidi che ricordano vecchi sorrisi di ragazzi. Mi sembra di essere l’unico sopravvissuto alla sera di una tremenda tempesta meteoritica. L’asfalto è caldo e da lontano si sente soltanto la sirena di un’ambulanza, che con l’orecchio seguo fino alla fine, fino a che il mondo mi si richiude intorno come un lenzuolo sporco. A volte camminando incontro qualcuno che pare mi assomigli.
È fatto solo di occhi e passi lenti. Mi guarda con sospetto a occhi stretti e si tiene a distanza, farfugliando qualcosa se provo ad avvicinarmi. Vedo numerosi visi sconosciuti, emaciati, solitari, terrorizzati, come la folla di un quadro di un espressionista di cui non ricordo più il nome. Stanno in fila, aspettano di entrare nelle poche attività commerciali rimaste aperte, nessuno parla più, ci si guarda soltanto e raramente un cenno.
Sembra che gli uni nascondano qualcosa di terribile, quasi mortifero; gli altri, invece, l’antidoto che ci salverà tutti, la panacea agognata. Io abbasso la testa, accelero il passo.
Forse stanno parlando di me perché oggi non porto la mascherina o forse perché pensano sia io l’untore di chissà quale pestilenza. Sento che mi schifano, e io mi faccio tutto rosso per la vergogna di una colpa ingiusta. A casa il telefono è una calamita, e io un suo ostaggio volontario. Nel pomeriggio ritrovo gli amici per una videochiamata, facciamo gruppo, ci raccontiamo, ma è così strano parlare ad uno schermo. Uno schermo non ha calore, non ha tridimensionalità, è piatto e a volte è sfocato quando ci sono problemi di connessione. Spesso penso che tutto questo potrebbe tranquillamente essere un programma mal riuscito della Apple e io un inutile esperimento emotivo. Quando premo la cornetta rossa e interrompo la chiamata, sprofondo in un lago di petrolio nero e melmoso. Intorno a me soltanto il rimbombare del silenzio. Il tempo passa troppo veloce a casa. Non faccio in tempo a tornare dal lavoro che è subito sera. Programmo una serie di articoli da leggere e lavatrici da fare, ma alla fine rimango ad ascoltare i bollettini di morte dal fronte e a sfogliare velocemente ulteriori nuove direttive e restrizioni in pdf. Sento che il mio tempo non è più mio.
Qualcuno in televisione parla in abito elegante. Forse è lui il padrone che lo regolamenta, lo proroga, lo estende, lo rinvia, lo decide, lo costringe? Domani sarà uguale ad oggi ne sono certo, domani sarà un’altra occasione per perdere un’altra occasione. Non riesco a fare progetti, se non decidere cosa cucinerò per cena e anche quello mi risulta faticoso. Non c’è spazio per organizzare un viaggio estivo o una sera a teatro, sono ridotto al minimo, sono lo scheletro nudo di me stesso. Se mi distraggo per un secondo dalle notizie sulla pandemia, sento che il tempo è un bagno in una vasca all’aperto d’inverno, riempito di acqua gelida e senza fragranze esotiche. Mi sento pallido, con i vasi svuotati dal sangue che vi scorreva, quasi automatizzato. Le parole che dico hanno un altro suono, come se non fossero le mie, non ci sono abituato, e l’aria calda che espiro rimbalza sulla mascherina e mi ritorna addosso. Con le mani coperte di guanti non posso più sentire la temperatura delle cose familiari e tutto sembra artificiale, di lattice. L’alterità dimenticata del mio corpo esplode nel mio campo di esperienza ad ogni leggero mal di testa o colpo di tosse, che diventano perciò un presagio di malattia o di un avvenuto contagio. Il termometro si poggia sul comodino dove prima stavano impilati i libri che non ho più voglia di leggere e il frigorifero si riempie di frutta e integratori.
Da giorni non taglio la barba e spesso riutilizzo i vestiti di ieri quando provo a cambiarmi il pigiama. La cucina è piena di scatolette di tonno consumate e sughi pronti che iniziano a nausearmi per il loro gusto monotono. È come se la forza di gravità fosse diventata più forte di colpo e io fossi tutto piedi freddi e palpebre che crollano sugli occhi.
È la quarantena.
È questa mia insopportabile quarantena.








