RECENSIONE "Archeologie del trauma - Un’antropologia del sottosuolo"
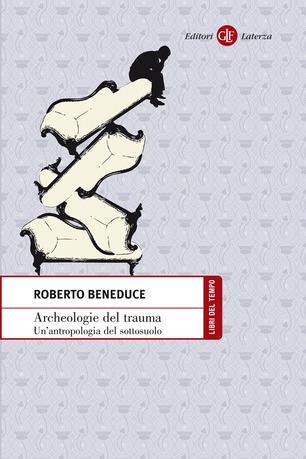
È uscita per i tipi dell’editore Laterza la seconda edizione de le Archeologie del trauma- Un’antropologia del sottosuolo di Roberto Beneduce; rispetto alla prima edizione del 2010 la ristampa contiene il capitolo aggiuntivo Archivi indocili per una memoria a venire.
L’Autore conduce una critica serrata, inquieta, intensa, ricca di note e riferimenti bibliografici della nozione di “trauma” come discussa e documentata in particolare nella letteratura psicoanalitica, in quella psichiatrica francese della seconda metà dell’Ottocento e del modo con cui il termine “trauma” è entrato nella codificazione della diagnosi di Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) introdotta nel 1980 nella terza edizione del Manuale diagnostico DSM III della psichiatria Nord americana. La categoria di PTSD è stata adottata per codificare disturbi presentati dai militari americani reduci dalla guerra nel Vietnam (difficoltà nelle relazioni sociali e affettive, disturbi dell’ideazione, dipendenze patologiche, comportamenti aggressivi, memoria ostinata di eventi traumatici e altro ancora). La diagnosi apriva ai reduci l’accesso ai programmi terapeutici e riabilitativi della Veteran Administration.
La diagnosi di PTSD è da allora usata in tutto il mondo a denotare i disturbi psichici di persone che hanno sperimentato violenze, torture, stragi, guerre, deportazioni provocate da umani, nonché di migranti in cerca di un approdo, richiedenti asilo, vittime di disastri naturali.
Nella sua puntigliosa, documentata ricostruzione Beneduce discute ed evidenzia come:
-
Il termine “trauma” di cui al PTSD, alle sue origini, sia stato usato a designare vicende che avevano visto protagonisti soggetti maschi adulti, bianchi vittime di guerre, cataclismi, e altro ancora, eventi catastrofici intervenuti violentemente nelle loro vite.
-
La diagnosi di PTSD ignora, non tiene conto delle intenzioni distruttive del torturatore o del carnefice.
-
La nozione di trauma e il dispiegarsi dei sintomi rimandino a un substrato neurobiologico e psichico comune a soggetti diversi e anche lontani per storie, condizioni, rapporti di forza.
-
La struttura del trauma sia presunta essere universale.
Di qui l’esigenza sia etica che politica, secondo Beneduce, di “archeologie del trauma” che disvelino le varietà di senso, modi di conoscenza e rappresentazione, silenzi, non detto, indicibile, vergogna, sensi di colpa, rabbia, desiderio di vendetta, domande di giustizia, tutto quello che sta dietro le analogie apparenti delle esperienze e dei sintomi generati da meccanismi psichici descritti come sempre identici. Di qui l’esigenza di spostare l’attenzione dal trauma all’evento traumatico così come risuona nei diversi registri della memoria (fra le memoria individuali e quelle collettive), nelle varie strategie narrative e nei silenzi.
Il problema dell’interpretazione di tali sofferenze psicologiche si era posto già nel corso e al termine della Prima guerra mondiale a medici militari, psicologi, psichiatri europei chiamati a gestire le cosiddette “nevrosi di guerra”, vale a dire i disturbi mentali che colpivano i militari facendoli diventare inidonei al combattimento per la presenza di un grave disturbo psichico. Non tutti gli esperti erano d’accordo che si trattasse di una “patologia psichiatrica” e va ricordato al riguardo che, nell’esercito italiano tali militari non erano considerati “malati”, ma “simulatori”, con tutte le conseguenti differenze del caso nei trattamenti, nei provvedimenti assunti dalle autorità.
Negli anni della Seconda guerra mondiale e nel successivo dopoguerra, nel corso delle guerre coloniali e nel corso della decolonizzazione è emersa in particolare l’importanza della questione delle sofferenze inflitte alle popolazioni civili (si pensi ai sopravvissuti alla Shoah; alle stragi in Congo, Ruanda, all’apartheid in Sud Africa, ai Palestinesi nel conflitto israelo-palestinese). Qui sono diventate centrali la testimonianza di Primo Levi, la figura e l’elaborazione di Franz Fanon, la ricerca di Freud, Ferenczi, Janet. Al riguardo, Beneduce sottolinea con forza che i traumi da incidente automobilistico o da esplosione di un ordigno non sono la stessa cosa rispetto alle sofferenze da tortura, vale a dire da violenze inferte intenzionalmente sulla vittima da parte di un essere umano. Le vittime chiedono il riconoscimento della loro verità, delle loro sofferenze, ma anche il risarcimento. Ma, se chi ha vissuto l’esperienza traumatica deve, come accade, anche magari accettare l’impunità di chi ha provocato umiliazioni, dolore e lutti, la sofferenza diventa intollerabile per la percezione dell’impunità e della superiorità del violento.
Secondo le teorie psicoanalitiche, il passato continua a perseguitare il presente delle persone e dei popoli: il complesso di Edipo e la sua elaborazione per questo sarebbero alla base dello psichismo universale e leggi dell’inconscio dovrebbero valere ed essere usate per l’interpretazione e la cura degli effetti psichici delle violenze. Ma, dice Beneduce, si tratta di un pre-giudizio etnocentrico perché la psicologizzazione del lutto e l’approccio psicoanalitico non risultano generalmente applicabili ed efficaci nella relazione con chi appartiene a culture non-bianche.
Il fatto è che le memorie traumatiche sono mediate culturalmente, politicamente, affettivamente, come accade quando, ad esempio, si sceglie di tacere per evitare di scaricare ricordi dolorosi su persone care.
Con le stesse argomentazioni, Beneduce mette in discussione anche l’abuso della retorica dell’emergenza e del paradigma diagnostico PTSD nelle attività che definisce di “psichiatria umanitaria” oggi diffuse in tutto il mondo nel soccorso a popolazioni che hanno subito catastrofi naturali, umanitarie, belliche. Egli insiste sul fatto che le traiettorie individuali del trauma vadano colte sulla scena di vicende che sono storiche e nel rispetto dei modelli culturali: qui secondo Beneduce la questione teorica principale, perché la storia non è se non nei corpi e nelle loro ferite, così come la cultura non è che nella coscienza e nelle parole di individui in carne ed ossa. Di qui l’opportunità di prendere in considerazione e riconoscere l’importanza e l’efficacia dei sistemi medici locali, della dimensione della spiritualità, delle Chiese, dei culti carismatici, e, comunque, sempre di “istituzioni di cura” sensibili, capaci di facilitare, sostenere il racconto del dolore, della violenza, dell’umiliazione.
Il capitolo 5 è dedicato alla tortura, la procedura tramite la quale l’aguzzino entra nel corpo della vittima: la tortura è definita un attacco ai fondamenti sociali e culturali dei confini del corpo e dell’esperienza del tempo, una frattura sistematica nell’esperienza del quotidiano.
Beneduce raccomanda una “riflessione critica permanente” sui limiti delle categorie diagnostiche, sulle forme della coercizione e dell’assoggettamento, così come sulle strategie contro-egemoniche e i modi di resistenza. Le molte tragedie, infatti, di cui siamo testimoni non sono solo risultati di circostanze imprevedibili o la conseguenza di viaggi su imbarcazioni inaffidabili, ma il risultato anche della militarizzazione delle frontiere e dei presupposti che ne regolano il controllo, ben oltre le odiose violenze commesse dai cosiddetti “trafficanti di uomini”.
Egli raccomanda ancora il dovere di verificare quello che accade nei CPT, CIE, CARA, CDA ecc., i numerosi non-luoghi in cui sono accolti migranti, richiedenti asilo, irregolari, spazi di extraterritorialità per “sradicati dal tempo e dal diritto”, nei quali cui le persone internate non dispongono del loro passato, che è abolito, e il futuro è bloccato.
Nota
Roberto Beneduce è medico psichiatra, etnopsichiatra, antropologo, epistemologo, storico della psichiatria e del colonialismo. Allievo di Sergio Piro all’Università di Napoli, si è dottorato presso l’École des hautes etudes en Sciences Sociales di Parigi; è professore di Antropologia Culturale all’Università di Torino. A Torino ha fondato il Centro Frantz Fanon, che eroga a migranti cittadini stranieri, rifugiati richiedenti asilo, sans papiers, vittime di torture servizi di psicoterapia e supporto psicosociale in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale della città.
Ha operato in Camerun, Uganda, Mozambico, Mali, Repubblica Democratica del Congo, Colombia, Eritrea, Etiopia. Fra i suoi campi principali di ricerca vi sono
• l’Antropologia della migrazione e della diaspora (rifugiati, richiedenti asilo, politiche della cittadinanza, minoranze etniche);
•i Postcolonial e Subaltern Studies; la Storia coloniale, con particolare riferimento alla medicina e alla psichiatria coloniali;
• l’Antropologia della violenza, della memoria e della guerra; l’Antropologia Medica e psicoanalitica;
• l’Etnografia delle “medicine tradizionali” e delle loro trasformazioni; stregoneria; rituali terapeutici (Mali, Cameroon, Mozambico, Uganda); conflitti fondiari (Mali); immaginari religiosi in Africa Subsahariana e in Sud-America.
Fra i suoi testi principali segnalo:
2017 (con Nigel Gibson), Frantz Fanon: Psychiatry and Politics, London & New York, NY: Rowman & Littlefield and Wits University Press.
2016, L’Histoire au corps. Mémoires indociles et archives du désordre dans les cultes de possession en Afrique, Fribourg, collana Studia Instituti Anthropos – Academic Press.
2007, Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura, Roma, Carocci (quarta edizione 2015).
2004, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo, Milano, Angeli (sesta ristampa 2014).








