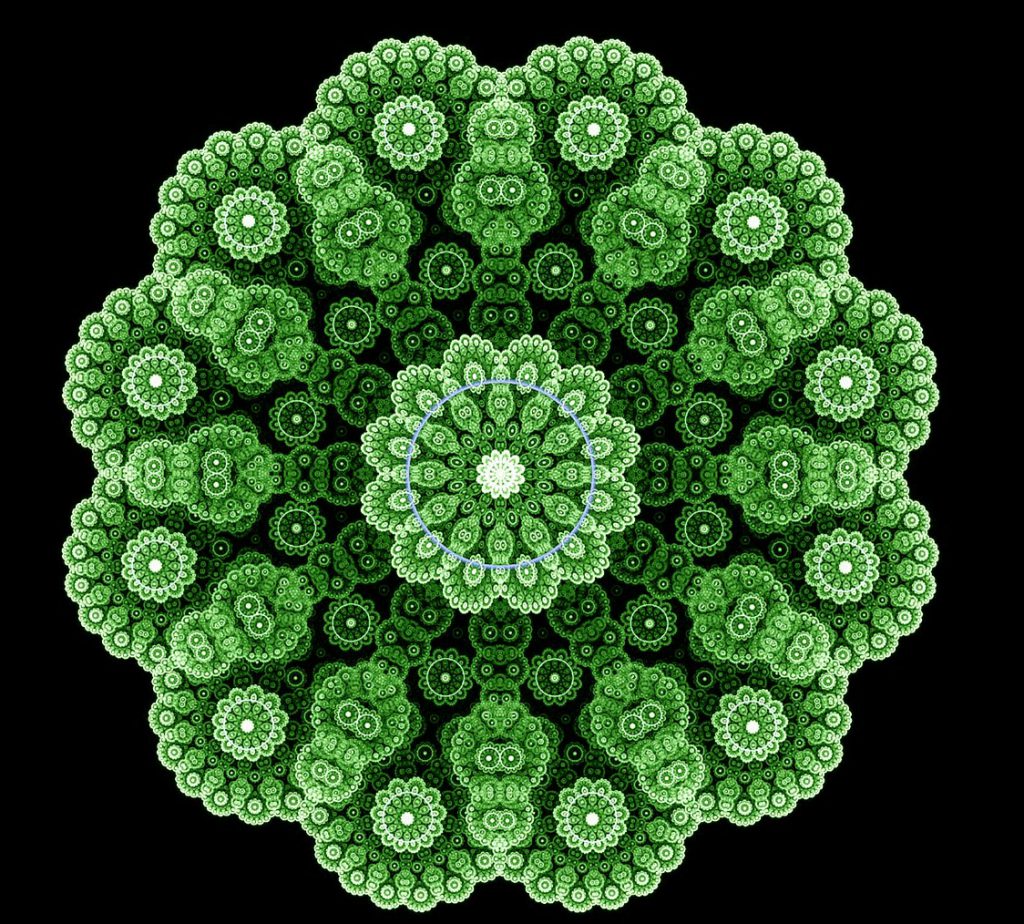
In questo nuovo articolo il Dott. Stefano Canali della SISSA di Trieste compie una rilfessione sulla natura sistemica dei disturbi da addiction, portandoci a riflettere su come, in senso clinico, occorra allargare lo sguardo dal "solo" individuo per ragionare sugli effetti dell'ambiente sull'individuo stesso, la sua famiglia, la relazione tra gli elementi dell'intero "sistema", che andrebbero considerati sullo stesso piano e in grado di influenzarsi a vicenda, come succede in ogni sistema complesso. Alcuni filoni di ricerca, come quello condotto e promosso da Denny Borsboom in Olanda, promuovono una concezione della psicopatologia fondata su un modello di causalità non più lineare, ma circolare: i disturbi da addiction sembrano prestarsi molto bene a una lettura di questo tipo, non riduzionistica e semplificativa, per forza di cose inclusiva, ampia e articolata, verso un approccio multi-professionistico e corale al problema.
Viene inoltre citato il programma "Youth in Iceland" messo in atto in Islanda a partire dal 1998 per contrastare il fenomeno dell'alcolismo e della tossicodipendenza tra gli adolescenti, che pare aver dato risultanti vistosamente soddisfacenti proprio in ragione di un approccio allargato alla questione.
Raffaele Avico, Psychiatry On Line
Il concetto biomedico della dipendenza come malattia del cervello, come disfunzione biologica, sembra aver definitivamente scalzato le spiegazioni sociali, psicologiche e morali ed è diventato il riferimento prevalente nel dibattito teorico e nella ricerca sulle cause e sulle strategie di intervento sull’abuso di sostanze psicoattive.
Una delle interpretazioni più ricorrenti e comuni della spiegazione biomedica delle dipendenze è che l’uso prolungato di una sostanza determina precise alterazioni nelle strutture e nelle funzioni cerebrali le quali, a loro volta, trasformano l’uso volontario e regolato nella ricerca e nel consumo compulsivo della sostanza. Il segno cardinale di questa malattia sarebbe la perdita del controllo rispetto alla sostanza o al comportamento che è oggetto della dipendenza, come sarebbe nel caso del gioco d’azzardo patologico.
Questa concezione della dipendenza come malattia, come disfunzione biologica, tuttavia stenta ancora oggi a trovare un modello esplicativo che metta d’accordo la stessa comunità biomedica. Non esiste infatti ancora un sostanziale consenso su quali siano i processi fisiopatologici e la rete causale e dei meccanismi – dalla sostanza, al cervello e al comportamento -, che portano un individuo a passare da un uso controllato a un consumo compulsivo, alla dipendenza.
Al di fuori della clinica e della ricerca biomedica ovviamente, questo concetto è considerato incapace di rappresentare la complessa natura della dipendenza e le sue numerose peculiarità. D’altra parte, le descrizioni di tipo psicologico e sociologico sono in grado di cogliere elementi della fenomenologia di questi comportamenti invisibili alla prospettiva biomedica e ancora non riducibili a una qualche alterazione nella fisiologia del sistema nervoso centrale.
I livelli di processi in gioco nelle dipendenze riguardano molti piani fattuali diversi da quello molecolare e farmacologico e gli stessi meccanismi fisiopatologici attivati nel cervello con l’esposizione alle sostanze sono modulati dall’ambiente, dalla sfera comportamentale, dai costrutti e dalle dinamiche intrapsichiche. I determinanti neurofarmacologici su cui agiscono le sostanze sono peraltro gli stessi della rete complessa di segnali e interazioni che nel cervello elaborano e distillano percezioni, comportamenti, credenze, abitudini, relazioni, aspettative. Ciò spiega come mai gli effetti delle sostanze e la loro eventuale capacità di portare alla dipendenza variano in funzione delle diverse concrete situazioni in cui una persona consuma, delle finalità d’uso, di ciò che sa e di ciò che si aspetta dalla sostanza, del complesso delle altre abitudini e valori con cui si struttura la sua vita psichica e materiale. Ecco perché, inoltre, nel trattamento delle dipendenze, le strategie di cura, recupero e prevenzione di tipo psicosociale mantengono un grado di efficacia comparabile, se non superiore, a quello degli approcci medicalizzati.
Ora, il dibattito su quale sia il modello migliore, tra quello biomedico e quello psicosociale, appare francamente poco interessante. È evidente che la complessità della dipendenza, la diversità e la circolarità dei livelli di processi e fenomeni che coinvolge – da quelli molecolari a quelli fisiologici, da quelli psicologici a quello sociali -, impongono l’uso di approcci concettuali e operativi articolati, multidimensionali, sempre integrati. Credo sia più urgente un lavoro di revisione concettuale più profondo. Ritengo infatti maggiormente utile partire dalla riflessione sull’idea stessa di malattia come disfunzione, come deviazione da una norma biologica funzionale. Questa idea costituisce infatti l’assioma, il fondamento teorico, su cui poggia l’attuale concetto di dipendenza in quanto patologia del cervello che compromette il controllo volontario dell’uso della sostanza
Funzione e disfunzione biologica (malattia). Organismo o ambiente?
A un primo sguardo il concetto di funzione biologica sembra banale, ma da più di un secolo la ricerca scientifica cerca invano di stabilire cosa propriamente sia, come si individui precisamente una funzione e come poi possa essere correlata a una struttura biologica o a una eventuale malattia.
Non c’è qui lo spazio per affrontare in modo esauriente un tema che ha impegnato centinaia di studiosi e prodotto un’enorme quantità di letteratura. Mi soffermerò tuttavia su aspetto problematico poco discusso e relativo al carattere intrinsecamente complesso e sistemico delle funzioni di un organismo biologico e dei processi funzionali che una persona mette in atto e dentro a cui si muove.
Ritorniamo al concetto di dipendenza come malattia del cervello e all’idea di malattia come disfunzione. Una disfunzione è una deviazione da una norma di funzionamento fisiologico. Ma ogni funzione normale è anche espressione di una “normale” relazione con l’ambiente. Tutte le funzioni biologiche e psicologiche sono infatti espressione di una interazione con l’ambiente esterno. Questo rappresenta lo spazio vitale per agire in vista della sopravvivenza individuale e della specie. Dall’ambiente esterno l’organismo trae nutrienti, energia, materia; e nell’ambiente riversa i prodotti del suo metabolismo. Dall’ambiente riceve stimoli percettivi e nell’ambiente esterno si realizzano le relazioni con gli altri esseri viventi e con gli appartenenti alla stessa specie, senza le quali la vita organica e quella psicologica sarebbero impossibili.
Dunque se una funzione biologica normale (comprese quelle del cervello e quindi del comportamento) viene compromessa e inizia così una malattia è perché è intervenuta una qualche anomalia nel rapporto “sano” tra organismo/individuo e ambiente. Le malattie infettive illustrano eloquentemente questa relazione. Una data concentrazione di agenti infettivi è sempre presente nell’ambiente e nell’organismo di un individuo. In condizioni normali, la carica patogena dei microbi viene controllata dall’azione sinergica di un complesso di elementi funzionali diversi ma mutuamente integrati, solo per citarne alcuni: il sistema immunitario di un individuo e altri meccanismi di difesa fisiologici, i suoi comportamenti, la sua alimentazione, i presidi igienici di cui può disporre in casa e al lavoro e quelli che gli vengono garantiti con le infrastrutture (fogne, acqua corrente e riscaldamento in casa), con la vigilanza, la profilassi e l’intervento dei servizi sanitari (controllo della qualità dell’aria, dell’acqua, del cibo; vaccinazioni, trattamento farmacologico delle infezioni, isolamento dei focolai infettivi e così via). Ma se uno qualunque di questi meccanismi funzionali diffusi tra individuo e ambiente viene compromesso allora tutto l’insieme funzionale viene pregiudicato e così può insorgere una malattia in una persona o manifestarsi un evento epidemico. Una cosa analoga vale per le malattie oncologiche, per gli altri disturbi cronico-degenerativi come le malattie cardiovascolari, dismetaboliche e in definitiva per tutte le condizioni che la medicina si trova ad affrontare, compresi gli infortuni e gli eventi traumatici, anch’essi espressione di un qualche tipo di inconveniente nel rapporto tra ambiente e organismo/individuo.
La prospettiva biomedica tende invece a concentrarsi sull’individuo. La malattia viene soprattutto ritenuta un processo che ha luogo nell’organismo di una persona. L’idea di malattia in questo modo esprime l’adozione di prospettiva, un giudizio di valore perché contempla la scelta di intervenire su uno dei due elementi della relazione compromessa tra organismo/individuo e ambiente. Se la relazione tra un organismo/individuo e l’ambiente è valutata inadeguata e porta alla definizione di una particolare malattia, ciò significa infatti che è il l’organismo/individuo a essere giudicato malato e che l’ambiente è ritenuto accettabile e funzionale. Ma, come abbiamo detto, la salute è la forma desiderabile e ottimale di relazione funzionale tra individuo e ambiente. Quando questa relazione è disfunzionale in genere anche l’ambiente che la determina può essere cambiato, sebbene ciò possa risultare più complesso dell’intervento su un singolo individuo, sul corpo e il comportamento di una singola persona. Ciò dimostra che definire malato il corpo o il comportamento di un individuo piuttosto che l’ambiente non è un fatto oggettivo ma una questione di punti di vista, di interessi (economici? politici?), di supposta praticità, oppure semplicemente la conseguenza di un’inerzia cognitiva, l’abitudine a pensare in modo schematico e come nel passato.
Dalla tossicità delle sostanze alla tossicità dell'ambiente
È evidente che l’idea della malattia come rottura di un’omeostasi, di un equilibrio complesso e dinamico tra ambiente e organismo/individuo valga anche per l’analisi del consumo di sostanze psicoattive e delle dipendenze. Una eccessiva focalizzazione sull’individuo, sul suo comportamento, sul suo cervello e sulle sostanze tossiche può portare a trascurare colpevolmente l’azione “tossica” dell’ambiente. E questa azione è assai più pervasiva e costante di quella delle sostanze. Essa si esplica attraverso la disponibilità delle sostanze sul mercato, dai significati e dall’accettazione che la società sta loro riconoscendo. Ma si realizza soprattutto per mezzo del carattere patogeno di certe dinamiche sociali, di talune condizioni di vita materiali: spesso intollerabili per il modo stesso in cui sono costruiti i meccanismi funzionali del nostro corpo, del nostro cervello e della nostra mente. L’azione “tossica” dell’ambiente si esplica nella effettiva tossicità biologica, nervosa e psicologica di determinati valori e simboli della contemporaneità, di certe rappresentazioni, forme e stili di consumo del piacere, del tempo libero, di oggetti, merci e relazioni oggi purtroppo ritenuti comuni, anzi funzionali e sani.
Negli ultimi 20 anni, investendo sul miglioramento dell’ambiente e delle opportunità di svago, attività fisica, socializzazione, crescita culturale e personale dei giovani, l’Islanda è diventato il paese europeo col più basso indice percentuale di consumo di sostanze psicoattive tra i ragazzi. L’Islanda partiva da una delle situazioni più problematiche da questo punto di vista, ma lavorando sulle condizioni ambientali, sull’educazione, sulla cultura e sullo sport si è arrivati quasi all’azzeramento del consumo di sostanze psicoattive. La percentuale dei ragazzi ubriachi almeno una volta al mese è caduta dal 42% del 1998 al 5% dello scorso anno; la percentuale di ragazzi che consumano cannabis dal 17 al 7%, quella dei giovani che fumano sigarette dal 23 al 3%.
Noi italiani invece amiamo perseverare a far male. Continuiamo a usare le scarse risorse disponibili per finanziare prioritariamente lo studio e il trattamento della dipendenza come malattia trascurando la ricerca e gli interventi sugli altri livelli fattuali da cui dipende l’uso problematico di sostanze. Ma soprattutto, a scapito della ricerca, dell’educazione dei provvedimenti per migliorare il benessere materiale e sociale, continuiamo a concentrare gli sforzi economici sull’aumento delle misure di repressione. E perpetuiamo questa logica di investimento da almeno mezzo secolo nonostante si sia tradotta in un costante aumento dei consumi di sostanze psicoattive. L’ultimo funesto esempio è quello del cosiddetto piano straordinario del Ministero dell’Interno contro le droghe nelle scuole denominato “Scuole sicure” e avviato lo scorso 26 agosto. Si tratta di 2,5 milioni di euro messi a disposizione da Salvini per i comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste. Soldi che non serviranno a offrire ai ragazzi nuove occasioni di apprendimento, uso del tempo libero, socializzazione sana e attiva, come in Islanda. Come recita la circolare ministeriale, i contributi dovranno essere spesi dagli enti locali “per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o installare impianti di videosorveglianza”, di conseguenza, aggiungiamo noi, creare o aumentare il senso di estraneità, minaccia e insicurezza vissuto nell’ambiente scolastico e con esso l’ansia e le inquietudini che possono portare al consumo.
canali@sissa.it
![]()








0 commenti