CUORE DI TENEBRA
Viaggio al termine della psichiatria
LAMPI NELLA NOTTE
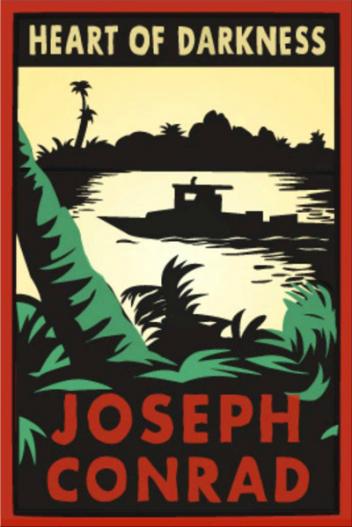
e quella in cui stavo entrando. L. Althusser
Notte silente, il deserto è in ascolto di Dio.
E la stella parla alla stella.
W. Goethe
Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna…
G. Leopardi
Ho conosciuto il “sorriso nascosto”, quello rubato, e secondo molti, “immeritato”. Come se anche il sorriso, uno, se lo dovesse guadagnare..Di chi ha vissuto cadendo a picco, di chi, per tanti, non avrebbe più motivo di ridere; di chi da solo, è riuscito a non morire. Il sorriso di una voglia straziante e viva. Un frammento acceso di vita, di chi vive già, come se ne stesse andando, o come se per lui non ci fosse un posto. Ho voluto incontrare dolori senza condannarne le ragioni, comprendendoli senza giudicarli, senza dare il mio “parere”. Qualcuno non lo sa, e qualcun altro, forse, non vuole saperlo...Ci sono vite trascorse in una stanza, in un letto. Rinchiuse tra le mura di una casa. Vite senza compagnia. Che hanno conosciuto solo una madre, una sorella, e qualche medico: poche presenze che hanno assistito a queste vite “ammalate”. Vite senza mai sbocciare, o sbocciate male. Che non sono andate come dovevano. Passate in silenzio. Senza fare rumore, senza traccia “degna di nota”... Vite ferme, mentre tutto fuori, si muove indifferente. Eppure, può scoppiare il cuore in un solo istante, attraverso uno sguardo, osservando qualcuno...Si può essere travolti dall'immensa grandezza di chi vive al margine, di chi è negato, diverso, escluso..Di chi ha in viso i segni del dolore, di chi ci fa orrore, ci ripugna, e turba per il suo male. Di chi ho avuto la fortuna di incontrare ed avere accanto. E che forse, ora mi fa scrivere. Come se solo ora, e solo grazie a questo, io potessi dire qualcosa. Qualcosa di diverso, che non piace a chi vive nella positività vuota della migliore, normale, e corretta condizione dell'essere felici e soddisfatti, nell'illusione di poter provare gioia senza mai dolore, senza mai incrociare quegli occhi profondi di chi sorride, invece, dal margine del suo niente, quasi beffandosi degli altri, come per ironia, disperazione, o perchè ormai troppo lontano.. Lontano da quello che siamo e abbiamo per sentirci normali.. Forse si parla meglio con gli occhi, con i sensi, con il cuore..., e ancora meglio con gli anni, che sembrano svuotarci, ma che forse riempiono, e accordano lentamente il fluire delle nostre stagioni combinandole in un equilibrio che non lascia nulla fuori, in cui nulla si perde. Ma siamo persone e non animali. Ci avviliamo attraverso le parole, come se fossero barche che ci portano a riva, mentre in realtà, spesso possono farci naufragare nell'impotenza di esprimere, di poter passare attraverso esse. Come se le parole uccidessero inesorabilmente ogni sentire tradendolo. Ma in fondo, anche se siamo come continuamente e alternatamente emersi ed immersi, vogliamo emergere restando immersi, senza perdere nel dire... Eppure, attraverso le parole qualcosa arriva. Qualcosa che forse è fuori del nostro controllo, e che non possiamo più tirare indietro. Ma solo lasciar andare, non si sa dove, e non si sa a chi. Forse una parte, o forse tutto, che lì dove arriva, incontra un'altra parte, un altro tutto..E questo, è un gesto di quelli che si svincolano dalla prassi, che trasgrediscono la norma, e che non vogliono nemmeno vestirsi di presentazione, introduzione, né altre apparecchiature superflue e deformanti. Gesti che non si propognono, ma che si pongono nel modo più spoglio e puro. Non sono gesti ciechi che non riescono a vedere oltre sé, solo perchè trascurano di anteporre un nome, e omettono la posizione dalla quale partono. Non sono gesti folli e chiusi, ma aperti e liberi. Che solo così posso fare.
Agosto 2015
L’ ADDIO ALLA VITA
Il tuo cuore stanco, A. si è fermato un mattino di questa mezza estate, al sorgere del sole. Avevi solo 22 anni. Pesavi solo 25 chili. Eri uno scricciolo. Uno scheletro rivestito di pelle. Occhi grandi, malinconici e sognanti, con dentro ancora l’idea di un futuro impossibile. Una barella, un monitor, le sacche a permanenza. Questa, mentre eri ancora in vita, la tua camera ardente. La presenza continua dei nostri infermieri per impedirti di chiudere il rubinetto della flebo, ultimo filo che ti legava alla vita. “Lo sai che stai morendo?” “Con voi non parlo”, hai risposto. La morte non era in discussione, per te, che della morte avevi fatto l’unica tua ragione di vita. Con i nostri infermieri hai parlato, invece, perché di tutto ti parlavano, ma non della morte. Si sono alternati numerosi, anche per reggere meglio un insostenibile turno di sei ore accanto a te. Due ore a testa, come si fa in guerra coi turni di guardia di fronte al nemico incombente, in stato di massima allerta. E’difficile vegliare un cadavere a cuore battente. Un corpo vivo, il tuo, ma già abitato dalla morte. Eppure questi uomini e queste donne rotti a tutto, con tanti anni di battaglia sulle spalle, hanno ascoltato la tua musica, con te. Tentato di parlare della vita, con te, di tutto e di più. Mentre pensavano ai figli, coetanei tuoi, che avevano a casa. Mentre pensavano ai tuoi genitori, disperati, coetanei anch’essi. Noi, avvezzi a trattare la più scatenata follia, così nudamente impotenti di fronte alla tua immensa e incoercibile volontà di morte. Il trattamento sanitario obbligatorio per importi una terapia salvavita, che tu ti ostinavi a non volere. Oggi, che non ci sei più, te ne chiediamo perdono. La tua leggerezza trasparente, più pesante di un intero e pachidermico ospedale. L’ultimo tuo anno di vita: un’odissea tra ospedali e centri, tra eroici tentativi di cura e vili dinieghi. Perché in una società così decadente e così opulenta una giovane donna come te, bella, intelligente, si lascia morire in questo modo? Stoppino che si consuma senza più cera. Rapita dall’essenzialità dell’anima, spirito disincarnato, onnipotente fino a nutrirti solo del tuo proprio corpo, scavandolo da dentro, organo per organo, nel distacco progressivo da tutto. Solo quel cellulare, nella tua affusolata mano destra, ultimo contatto con un mondo a cui, di minuto in minuto, stavi dicendo addio. Noi, che ragioniamo coi deliri; noi, che ci apriamo una via tra le allucinazioni; noi, abituati, come gli speleologi, a cercare una fiammella nel buio sotto terra; come i pompieri, a domare le fiamme della rabbia distruttiva; come i sommozzatori, a trattenere a lungo il respiro nella vastità del mare; noi, che interpretiamo tutto, senza più ragioni da offrirti. Una giovane vita, la tua, catturata dalla morte volontaria, che svanisce nella corsia di un ospedale, nel cuore dell’estate, mentre i tuoi coetanei ballano, fanno l’amore, sognano a colori, si sentono padroni del mondo, vivono la notte, il mare, le luna e le stelle, i fuochi sulla spiaggia, corrono, sentono la musica nel sangue, traversano il mondo, vibrano di eternità. Ci auguriamo di essere riusciti, A., dando fondo a tutta l’ umanità che ci rimane, a dare un senso a ciò che un senso non ce l’ha. A rendere meno squallido il tuo breve passaggio finale; a coprire, con la nostra voce umana, il bip-bip del monitor; a ricordarti, tenendo aperto con dolcezza e con fermezza il rubinetto della flebo, che la tua vita ancora stava a cuore a qualcuno. Che, sapendo che ti stavamo perdendo, non volevamo perderti; che credevamo di potercela fare, anche questa volta, a tagliare la strada alla morte. Noi, uomini e donne dagli occhi asciutti, dalle spalle grandi, abituati ad agire prima di pensare, che non possiamo mai piangere, di fronte alle tragedie che ogni giorno ci arrivano, noi abbiamo versato lacrime, per te, non visti, anche se non eri nostra sorella, anche se non eri nostra figlia. Noi ti abbiamo voluto bene, anche se non ti conoscevamo da molto e sapevamo che non ti avremmo tenuto la mano per molto. E, in fondo, a modo nostro, come siamo abituati a fare con i nostri pazienti più folli, abbiamo avuto rispetto per la tua visione del mondo. Anzi, ti abbiamo ammirata, per la tua determinazione, per la vita a cui ti tenevi appesa, nonostante avessi ormai la morte dietro l’angolo; per la dolcezza infinita che, nonostante la via cieca, promanava dalla tua fragile esistenza. Siamo onorati di averti accompagnata, A., nel tuo ultimo viaggio. Addio A., innamorata della morte, che sei riuscita, come nessun altro, a farci sentire così tanto attaccati alla vita, nostra e degli altri, in questa torrida estate, oltre tutto il dolore e tutta la vanità del mondo.
PERFETTI SCONOSCIUTI
E’ un po’ come tutte le notti che precedono l’inizio del nostro turno, un saluto a chi va uno a chi viene, uno scambio veloce una battuta leggera ,serve a tirarsi via la stanchezza del quotidiano e a tuffarsi nella notte che mai ci lascia indifferenti, veloce raccolta di dati, ultimi passaggi di consegna, poi ci si cambia, un profondo respiro, l’odore di un primo caffè che ci accompagna e ci carica verso storie di vite complesse, così lontane ma così vicine che in maniera silente diventeranno parte di noi.
Sembra andare tutto abbastanza liscio stasera, si ultimano terapie, si prova a preparare qualcosa di caldo per rendere meno lunga e più utile questa notte, mentre qualcun’altro si offre alla curiosità apparente cercando del proprio negli occhi e nelle storie di chi è là in cerca di aiuto, ma nel quale prova ad allontanare da se la paura di essere parte del tutto. Anto ha quasi pronto un the e qualche biscotto, Gigi legge consegne lasciate nei turni che ci hanno preceduto e Luigi archivia qualche cartella, mentre io e Gilberto si parla di un libro e di cose da fare che di notte sembrano più vicino ai nostri sogni che alle nostri reali possibilità.
Quando tutto ti sembra così per un attimo chiaro e il piacere si libera dell’estenuante fatica del cercare risposte, uno squillo rompe la tua intimità e la richiesta si offre forte e chiara dall’altro capo del telefono.
Ci si guarda ,ci si sceglie e si va, il tratto che intercorre tra il reparto e il PS, è lo stesso tratto che lancia il pugile dallo spogliatoio verso il ring, è il momento in cui ci si chiede il senso di quello che si andrà a fare, è il momento in cui ci si chiede se ancora una volta si riuscirà a venire a capo di cose su cui ancora bisognerà lavorarci perché possano definirsi con più chiarezza dentro di noi, ma mentre ci si avvicina al ring il tempo è ormai finito e i secondi sono già fuori, ci si guarda un ultima volta per avere almeno la sensazione di essere in linea.
Il medico del PS ci spiega sommariamente la situazione, si fa fatica anche a scambiarsi la più semplice delle consegne in quelle stanze mal divise e dove il caos degli operatori crea più di quanto ci sia anche nel filtro delle richieste.
Raggiungiamo la stanza e ci viene indicata la lettiga dove disteso e leggermente confuso con sguardo remissivo, si trova un uomo di poco più di trent’anni, ci viene detto che una pattuglia dei carabinieri l’ha sottratto ad una colluttazione e che pare impugnasse un coltello che brandiva in maniera minacciosa anche verso le stesse forze dell’ordine . Ci avviciniamo cerchiamo di capire cosa sia successo chiedendo a lui la versione dei fatti. Il tono della sua voce è apparentemente tranquillo, cerca di giustificare l’accaduto e a modo suo ci rassicura scusandosi, e che tutto a breve rientrerà. Intanto veniamo a sapere con una ricerca fatta in maniera a dir poco tortuosa che ha una lunga storia di alcool, droghe e soprattutto che risulta positivo all’ HIV ed ha una Epatite di tipo C. Intanto gli esami di routine gli sono stati praticati e gli si comincia ad offrigli l’opportunità del ricovero per sottrarlo più a rischi di carattere legale che al reale aiuto che gli si può offrire dal punto di vista delle nostre competenze, cercando di guadagnare tempo necessario per affrontare in maniera più adeguata le problematiche che lo hanno condotto quella notte in PS.Mentre tutto sembra fluire verso una tranquilla risoluzione della richiesta, al nostro invito a seguirci comincia ad opporsi prima in maniera garbata e poi in un crescendo di ostilità e rabbia al punto che si libera quasi completamente dei presidi e comincia ad inveire contro tutto e tutti.
Le persone e tutti coloro che si trovavano in quella stanza fatta da altre lettighe ed operatori si svuota come in una fuga per il sopraggiungere di un ciclone, d’improvviso non è più disposto a trattare, prende l’asta che regge la flebo e la scaglia contro una parete e urlando comincia una sorta di danza avanzando e indietreggiando sfidando di volta in volta le uniche tre persone rimaste lì con lui. Ormai il reflusso ematico ha completamente riempito il tubicino della flebo e l’ago non è più in vena, in pochi istanti la confusione e il caos si placano e le urla del nostro amico cominciano a divenire un preoccupante imperativo ,grida verso di noi cose forse senza senso ,ma sembrano più giustificazioni alla sua condizione che vere e proprie necessità, in un istante comincia ad avanzare minaccioso verso Gilberto screditandolo del non senso del suo intervento ,io e Gigi compreso il rischio proviamo a staccare la sua tensione e la sua attenzione dal bersaglio che era divenuta preoccupante, funziona,ma comincia a venire verso di noi brandendo il deflussore pieno solo del suo liquido ematico come arma . C’è un istante in cui sotto un forte livello di pressioni metti via ogni difesa e ti affidi al tuo sentire che ti porti a prendere la più opportuna delle scelte, ma forse più per consapevole impotenza che reale certezza del da farsi, lo guardo è ad un passo da noi, si coglie il suo respiro e nella sua rabbia il senso di perdita, di un mondo di cui non sa più che farsene di lui, cerco contrapponendomi alle sue urla con tono pacato di essere li a raccogliere le sue ragioni, intanto il suo braccio con il deflussore e ormai all’altezza del mio viso, non muovo più un muscolo lo guardo negli occhi e d’improvviso non sento più nulla, i suoi occhi sono più forti delle sue urla e sanno che non vedranno vie di fuga e allo stesso tempo nemmeno cercate.
A quel punto Gilberto lo aggancia alle spalle attraverso la cinghia dei pantaloni e lui si consegna quasi morbidamente come d’improvviso a prendere coscienza della fine del match, un po’ come quando il pugile si abbandona allo stremo delle forze quasi rendendo grato l’avversario di aver finalmente centrato l’ultimo colpo che rende giustizia alla forza dell’altro e giustifica con dignità la sconfitta. E’ a terra noi sopra di lui più in un abbraccio a protezione che in un contenimento a nostra difesa, piange si scusa ,ci chiede di non fargli della male ed è forse più penoso per noi che per lui trovarci troppo tardi per poter rimediare.
Lo solleviamo, lo rialziamo delicatamente lo ripuliamo e lo accompagniamo in reparto, ancora piange comincia a parlarci di lui e della sua storia di vita come mille altre, ma come mai prima d’ora qualcuno ascolta in maniera accogliente provando a restituire almeno sul piano emozionale. Ormai è a letto e noi mentre stiliamo giù il rapporto dell’intervento, torniamo a cercare di essere leggeri provando a guardare fuori per non lasciare in maniera troppo forte dentro quello che domani proveremo senza mai riuscire a dimenticare.
Inf.prof.; counselor, SPDC Ospedale S.Maria Delle Grazie, Pozzuoli
DOPPIO SOGNO
SPDC. Una notte di maggio del 2016. La cena con gli infermeri è andata. Sono in branda e ho appena perso i sensi quando sento il cicalino. Ore una e trenta. Fuori piove. E’ il collega di guardia a Giugliano. Paziente maschio, in stato maniacale, agitatissimo. Non hanno posto. Anche io sono pieno, ma non me la sento di lasciarlo in difficoltà. Gi do la disponibilità. Avverto gli infermieri. Mi alzo. Tiro fuori una cartella pulita e riordino la scrivania. La mia stanza è appena fuori dal reparto. Nel tempo che passa il tamburellare sempre più violento della pioggia non mi sembra quello di maggio. Ero convinto che la serata passasse. Il Napoli ha vinto quattro a zero. Quando il Napoli vince e il cielo butta acqua, la serata va. Ma non sempre è così. Stanotte non è così. Ho quasi ripreso sonno fino alle quattro e mezzo, con spezzoni di sogni contorti e agitati. Ci sono io, c’è qualcun altro. Non si capisce chi di noi è il paziente. Quando bussano all’entrata dell’SPDC, gli infermieri aprono da dentro con il comando elettrico, e non vengono fuori dal reparto. Gli avventori entrano, alla rinfusa. Un torrente umano che percorre gli anditi semibui fino alla mia stanza illuminata. Chi è il paziente? Non si capisce mai chi è il paziente. Mi sembra di vivere il mio sogno. Due carabinieri in fondo. Due infermieri del CSM in abiti civili, una dottoressa del PS, col suo fonendo al collo, parecchio fuori contesto. Un paio di amici e un fratello. Il paziente. Silenzio, disagio, imbarazzo. Il paziente a un tratto si staglia evidentemente dal gruppo informe, esplora da padrone lo spazio della stanza, e si butta su un divanetto. Non chiede permesso a nessuno. E’ drammaticamente agitato. Farfuglia frasi sconnesse. E’ accelerato. Gli occhi, che ho incrociato per un attimo, gli fiammeggiano. Gli hanno detto, per rabbonirlo, che veniva a fare un accertamento e che andava via. Come al solito. Spero che gli stiano facendo effetto i sedativi che mi hanno detto di avergli fatto in PS a Giugliano. Macchè. Si alza, riprende vigore, inveisce violento contro il fratello. Il fratello si allontana.accusa di una cospirazione contro di lui. Chiamo in reparto e faccio preparare le fascette. I carabinieri non si muovono. Forse si aspettano, come da regolamento regio del 1904, che escano i mastugiorgi del manicomio con la camicia di forza.. Il paziente è sempre più incoerente e scomposto, alza la voce, si agita sempre di più. Minaccia la catastrofe. Mi viene verso. Mi sento solo. Ho paura. Per prendere tempo fingo di raccogliere qualche notizia. Ma non faccio che peggiorare la situazione, perché ogni parola il paziente la prende di traverso. Non sono tranquillo, sento che ora sta per esplodere. Mi sento più agitato di lui. La stanza è piena di sedie, di quadri di spigoli. Viene dal mio stesso hinterland, questo ragazzo. Non ha più i genitori. Ha un figlio che non gli fanno vedere né riconoscere, che ogni tanto incontra nel paese. Dopo il congedo dall’esercito ha gestito dei bar. Alcol, sostanze, discoteche, rave. Chiedo “Old river”? “Old river..” Ne ho visti di fulminati dell’Old river in questi anni. Ultima missione a Kabul, nel cellulare mostra video di cadaveri con teste mozzate. Era in un’unità di soccorso che sopraggiungeva dopo gli attentati. Raccoglievano arti e organi sparsi. Poi il congedo per turbe del comportamento. In America sarebbe stato a carico di uno dei tanti Veterans Hospital. Qui da noi è alla deriva del mondo. In poche ore è stato caricato e scaricato dal PS Fratta, dal PS di Aversa, è passato per Giugliano, e viene ora ad esplodere a Pozzuoli. Qui, stanotte, davanti a me. Chissà se ha sostanze stupefacenti in corpo. Il fratello sostiene che ha utilizzato cocaina. Mi affronta, si avvicina, cerco di rimanere calmo, ma non lo sono, mi ergo in piedi. Allargo le braccia. Sono pronto a prendere un colpo. Dichiara di volersene andare, pensa di avere il controllo della situazione, ignora che è stato emesso un TSO. Sono fermo. Come di fronte ad un animale che sta per balzarmi addosso. Ci guardiamo negli occhi. Forse capisce, in quell’attimo, che io non recederò, che non ha scampo. Qualcosa, non so cosa, lo dissuade dall’aggredirmi. Tenta di sollevare la scrivania con il computer, lo freddo con un urlo, dopodiché, invece di agreddirmi, mi sputa addosso e si fionda verso la porta. Intimo ai carabinieri di bloccarlo e così lo afferrano, uno avanti e uno dietro. Scalcia con tutta la forza, sfonda la porta. Mi aggredisce verbalmente dicendomi di tutto. Passano attimi lunghissimi. Si sente il suo urlo prima acuto, poi duro e gutturale, poi soffocato. Aggiro la massa laocoontica e gli afferro un piede. La porta è aperta. Qualcuno afferra l’altro piede. Lo portiamo in reparto, si lascia lentamente andare sul letto. Si lascia mettere le fascette. Solo quando possediamo il totale controllo motorio il paziente si lascia andare. Allora implora. Gi prude il naso all’ala destra. Mi colpisce la dolcezza e la serenità con cui gli infermieri lo contengono. Daniela gli gratta anche la narice destra. Chiede di non spegnere la luce dice che ha paura. In quel momento i miei nervi cedono e gli urlo che se avesse evitato di agitarsi noi avremmo evitato di legarlo. Mi rendo conto dell’inutilità del mio intervento. Ma mi serve per far defluire la tensione parossistica che è salita. Lo facciamo bere. Ci spostiamo di la. La stanza dei medici è a soqquadro e il pannello della porta è completamente sfondato. Il fratello mi dice che ha distrutto la casa due volte e che non è stato facile ricoverarlo. Sentiva la voce della madre morta che gli imponeva di fare terra bruciata. Ha chiamato i carabinieri due volte. E’ passato per tre pronto soccorsi che lo hanno di fatto scaricato. Vuole querelare tutti. E’ finito qui. Dove non diciamo di no a nessuno. Lo hanno permato prima della partenza per il nord. Dove, su un monte sacro, andava ad incontrarsi con l’apparizione della madre. Tra la roba del paziente, lasciata dai familiari, mi colpisce una bottiglia di profumo, è il Sauvage.
Lo stesso che uso io.
Dopo circa due settimane di ricovero dimetto il paziente, che mi chiede, andando via, un bracciale di cuoio che ho al polso. Glielo dono. Ci reincontreremo?
Maggio 2016
HO INGOIATO UNA STILO
Carcere femminile. Filomena ha ingoiato una stilo. Una batteria stilo. L’ha ingoiata e poi ha chiamato soccorso. Tutti si mobilitano. Viene trasferita con il blindato al pronto soccorso del vicino ospedale. La rx conferma. Una stilo nell’intestino. La gastroscopia non riesce a intercettarla. Si preparano per l’intervento. Filomena, alle cui gruda prima nessuno prestava attenzione, adesso ha intorno il livello di massima allerta dell’emergenza sanitaria. Firma. Si alza dal letto operatorio. Chiede 24 ore di tempo. E’ convinta che la espellerà con le feci. Di fronte alla sua lucida determinazione l’apparato recede. Non ci sono le condizioni per intervenire. La paziente non è in immediato pericolo di vita. I suoi parametri vitali sono buoni. Filomena è una tosta. E’, nel linguaggio del carcere, un masculillo. Capelli corti, tarchiata, cicatrici ovunque sul corpo. E’ un’esperta di self-cutting. E’ capace di tagliarsi con qualunque superficie. E’ capace di far diventare tagliente qualunque superficie al contatto con il suo corpo. L’ho vista tante volte. Ci ho lavorato anche nel gruppo. Una volta, nel gruppo, disse : “Non mi sono tagliata per quella frase che mi avete detto voi”. Non ricordavo cosa le avessi detto. Me lo chiarì in un altro gruppo. “ Nella vostra stanza c’era al muro l’immagine del Vesuvio, mi avete detto che io ero così, un vulcano. E che se esplodevo trascinavo tutti nella mia eruzione. Quando stavo male pensavo a quella immagine. Mi ha dato la forza di non scoppiare”. Effettivamente i sui tagli si erano ridotti, forse perché aveva trovato il suo amore. Poi erano state separate. Nella cella le altre detenute non tolleravano le effusioni notturne, il clima che si crea quando in una cella tra due si crea un gruppo. S
Due persone che stanno insieme, tra dieci che sono divise, sono uan forza. C’erano state lagnanze, qualche delazione e Filomena era stata separata dal suo amore. Quella stilo l’avrebbe riportata al suo amore. Dopo dodici ore Filomena la recuperò nella cacca e la portò all’infermeria. Intanto è arrivata la disposizione che poteva essere riunita alla sua amica. Ora stavano insieme in un’altra cella. Le ho raccomandato di non eccedere e di fare le cose con calma. Mi colpiva, esaminando i referti clinici e le indagini strumentali, il percorso di quella stilo, perfettamente tracciata dentro i visceri di Filomena, dalla bocca all’ano. Diversamente dai suoi sentimenti. Alla fine ha vinto Filomena, perché il vulcano vince sempre. Che cosa ho fatto io, psichiatra, in questa situazione? Non lo so, so che nella Freccia rossa che mi porta a Milano, sul tavolino vedo una stilo, forse scarica, lasciata li da chissà chi. Sfuggita al personale di pulizia. E ripenso a Filomena, Alla forza di una stilo. Alla forza di un amore.








