“FOLLIA ANTIFASCISTA”. Una doppia recensione per il 25 Aprile
25 aprile, 2018 - 10:02

Editore:
Anno:
Pagine:
Costo:
In un’intervista che mi è stata fatta dallo storico Francesco Paolella a margine della pubblicazione del libro La guerra dentro[i], apparsa sul periodico culturale emiliano Pollicino Gnus, affermavo che l’internamento manicomiale fu utilizzato dal fascismo per la repressione del dissenso politico solo in casi “probabilmente eccezionali”. Partirò da questa affermazione perché in apertura della monografia molto ben documentata e originale che Marco Rossi dedica al tema, una delle due delle quali ci occupiamo per questo 25 aprile, l’autore manifesta - con un garbo e una stima dei quali lo ringrazio - le sue perplessità rispetto ad essa. Che, del resto, sembrerebbe proprio smentita dal fatto che sei anni dopo siano stati pubblicati ben due libri su questo, evidentemente non così trascurabile, argomento ed entrambi portino in modo inoppugnabile nomi e cognomi di soggetti schedati come antifascisti e finiti per qualche ragione internati in manicomio negli anni del regime.
E’ possibile che mi sia sbagliato? Senz’altro, anzi dicevo appunto “probabilmente” perché non avevo avuto la possibilità di accedere a documenti di polizia o manicomiali, come invece gli autori dei due volumi, a suffragio della mia affermazione. Peraltro, è anche vero che se riferiamo l’“eccezionalità” di cui parlavo alla totalità degli internamenti in quegli anni o alla totalità dei provvedimenti repressivi adottati dal regime, mi pare che l’uso dell’internamento manicomiale nel caso di soggetti schedati come antifascisti non fosse certo la regola.
Ma dietro questa questione, in realtà, mi pare ce ne sia un’altra, ed è se l’internamento manicomiale sia stato uno strumento abituale, tra altri, di repressione per il fascismo (o, ci si potrebbe chiedere, lo sia nel caso di altri regimi autoritari). è possibile, certo, ma di motivi per i quali potremmo ritrovare un soggetto schedato in manicomio ce ne potrebbero essere anche altri; e, d’altra parte, per la repressione della maggioranza degli oppositori del fascismo non è stata utilizzata la psichiatria, né d’altra parte la maggioranza degli internati di quegli anni era schedata come antifascista.
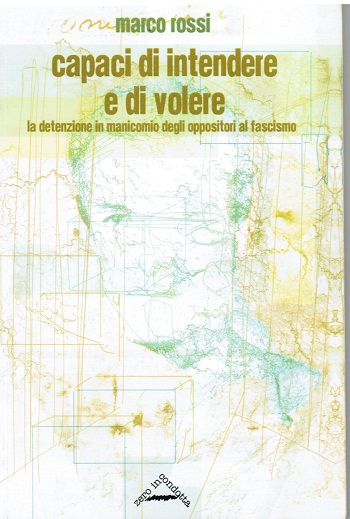 Un altro possibile motivo che vorrei considerare, ha a che fare coi confini della psichiatria, speculari ovviamente a quelli della malattia mentale. Perché la questione diventa delicata quando il discorso dal nucleo fondante della disciplina (allucinazioni, deliri, alterazioni grossolane dell’umore) si sposta sugli impulsi, gli istinti, la volontà, la personalità, il comportamento nel campo delle questioni centrali della politica: il rapporto individuo/massa, la proprietà privata o collettiva, il sesso. Qualche esempio. Se una ragazza ha un comportamento sessuale promiscuo, diremo che è una ragazza alla quale, semplicemente, piace il sesso, oppure cominceremo a cogliervi i sintomi di un disturbo del controllo degli impulsi, di una personalità borderline, o addirittura la tendenza alla promiscuità che caratterizza lo stato maniacale? E’ evidente che ciò dipende dal fatto che una società condivida serenamente l’idea che in talamo omnia licet e che in materia di sesso tutto è sano, o quella che esiste un comportamento sessuale “normale” (ad esempio eterosessuale e monogamico) e che al di fuori di esso si è nella devianza, ed eventualmente nella patologia. Ma lo stesso potrà valere per la proprietà privata: un giovane che abbia tendenza ad appropriarsi delle cose altrui per bisogno o desiderio, in una società che fa della proprietà un suo pilastro sarà imprigionato come ladro ma, qualora la pena non dimostri deterrenza e il fatto si ripeta e si ripeta, e quello proprio non la capisca e non si penta, a qualcuno verrà prima poi in mente di classificarlo come affetto da impulsività sfrenata o disturbo antisociale. Specularmente, in una società nella quale si condivide l’idea che l’individuo debba sacrificare il suo interesse materiale e l’autonomia di sentimento e pensiero a un’istanza collettiva cui appartiene (la patria, o la classe), a chi resiste potrà capitare di essere considerato affetto da egoismo patologico, disturbo narcisistico o asocialità, almeno. Ogni società, insomma, nel momento in cui restringe il concetto di ciò che è normale, produce un surplus di malattia mentale in riferimento a valori che sono rifiutati. Lo dimostra molto bene, tra l’altro, Marco Rossi ripercorrendo il pensiero psico-politico di Lombroso nella sua relazione con l’autoritarismo della società liberale italiana prefascista.
Un altro possibile motivo che vorrei considerare, ha a che fare coi confini della psichiatria, speculari ovviamente a quelli della malattia mentale. Perché la questione diventa delicata quando il discorso dal nucleo fondante della disciplina (allucinazioni, deliri, alterazioni grossolane dell’umore) si sposta sugli impulsi, gli istinti, la volontà, la personalità, il comportamento nel campo delle questioni centrali della politica: il rapporto individuo/massa, la proprietà privata o collettiva, il sesso. Qualche esempio. Se una ragazza ha un comportamento sessuale promiscuo, diremo che è una ragazza alla quale, semplicemente, piace il sesso, oppure cominceremo a cogliervi i sintomi di un disturbo del controllo degli impulsi, di una personalità borderline, o addirittura la tendenza alla promiscuità che caratterizza lo stato maniacale? E’ evidente che ciò dipende dal fatto che una società condivida serenamente l’idea che in talamo omnia licet e che in materia di sesso tutto è sano, o quella che esiste un comportamento sessuale “normale” (ad esempio eterosessuale e monogamico) e che al di fuori di esso si è nella devianza, ed eventualmente nella patologia. Ma lo stesso potrà valere per la proprietà privata: un giovane che abbia tendenza ad appropriarsi delle cose altrui per bisogno o desiderio, in una società che fa della proprietà un suo pilastro sarà imprigionato come ladro ma, qualora la pena non dimostri deterrenza e il fatto si ripeta e si ripeta, e quello proprio non la capisca e non si penta, a qualcuno verrà prima poi in mente di classificarlo come affetto da impulsività sfrenata o disturbo antisociale. Specularmente, in una società nella quale si condivide l’idea che l’individuo debba sacrificare il suo interesse materiale e l’autonomia di sentimento e pensiero a un’istanza collettiva cui appartiene (la patria, o la classe), a chi resiste potrà capitare di essere considerato affetto da egoismo patologico, disturbo narcisistico o asocialità, almeno. Ogni società, insomma, nel momento in cui restringe il concetto di ciò che è normale, produce un surplus di malattia mentale in riferimento a valori che sono rifiutati. Lo dimostra molto bene, tra l’altro, Marco Rossi ripercorrendo il pensiero psico-politico di Lombroso nella sua relazione con l’autoritarismo della società liberale italiana prefascista.
Ma non è l’unico motivo alternativo che viene alla mente; un altro sta nel fatto che in una società rigida, autoritaria, chi dissente si trova più frequentemente a compiere azioni che potranno più facilmente essere sanzionate come dissenso politico quando sono espressione di un’opposizione organizzata, un’associazione e un progetto; ma che possono prestarsi invece di più a una lettura in termini di patologia quando rappresentano l’urlo solitario e disperato dell’individuo. A chi alla parata di migliaia di persone riunite per osannare la patria in guerra esplodesse ad urlare “W la pace” potrà certo capitare di essere represso come disfattista, fautore del disordine o nemico del popolo e prendersi una scarica di manganellate. Ma a qualcuno, anche qui, potrà venire in mente che, di fronte alla consapevolezza del carattere minoritario del proprio pensiero, perdente della propria azione e alla certezza della punizione, questo gesto possa essere considerato privo di senso, e quindi il segno di una patologia, diciamo pure dissociativa, il segno cioè di un alterato sentimento della realtà, o forse maniacale. O magari il segno di una “mania politica” - così si trova a volte scritto nelle schede del Casellario Politico Centrale - tanto la possibilità stessa del dissenso diviene inconcepibile in un regime autoritario, al di fuori della follia. Il dissenso, insomma, può essere alternativamente temuto come nemico, o può meravigliare come folle a seconda di come si presenta e come viene recepito. Ma come hai potuto disobbedire alla mamma che ti ha dato la vita, e rimanere incinta prima del matrimonio? Ma come puoi disobbedire al Papa, che è il rappresentante di Cristo, che è morto per noi, sulla terra e pensare che Maria non fosse vergine? Ma come puoi disobbedire al Duce che vuole così bene agli italiani, ha creato l’ONMI, ci ha dato l’impero e ha dato all’Italia il peso che le spetta tra le grandi nazioni? Impossibile…. A meno che: mania politica, appunto!
Un altro motivo ancora, poi, è che chi dissente è sottoposto a stress continuo: il controllo soffocante della polizia, le minacce e la violenza dello squadrismo nel nostro caso, il rischio di trovarsi kafkianamente oggetto di accuse eventualmente pretestuose in tribunale, i periodi più o meno lunghi trascorsi in carcere o al confino e l’eventuale tortura, l’isolamento autoimposto per la preoccupazione di non compromettere altri, la difficoltà a proseguire, in queste condizioni, una vita famigliare e lavorativa normale (cfr. Rossi, p. 26). Il sentimento costante d’ingiustizia e i momenti nei quali il potere sembra invincibile e a prevalere sono sfiducia, disperazione, scoramento. E in questa condizione il rischio è che la mente cominci effettivamente a cedere. Dicevo, altrove, a proposito del caso del sindacalista emiliano Giuseppe Massarenti della difficoltà che può incontrare uno psichiatra, anche in sé onesto, a fare diagnosi di fenomeni paranoicali in chi si trova a vivere, da anni, oggettivamente vittima di una persecuzione reale e magari può, inevitabilmente, cominciare ad avvertirla anche dove non è.
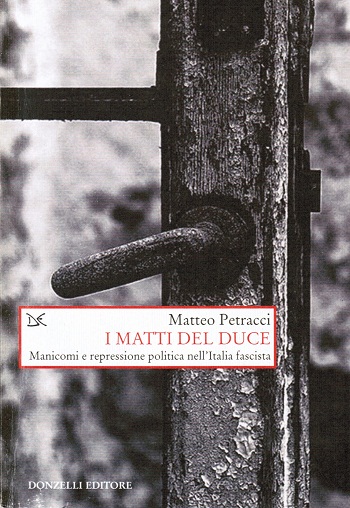 Senza considerare poi il fatto che nel caso di qualcuno la scelta di considerarlo folle da parte dello psichiatra di turno possa essere un modo pietoso di cercare di sottrarlo a una punizione. E per qualcun altro, tra le vittime, il fatto di presentarsi come folle possa essere, ugualmente, un modo per tentare di sottrarvisi.
Senza considerare poi il fatto che nel caso di qualcuno la scelta di considerarlo folle da parte dello psichiatra di turno possa essere un modo pietoso di cercare di sottrarlo a una punizione. E per qualcun altro, tra le vittime, il fatto di presentarsi come folle possa essere, ugualmente, un modo per tentare di sottrarvisi.
Perciò, per queste varie ragioni, io credo che si debba andare piano nell’ascrivere tout-court l’internamento di soggetti dissidenti a un disegno consapevole del potere di utilizzare la psichiatria come braccio ausiliario della repressione, in questo come in altri casi: le vie che possono portare un oppositore in manicomio sotto un regime autoritario/totalitario sono tante (e tutte fanno riflettere, naturalmente). E un regime autoritario/totalitario - con buona pace dei goffi tentativi di Lombroso di offrire consulenza e servigi all’autoritarismo dell’Italia liberale dei suoi anni - dispone di ben altri strumenti (manganello, carcere, confino, campo d’internamento, al limite omicidio politico) ai quali, infatti, con frequenza infinitamente maggiore ricorre, e per lo più credo tenda a non prendere molto sul serio le elucubrazioni degli psichiatri. Perciò, per solito il regime può fare a meno di noi[ii].
E la psichiatria può essere asservita, umiliata come altri settori della vita sociale e utilizzata quando sembra particolarmente utile destituire di dignità la posizione del nemico anziché combatterlo a viso aperto, o in casi particolari quando la si può usare per “fare sparire” qualcuno (è il caso della Dalser o di Sante, come vedremo, che più che oppositori sono fantasmi scomodi emersi dal passato del duce). Altre volte, la possibilità di fare sì che il dissenso assuma, per così dire, la forma della psicopatologia è un rischio che sta dentro la natura stessa del regime autoritario/totalitario per le tre ragioni che proponevo: che l’area del “normale” si stringe e si irrigidisce sulla base di valori che si pretendono universalmente condivisi; che l’espressione del dissenso può apparire irragionevole se giudicata in base alla meccanica degli interessi; e che la vita stessa alla quale l’oppositore è costretto può costituire in sé un fattore di rischio per il suo compenso mentale. Ma su un punto credo senz’altro che Rossi abbia ragione: che tutte queste questioni sono certo più macroscopicamente visibili nel regime autoritario/totalitario, ma nessuna forma di convivenza organizzata che implichi un rapporto tra potere e individuo, democrazie liberali comprese, può certo considerarsene immune (p. 15).
Al di là comunque di quali ne siano le dimensioni e le ragioni, il fenomeno dell’internamento manicomiale è qualitativamente importante perché è attinente a questioni relative ai fondamenti e ai confini della psichiatria e alla sua relazione col potere, e credo sia perciò un fatto molto positivo che due studiosi, parrebbe di capire operando per linee del tutto indipendenti uno dall’altro tanto che reciprocamente non si citano, abbiano scelto di rendere contemporaneamente pubblico il risultato delle loro ricerche in questo campo. Dei due testi uno solo è correlato di data completa di pubblicazione, e quindi non è possibile stabilirne la successione temporale; li affronterò pertanto in ordine alfabetico: prima Capaci di intendere e poi I matti del duce.
Il testo di Marco Rossi comincia con il ripercorrere la storia della relazione tra manicomio e repressione politica a partire dall’Italia prefascista, i casi di illustri briganti periziati e internati, quello poco noto di ex garibaldini (p. 14), quello di renitenti e disertori nel corso della Grande guerra (pp. 21-23). Passa poi a considerare i 473 casi (1.06%) d’internamento psichiatrico, per lo più in manicomio criminale, che risultano tra 44.540 casi di antifascisti schedati presso il Casellario Politico Centrale e recentemente pubblicati.
Alcuni casi individuali presentati da Rossi sono davvero d’immenso interesse. Il primo è quello di Giovanni Corvi, reo di avere assassinato il deputato fascista Armando casalini con l’intenzione di vendicare Matteotti, internato in manicomio a Roma, poi in manicomio criminale, inviato al confino, liberato nel settembre ’43, nuovamente internato in un campo, prelevato dalla polizia tedesca e poi misteriosamente deceduto. Riprendendo la classificazione originale che Rossi mantiene, tra gli anarchici troviamo Antonio D’Alba e Augusto Masetti, che commisero reati precedentemente al 1922, e poi tra tanti spicca Argo Secondari, fondatore degli Arditi del popolo, ferito al capo da un’aggressione fascista e rimasto poi definitivamente in manicomio. Il secondo gruppo che incontriamo per numero sono i comunisti, cui seguono a distanza socialisti (tra i quali spicca il caso di Giuseppe Massarenti) e repubblicani. Antifascisti e sovversivi senza indicazione di partito sono il gruppo più numeroso di tutti, tra i quali troviamo molti autori di vilipendio del regime od “offesa al Duce”, un reato specifico introdotto nel 1925. Ma non mancano anche in questa categoria soggetti affetti da turbe nervose o mentali conseguenti a violenza perpetrata dagli squadristi o durante interrogatori di polizia. Tra le “donne degeneri” spiccano, tra tante piccole vicende commuoventi, il caso di Violet Gibson, l’irlandese che aveva niente meno che ferito Mussolini al naso nel tentativo di ucciderlo, internata al S. Maria della Pietà e rapidamente espulsa in Gran Bretagna dove rimase poi sempre in manicomio, e quello, reso nota qualche anno fa dal film Vincere, di Ida Dalser che fu la compagna (e forse moglie) che aveva dato un figlio al giovane Mussolini. Si tratta in molti casi di soggetti originariamente destinati al carcere o al confino, e successivamente spostati in manicomio per problemi sopravvenuti; in alcuni casi vi morirono, a volte in dubbie circostanze. L’ultimo capitolo, e la postfazione di Angelo Pagliaro centrata sul caso Mastrogiovanni, sono dedicati alle modalità con le quali, dopo il fascismo, le questione affrontate si sono riproposte. Voleva “frugare sotto la polvere della Storia in cerca di vite inestimabili”, insomma, Marco Rossi; e possiamo dire che c’è pienamente riuscito.
Quanto al testo di Petracci, esso affronta lo stesso tema riferendosi a un ventaglio di fonti più ampie, comprese le cartelle manicomiali e le lettere personali, e ripercorre a sua volta i rischi dell’osmosi tra psichiatria e politica a partire dai tentativi di patologizzazione del marxismo e della democrazia, citando tra gli esempi oltre a meno noti psichiatri italiani lo spagnolo Antonio Vallejo Nagera impegnato in ricerche tra militanti delle brigate internazionali sulla “biopsicologia del fanatismo marxista”, o a sostenere che solo individui inferiori mentalmente avrebbero potuto cercare soddisfazione nei beni materiali offerti dal marxismo o dalla democrazia (p. 9).
Anche in questo caso sono molte le storie commuoventi che Petracci raccoglie tra manicomio, manicomio criminale, confino e carcere, storie di persone; storie di modesti eroi del quotidiano al cui coraggio e alle cui sofferenze patite dobbiamo oggi la libertà. Sono emblematiche, tra davvero tante, oltre ad alcune già ricordate a proposito del testo di Rossi, le vicende di Secondo Biamonti o di Sante, un amico di Mussolini giovane che avrebbe potuto forse poi comprometterlo, provò a ricattarlo e tanto bastò per un internamento di comodo; o quella di Rossano, un giovane comunista al quale gli psichiatri diagnosticarono con il “pletismografo” la schizofrenia, e solo con ciò lo condannarono a vita al manicomio (p. 80); o quella di Laura, comunista anch’essa, cui furono diagnosticati durante la detenzione disturbi neuropatici dopo che aveva subito, come avrebbe detto in seguito, “tante torture quasi da impazzire” (pp. 107-119).
Il testo documenta la duplice violenza del manicomio fascista verso costoro, internati e antifascisti, e quella, al suo interno, dei luoghi speciali loro riservati, come il triste padiglione XVIII del S. Maria della Pietà. I dubbi su certi suicidi e morti sospette nel manicomio criminale o nel carcere. La durezza, fatta di quotidiane angherie e umiliazioni, dell’esperienza del confino. Il sentimento tremendo di essere del tutto in balia d’altri, che possono “fare di me quello che vogliono” (p. 172). Le brutalità; è impressionante la testimonianza di un detenuto celebre, Sandro Pertini (p. 159), sulla pratica in carcere del Sant’Antonio”, pestaggio o bastonatura che poteva in quegli anni essere a morte. Le “raffiche improvvise di follia assurda e infantile” (p. 152) di cui parla Antonio Gramsci a proposito dell’esperienza detentiva degli intellettuali, meno capaci di adattamento e sopportazione rispetto al popolo, quelli la cui mente può cedere, almeno per un attimo, più facilmente allo sforzo. E documenta anche atti di coraggio, come quando un gruppo di antifascisti insorge contro l’uso della contenzione su un condetenuto a scopo punitivo (p. 165). O persino attimi di dolcezza, che dobbiamo ancora alla penna di Laura: “vi è una giovane madre con una piccola lattante di otto mesi che attira veramente compassione, quante volte il nostro tozzo di pane lo passiamo a lei, per quell’adorabile creatura. E dire che ci accusano di comunismo, qui dentro si impara a diventarlo” (p. 115).
Gli psichiatri appaiono, talvolta, vergognosamente complici. Altre no, e tra i colleghi dei quali possiamo sentirci orgogliosi Petracci allunga la serie di coloro ai quali ho cercato di restituire giusta memoria nel 2008 con:Luigi Baroncini, direttore a Imola, Giulio Agostini, direttore a Perugia, Emilio Mancini, psichiatra al manicomio di Ancona e partigiano (pp. 220-222)[iii]. E altri speriamo possano esserne aggiunti in futuro. In questi giorni, la Società di Psichiatria sta giustamente ricordando con una mostra a Roma fatti esecrabili della nostra storia, e di quella della psichiatria tedesca[iv]. Chissà che non si possa un giorno, tra storici e psichiatri, promuovere una ricerca più capillare per recuperare il ricordo di quanti, nel dolore e nel pericolo della tirannia e della guerra, hanno avuto la forza e il coraggio di comportarsi bene e sono stati poi dimenticati.
Il testo di Petracci si chiude, infine, con una frase destinata a creare imbarazzo per la psichiatria: ci si chiede perché, infatti, per alcuni come Massarenti o Biamonti, ricoverati fino al giorno prima come malati con diagnosi e terapia, al cambiamento politico della liberazione sia miracolosamente corrisposto quello clinico della guarigione. Una domanda seria, credo, che dovrebbe porre a noi psichiatri molti dubbi.
P.S.: Buon 25 aprile!!!!
E’ possibile che mi sia sbagliato? Senz’altro, anzi dicevo appunto “probabilmente” perché non avevo avuto la possibilità di accedere a documenti di polizia o manicomiali, come invece gli autori dei due volumi, a suffragio della mia affermazione. Peraltro, è anche vero che se riferiamo l’“eccezionalità” di cui parlavo alla totalità degli internamenti in quegli anni o alla totalità dei provvedimenti repressivi adottati dal regime, mi pare che l’uso dell’internamento manicomiale nel caso di soggetti schedati come antifascisti non fosse certo la regola.
Ma dietro questa questione, in realtà, mi pare ce ne sia un’altra, ed è se l’internamento manicomiale sia stato uno strumento abituale, tra altri, di repressione per il fascismo (o, ci si potrebbe chiedere, lo sia nel caso di altri regimi autoritari). è possibile, certo, ma di motivi per i quali potremmo ritrovare un soggetto schedato in manicomio ce ne potrebbero essere anche altri; e, d’altra parte, per la repressione della maggioranza degli oppositori del fascismo non è stata utilizzata la psichiatria, né d’altra parte la maggioranza degli internati di quegli anni era schedata come antifascista.
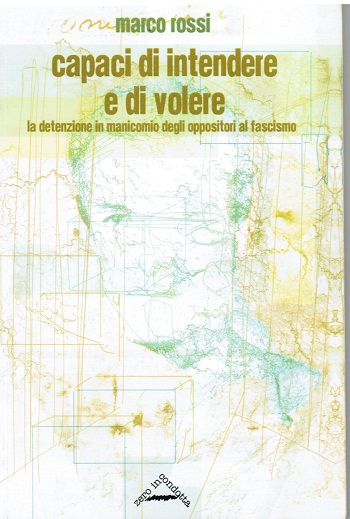 Un altro possibile motivo che vorrei considerare, ha a che fare coi confini della psichiatria, speculari ovviamente a quelli della malattia mentale. Perché la questione diventa delicata quando il discorso dal nucleo fondante della disciplina (allucinazioni, deliri, alterazioni grossolane dell’umore) si sposta sugli impulsi, gli istinti, la volontà, la personalità, il comportamento nel campo delle questioni centrali della politica: il rapporto individuo/massa, la proprietà privata o collettiva, il sesso. Qualche esempio. Se una ragazza ha un comportamento sessuale promiscuo, diremo che è una ragazza alla quale, semplicemente, piace il sesso, oppure cominceremo a cogliervi i sintomi di un disturbo del controllo degli impulsi, di una personalità borderline, o addirittura la tendenza alla promiscuità che caratterizza lo stato maniacale? E’ evidente che ciò dipende dal fatto che una società condivida serenamente l’idea che in talamo omnia licet e che in materia di sesso tutto è sano, o quella che esiste un comportamento sessuale “normale” (ad esempio eterosessuale e monogamico) e che al di fuori di esso si è nella devianza, ed eventualmente nella patologia. Ma lo stesso potrà valere per la proprietà privata: un giovane che abbia tendenza ad appropriarsi delle cose altrui per bisogno o desiderio, in una società che fa della proprietà un suo pilastro sarà imprigionato come ladro ma, qualora la pena non dimostri deterrenza e il fatto si ripeta e si ripeta, e quello proprio non la capisca e non si penta, a qualcuno verrà prima poi in mente di classificarlo come affetto da impulsività sfrenata o disturbo antisociale. Specularmente, in una società nella quale si condivide l’idea che l’individuo debba sacrificare il suo interesse materiale e l’autonomia di sentimento e pensiero a un’istanza collettiva cui appartiene (la patria, o la classe), a chi resiste potrà capitare di essere considerato affetto da egoismo patologico, disturbo narcisistico o asocialità, almeno. Ogni società, insomma, nel momento in cui restringe il concetto di ciò che è normale, produce un surplus di malattia mentale in riferimento a valori che sono rifiutati. Lo dimostra molto bene, tra l’altro, Marco Rossi ripercorrendo il pensiero psico-politico di Lombroso nella sua relazione con l’autoritarismo della società liberale italiana prefascista.
Un altro possibile motivo che vorrei considerare, ha a che fare coi confini della psichiatria, speculari ovviamente a quelli della malattia mentale. Perché la questione diventa delicata quando il discorso dal nucleo fondante della disciplina (allucinazioni, deliri, alterazioni grossolane dell’umore) si sposta sugli impulsi, gli istinti, la volontà, la personalità, il comportamento nel campo delle questioni centrali della politica: il rapporto individuo/massa, la proprietà privata o collettiva, il sesso. Qualche esempio. Se una ragazza ha un comportamento sessuale promiscuo, diremo che è una ragazza alla quale, semplicemente, piace il sesso, oppure cominceremo a cogliervi i sintomi di un disturbo del controllo degli impulsi, di una personalità borderline, o addirittura la tendenza alla promiscuità che caratterizza lo stato maniacale? E’ evidente che ciò dipende dal fatto che una società condivida serenamente l’idea che in talamo omnia licet e che in materia di sesso tutto è sano, o quella che esiste un comportamento sessuale “normale” (ad esempio eterosessuale e monogamico) e che al di fuori di esso si è nella devianza, ed eventualmente nella patologia. Ma lo stesso potrà valere per la proprietà privata: un giovane che abbia tendenza ad appropriarsi delle cose altrui per bisogno o desiderio, in una società che fa della proprietà un suo pilastro sarà imprigionato come ladro ma, qualora la pena non dimostri deterrenza e il fatto si ripeta e si ripeta, e quello proprio non la capisca e non si penta, a qualcuno verrà prima poi in mente di classificarlo come affetto da impulsività sfrenata o disturbo antisociale. Specularmente, in una società nella quale si condivide l’idea che l’individuo debba sacrificare il suo interesse materiale e l’autonomia di sentimento e pensiero a un’istanza collettiva cui appartiene (la patria, o la classe), a chi resiste potrà capitare di essere considerato affetto da egoismo patologico, disturbo narcisistico o asocialità, almeno. Ogni società, insomma, nel momento in cui restringe il concetto di ciò che è normale, produce un surplus di malattia mentale in riferimento a valori che sono rifiutati. Lo dimostra molto bene, tra l’altro, Marco Rossi ripercorrendo il pensiero psico-politico di Lombroso nella sua relazione con l’autoritarismo della società liberale italiana prefascista.Ma non è l’unico motivo alternativo che viene alla mente; un altro sta nel fatto che in una società rigida, autoritaria, chi dissente si trova più frequentemente a compiere azioni che potranno più facilmente essere sanzionate come dissenso politico quando sono espressione di un’opposizione organizzata, un’associazione e un progetto; ma che possono prestarsi invece di più a una lettura in termini di patologia quando rappresentano l’urlo solitario e disperato dell’individuo. A chi alla parata di migliaia di persone riunite per osannare la patria in guerra esplodesse ad urlare “W la pace” potrà certo capitare di essere represso come disfattista, fautore del disordine o nemico del popolo e prendersi una scarica di manganellate. Ma a qualcuno, anche qui, potrà venire in mente che, di fronte alla consapevolezza del carattere minoritario del proprio pensiero, perdente della propria azione e alla certezza della punizione, questo gesto possa essere considerato privo di senso, e quindi il segno di una patologia, diciamo pure dissociativa, il segno cioè di un alterato sentimento della realtà, o forse maniacale. O magari il segno di una “mania politica” - così si trova a volte scritto nelle schede del Casellario Politico Centrale - tanto la possibilità stessa del dissenso diviene inconcepibile in un regime autoritario, al di fuori della follia. Il dissenso, insomma, può essere alternativamente temuto come nemico, o può meravigliare come folle a seconda di come si presenta e come viene recepito. Ma come hai potuto disobbedire alla mamma che ti ha dato la vita, e rimanere incinta prima del matrimonio? Ma come puoi disobbedire al Papa, che è il rappresentante di Cristo, che è morto per noi, sulla terra e pensare che Maria non fosse vergine? Ma come puoi disobbedire al Duce che vuole così bene agli italiani, ha creato l’ONMI, ci ha dato l’impero e ha dato all’Italia il peso che le spetta tra le grandi nazioni? Impossibile…. A meno che: mania politica, appunto!
Un altro motivo ancora, poi, è che chi dissente è sottoposto a stress continuo: il controllo soffocante della polizia, le minacce e la violenza dello squadrismo nel nostro caso, il rischio di trovarsi kafkianamente oggetto di accuse eventualmente pretestuose in tribunale, i periodi più o meno lunghi trascorsi in carcere o al confino e l’eventuale tortura, l’isolamento autoimposto per la preoccupazione di non compromettere altri, la difficoltà a proseguire, in queste condizioni, una vita famigliare e lavorativa normale (cfr. Rossi, p. 26). Il sentimento costante d’ingiustizia e i momenti nei quali il potere sembra invincibile e a prevalere sono sfiducia, disperazione, scoramento. E in questa condizione il rischio è che la mente cominci effettivamente a cedere. Dicevo, altrove, a proposito del caso del sindacalista emiliano Giuseppe Massarenti della difficoltà che può incontrare uno psichiatra, anche in sé onesto, a fare diagnosi di fenomeni paranoicali in chi si trova a vivere, da anni, oggettivamente vittima di una persecuzione reale e magari può, inevitabilmente, cominciare ad avvertirla anche dove non è.
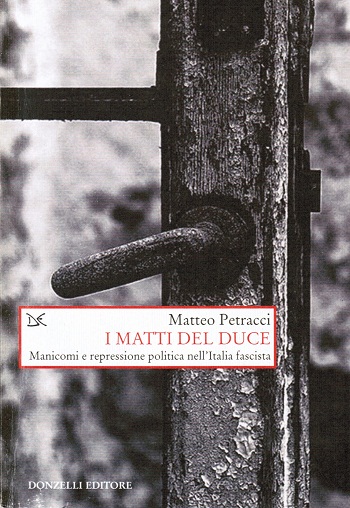 Senza considerare poi il fatto che nel caso di qualcuno la scelta di considerarlo folle da parte dello psichiatra di turno possa essere un modo pietoso di cercare di sottrarlo a una punizione. E per qualcun altro, tra le vittime, il fatto di presentarsi come folle possa essere, ugualmente, un modo per tentare di sottrarvisi.
Senza considerare poi il fatto che nel caso di qualcuno la scelta di considerarlo folle da parte dello psichiatra di turno possa essere un modo pietoso di cercare di sottrarlo a una punizione. E per qualcun altro, tra le vittime, il fatto di presentarsi come folle possa essere, ugualmente, un modo per tentare di sottrarvisi. Perciò, per queste varie ragioni, io credo che si debba andare piano nell’ascrivere tout-court l’internamento di soggetti dissidenti a un disegno consapevole del potere di utilizzare la psichiatria come braccio ausiliario della repressione, in questo come in altri casi: le vie che possono portare un oppositore in manicomio sotto un regime autoritario/totalitario sono tante (e tutte fanno riflettere, naturalmente). E un regime autoritario/totalitario - con buona pace dei goffi tentativi di Lombroso di offrire consulenza e servigi all’autoritarismo dell’Italia liberale dei suoi anni - dispone di ben altri strumenti (manganello, carcere, confino, campo d’internamento, al limite omicidio politico) ai quali, infatti, con frequenza infinitamente maggiore ricorre, e per lo più credo tenda a non prendere molto sul serio le elucubrazioni degli psichiatri. Perciò, per solito il regime può fare a meno di noi[ii].
E la psichiatria può essere asservita, umiliata come altri settori della vita sociale e utilizzata quando sembra particolarmente utile destituire di dignità la posizione del nemico anziché combatterlo a viso aperto, o in casi particolari quando la si può usare per “fare sparire” qualcuno (è il caso della Dalser o di Sante, come vedremo, che più che oppositori sono fantasmi scomodi emersi dal passato del duce). Altre volte, la possibilità di fare sì che il dissenso assuma, per così dire, la forma della psicopatologia è un rischio che sta dentro la natura stessa del regime autoritario/totalitario per le tre ragioni che proponevo: che l’area del “normale” si stringe e si irrigidisce sulla base di valori che si pretendono universalmente condivisi; che l’espressione del dissenso può apparire irragionevole se giudicata in base alla meccanica degli interessi; e che la vita stessa alla quale l’oppositore è costretto può costituire in sé un fattore di rischio per il suo compenso mentale. Ma su un punto credo senz’altro che Rossi abbia ragione: che tutte queste questioni sono certo più macroscopicamente visibili nel regime autoritario/totalitario, ma nessuna forma di convivenza organizzata che implichi un rapporto tra potere e individuo, democrazie liberali comprese, può certo considerarsene immune (p. 15).
Al di là comunque di quali ne siano le dimensioni e le ragioni, il fenomeno dell’internamento manicomiale è qualitativamente importante perché è attinente a questioni relative ai fondamenti e ai confini della psichiatria e alla sua relazione col potere, e credo sia perciò un fatto molto positivo che due studiosi, parrebbe di capire operando per linee del tutto indipendenti uno dall’altro tanto che reciprocamente non si citano, abbiano scelto di rendere contemporaneamente pubblico il risultato delle loro ricerche in questo campo. Dei due testi uno solo è correlato di data completa di pubblicazione, e quindi non è possibile stabilirne la successione temporale; li affronterò pertanto in ordine alfabetico: prima Capaci di intendere e poi I matti del duce.
Il testo di Marco Rossi comincia con il ripercorrere la storia della relazione tra manicomio e repressione politica a partire dall’Italia prefascista, i casi di illustri briganti periziati e internati, quello poco noto di ex garibaldini (p. 14), quello di renitenti e disertori nel corso della Grande guerra (pp. 21-23). Passa poi a considerare i 473 casi (1.06%) d’internamento psichiatrico, per lo più in manicomio criminale, che risultano tra 44.540 casi di antifascisti schedati presso il Casellario Politico Centrale e recentemente pubblicati.
Alcuni casi individuali presentati da Rossi sono davvero d’immenso interesse. Il primo è quello di Giovanni Corvi, reo di avere assassinato il deputato fascista Armando casalini con l’intenzione di vendicare Matteotti, internato in manicomio a Roma, poi in manicomio criminale, inviato al confino, liberato nel settembre ’43, nuovamente internato in un campo, prelevato dalla polizia tedesca e poi misteriosamente deceduto. Riprendendo la classificazione originale che Rossi mantiene, tra gli anarchici troviamo Antonio D’Alba e Augusto Masetti, che commisero reati precedentemente al 1922, e poi tra tanti spicca Argo Secondari, fondatore degli Arditi del popolo, ferito al capo da un’aggressione fascista e rimasto poi definitivamente in manicomio. Il secondo gruppo che incontriamo per numero sono i comunisti, cui seguono a distanza socialisti (tra i quali spicca il caso di Giuseppe Massarenti) e repubblicani. Antifascisti e sovversivi senza indicazione di partito sono il gruppo più numeroso di tutti, tra i quali troviamo molti autori di vilipendio del regime od “offesa al Duce”, un reato specifico introdotto nel 1925. Ma non mancano anche in questa categoria soggetti affetti da turbe nervose o mentali conseguenti a violenza perpetrata dagli squadristi o durante interrogatori di polizia. Tra le “donne degeneri” spiccano, tra tante piccole vicende commuoventi, il caso di Violet Gibson, l’irlandese che aveva niente meno che ferito Mussolini al naso nel tentativo di ucciderlo, internata al S. Maria della Pietà e rapidamente espulsa in Gran Bretagna dove rimase poi sempre in manicomio, e quello, reso nota qualche anno fa dal film Vincere, di Ida Dalser che fu la compagna (e forse moglie) che aveva dato un figlio al giovane Mussolini. Si tratta in molti casi di soggetti originariamente destinati al carcere o al confino, e successivamente spostati in manicomio per problemi sopravvenuti; in alcuni casi vi morirono, a volte in dubbie circostanze. L’ultimo capitolo, e la postfazione di Angelo Pagliaro centrata sul caso Mastrogiovanni, sono dedicati alle modalità con le quali, dopo il fascismo, le questione affrontate si sono riproposte. Voleva “frugare sotto la polvere della Storia in cerca di vite inestimabili”, insomma, Marco Rossi; e possiamo dire che c’è pienamente riuscito.
Quanto al testo di Petracci, esso affronta lo stesso tema riferendosi a un ventaglio di fonti più ampie, comprese le cartelle manicomiali e le lettere personali, e ripercorre a sua volta i rischi dell’osmosi tra psichiatria e politica a partire dai tentativi di patologizzazione del marxismo e della democrazia, citando tra gli esempi oltre a meno noti psichiatri italiani lo spagnolo Antonio Vallejo Nagera impegnato in ricerche tra militanti delle brigate internazionali sulla “biopsicologia del fanatismo marxista”, o a sostenere che solo individui inferiori mentalmente avrebbero potuto cercare soddisfazione nei beni materiali offerti dal marxismo o dalla democrazia (p. 9).
Anche in questo caso sono molte le storie commuoventi che Petracci raccoglie tra manicomio, manicomio criminale, confino e carcere, storie di persone; storie di modesti eroi del quotidiano al cui coraggio e alle cui sofferenze patite dobbiamo oggi la libertà. Sono emblematiche, tra davvero tante, oltre ad alcune già ricordate a proposito del testo di Rossi, le vicende di Secondo Biamonti o di Sante, un amico di Mussolini giovane che avrebbe potuto forse poi comprometterlo, provò a ricattarlo e tanto bastò per un internamento di comodo; o quella di Rossano, un giovane comunista al quale gli psichiatri diagnosticarono con il “pletismografo” la schizofrenia, e solo con ciò lo condannarono a vita al manicomio (p. 80); o quella di Laura, comunista anch’essa, cui furono diagnosticati durante la detenzione disturbi neuropatici dopo che aveva subito, come avrebbe detto in seguito, “tante torture quasi da impazzire” (pp. 107-119).
Il testo documenta la duplice violenza del manicomio fascista verso costoro, internati e antifascisti, e quella, al suo interno, dei luoghi speciali loro riservati, come il triste padiglione XVIII del S. Maria della Pietà. I dubbi su certi suicidi e morti sospette nel manicomio criminale o nel carcere. La durezza, fatta di quotidiane angherie e umiliazioni, dell’esperienza del confino. Il sentimento tremendo di essere del tutto in balia d’altri, che possono “fare di me quello che vogliono” (p. 172). Le brutalità; è impressionante la testimonianza di un detenuto celebre, Sandro Pertini (p. 159), sulla pratica in carcere del Sant’Antonio”, pestaggio o bastonatura che poteva in quegli anni essere a morte. Le “raffiche improvvise di follia assurda e infantile” (p. 152) di cui parla Antonio Gramsci a proposito dell’esperienza detentiva degli intellettuali, meno capaci di adattamento e sopportazione rispetto al popolo, quelli la cui mente può cedere, almeno per un attimo, più facilmente allo sforzo. E documenta anche atti di coraggio, come quando un gruppo di antifascisti insorge contro l’uso della contenzione su un condetenuto a scopo punitivo (p. 165). O persino attimi di dolcezza, che dobbiamo ancora alla penna di Laura: “vi è una giovane madre con una piccola lattante di otto mesi che attira veramente compassione, quante volte il nostro tozzo di pane lo passiamo a lei, per quell’adorabile creatura. E dire che ci accusano di comunismo, qui dentro si impara a diventarlo” (p. 115).
Gli psichiatri appaiono, talvolta, vergognosamente complici. Altre no, e tra i colleghi dei quali possiamo sentirci orgogliosi Petracci allunga la serie di coloro ai quali ho cercato di restituire giusta memoria nel 2008 con:Luigi Baroncini, direttore a Imola, Giulio Agostini, direttore a Perugia, Emilio Mancini, psichiatra al manicomio di Ancona e partigiano (pp. 220-222)[iii]. E altri speriamo possano esserne aggiunti in futuro. In questi giorni, la Società di Psichiatria sta giustamente ricordando con una mostra a Roma fatti esecrabili della nostra storia, e di quella della psichiatria tedesca[iv]. Chissà che non si possa un giorno, tra storici e psichiatri, promuovere una ricerca più capillare per recuperare il ricordo di quanti, nel dolore e nel pericolo della tirannia e della guerra, hanno avuto la forza e il coraggio di comportarsi bene e sono stati poi dimenticati.
Il testo di Petracci si chiude, infine, con una frase destinata a creare imbarazzo per la psichiatria: ci si chiede perché, infatti, per alcuni come Massarenti o Biamonti, ricoverati fino al giorno prima come malati con diagnosi e terapia, al cambiamento politico della liberazione sia miracolosamente corrisposto quello clinico della guarigione. Una domanda seria, credo, che dovrebbe porre a noi psichiatri molti dubbi.
P.S.: Buon 25 aprile!!!!
Titolo: Capaci di intendere e di volere. La detenzione in manicomio degli oppositori del fascismo
Autore: Marco Rossi
Editore: Zero in condotta
Anno: 2014
Pagine: 92
Costo: €10.00
Titolo: I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista
Autore: Matteo Petracci
Editore: Donzelli
Anno: 2014
Pagine: 238
Costo: €33.00
[i] P.F. Peloso, La guerra dentro. La psichiatria italiana tra fascismo e resistenza (1922-1945), Verona, Ombre corte.
[ii] Rossi riporta a p. 19 la dignitosa posizione di Kropotkin e di Sante Caserio, contro le ipotesi di lettura del delitto anarchico come fatto psicopatologico volte a banalizzarne la dignità e l’importanza. E Caserio rinunciò a questa strategia difensiva nonostante fosse l’unico mezzo che gli rimaneva per sottrarsi alla ghigliottina (sulla vicenda Caserio cfr. anche: G. Vagnarelli, Fu il mio cuore a prendere il pugnale. Medicina e antropologia criminale nell’affare Caserio, Milano, Zero in condotta, 2013).
[iii] Sul tema degli psichiatri antifascisti cfr. anche in questa rubrica: 25 aprile 2016: ricordando il sacrificio di Giovanni Mercurio per la libertà degli Italiani.









Commenti
Lo stesso discorso PARO PARO vale anche per la questione della mancata depatologizzazione delle persone omosessuali che ancora sono ABUSATE dai MEDICI che ne pretendono la CURA, che di fatto diventa VIOLENZA in un sistema solo apparentemente liberale, ma che di fatto è ancora OMOFOBO e TRANSFOBO e garantisce l'omofobia e transfobia sanitaria invece di contrastarla.
Ci sono anche i COLLEGHI GAY E LESBICHE CHE SI NASCONDONO essendo terrorizzate da eventuali punizioni (familiari o lavorative) esattamente come nel periodo fascista.
NOI non abbiamo ancora avuto il nostro 25 Aprile in Sanità!
http://www.psychiatryonline.it/rubrica/4376
Grazie, credo tu abbia senz'altro ragione. L'intolleranza dei regimi autoritari/totalitari verso l'omosessualità, e la violenza particolarmente efferata del nazismo verso gli omosessuali, sono fenomeni che nella rappresentazione storica tendono a essere sottovalutati rispetto alla persecuzione di altri gruppi. E oggi, mentre credo che siano solo sparuti gruppi ad attardarsi irragionevolmente su quelle posizioni, per molti la consapevolezza della pari liceità e dignità di ogni scelta di orientamento sessuale che non crei danno ad altri rappresenta un principio cui è difficile trovare argomenti logici per non aderire, che però è difficile trasformare in sentimento autenticamente internalizzato.