Michele Risso. Lo psichiatra che negli anni ’70 curava gli psicotici gravi e congedava i nevrotici.
12 luglio, 2018 - 11:57
12 luglio, 2018 - 11:57

Riassunto. Fra i pionieri dell’etnopsichiatria un posto di assoluto rilievo in Italia e nel mondo spetta al piemontese Michele Risso, medico psichiatra, psicoterapeuta clinico, psicoanalista eterodosso. Nato a Boves (CN) nel 1927, morto prematuramente di leucemia nel 1981, ad appena 54 anni. Spirito libero, geniale, combattivo, spende generosamente la sua vita intensa e coraggiosa per appianare uno dei nodi più difficili da sciogliere nell’agire psichiatrico: come le alterità culturali possano facilmente confondersi per alienazioni mentali. Questa osservazione l’aveva fatta in area migratoria dove l’Italia ha primeggiato fino al 1974, in cui, nelle sedi internazionali europee, prevalsero stolte dichiarazioni ufficiali sulla “fine dell’immigrazione”[1]. Risso aveva lavorato in ospedali cantonali svizzeri, sapeva della miseria materiale e culturale della maggior parte della mano d’opera italiana che emigrava. Era andato a conoscere de Martino. Era informato sul micidiale potere magico del fascino e dello sfascino, nell’ambito delle culture popolari; di quanto la tradizione avesse presa in chi ci credeva, perché solo quella l’aveva cresciuto fino all’esodo migratorio. Nondimeno era convinto che quel tipo di rilettura differenziale e reciproca tra il punto di vista del “mondo del normale” e quello “della follia” andasse applicato sempre, comunque e dovunque, soprattutto sul piano dell’intersoggettività, non solo su quello dell’interculturalità. «Autoctoni o stranieri, sedentari o migranti, devi piantarti subito come frangiflutti di fronte alle loro sofferenze e ai loro problemi. Quelli che ti presentano, in quel momento e a modo loro. Tu devi cercare di capire nel più breve tempo. Altrimenti rischi di trovarteli in ospedale o in manicomio. Se ci arrivano!». Più o meno, così mi disse una volta, direttamente, senza giri di parole, com’era sua abitudine. Per questo il suo impegno nel sociale fu costante, assiduo, indefesso.
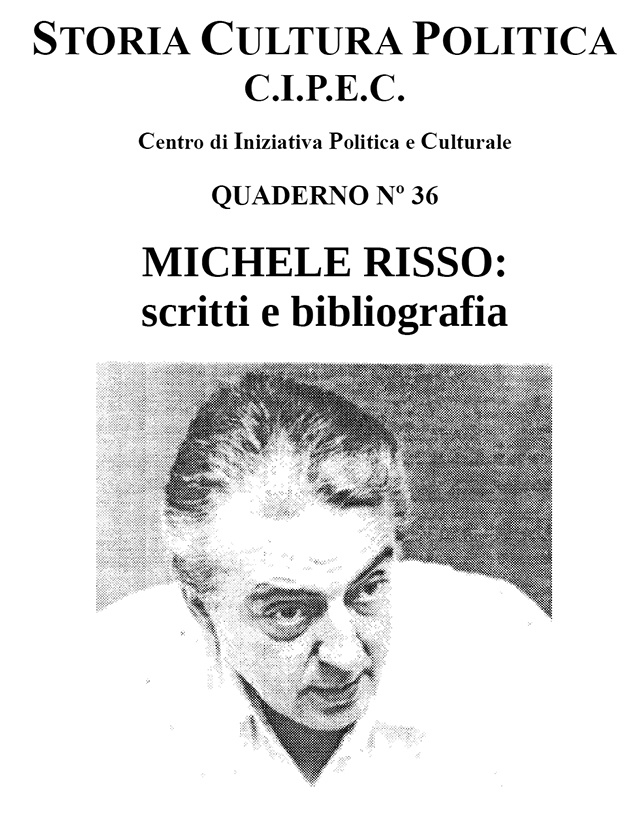
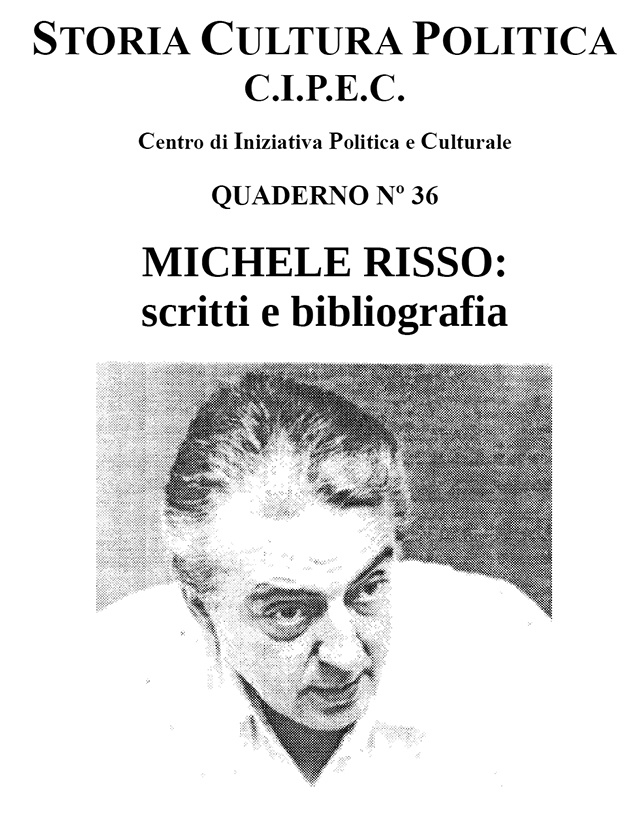
«Il trapianto nella situazione svizzera
non significa solo confrontarsi con una cultura completamente diversa,
per molti tratti perfino contraria rispetto alla propria,
ma significa anche la separazione dall’ambiente natio famigliare
e la perdita della prima naturale sicurezza»
[Michele Risso e Wolfgang Böker. Verhexungswahn (Delirio di sortilegio)].
non significa solo confrontarsi con una cultura completamente diversa,
per molti tratti perfino contraria rispetto alla propria,
ma significa anche la separazione dall’ambiente natio famigliare
e la perdita della prima naturale sicurezza»
[Michele Risso e Wolfgang Böker. Verhexungswahn (Delirio di sortilegio)].
Michele Risso, si laurea in medicina nel 1953, l’anno successivo si reca a Berna per specializzarsi nella clinica psichiatria universitaria di Waldau. La struttura gode ottima fama [2]. Nella direzione della Clinica a Jakob Kläesi (1883-1980) è appena succeduto Max Müller (1894-1980) e a fare lezione viene addirittura Jacob Wyrsch (1892-1980), fra i maggiori psicopatologi ad indirizzo antropologico e fenomenologico [3]. A proposito di Max Müller rammentiamo che per molti anni è stato il maestro indiscusso della psichiatria clinica e il caposcuola della psicoanalisi Bernese. La sua influenza come forgiatore di allievi psicoanalisti gli derivò non soltanto dalle sue eccellenti doti umane e didattiche, ma anche dal fatto di essere stato prima direttore dell’Ospedale psichiatrico di Münsingen e successivamente della Clinica psichiatrica universitaria di Waldau. La sua figura vigorosa e autorevole traspare dal romanzo Matto regiert (1936) dello scrittore viennese Friedrich Glauser (1896-1938), capitato anche a Waldau, nella sua lunga peregrinazione per manicomi.
La politica del nuovo direttore è quella di circondarsi di giovani talenti psichiatrici europei. Quel medico italiano – che parla fluidamente il tedesco e conosce benissimo i dialetti cantonali (il bernese in particolare) – conquista rapidamente la stima del professor Max Müller che apprezza, del giovane, la serietà, la sagacia, la curiosità e la solerzia impiegate nella ricerca scientifica, non inferiore a quelle dedicate alla soluzione pratica di problemi clinici. Nel frattempo completa la sua formazione professionale e – sottoponendosi a due distinte e rigorose “analisi didattiche”[4]41 – consegue due abilitazioni alla psicoterapia.
Risso apprezza la Svizzera il suo clima operoso, ma le sue occhiute analisi sulle condizioni di vita e le conseguenze sulla salute mentale dei lavoratori immigrati sono implacabili. Ciò non gli impedisce di crearsi legami affettivi in terra elvetica. Nel 1955 conosce Ursula, da cui ha due figli Michele Davide e Claudia entrambi psichiatri psicoterapeuti. Intanto va maturando l’idea di lavorare sulle derive psicopatologiche di una serie di credenze popolari – la “fattura”, il “fascìno” lo “stregamento” e l’eventuale tracimazione in esperienza delirante – diffusissima in Italia, ma poco conosciuta in Svizzera [5]. Ebbene, Risso, per definire la strana patologia che andava osservando dovrà coniare il nuovo termine Verexungswhan (delirio di sortilegio, di stregamento, di affatturazione) che lo consacra come uno dei padri nobili dell’etnopsichiatria.
Naturalmente non fa tutto da solo: l’Umwelt prestigioso della clinica di Müller era appunto quello di favorire i lavori d’equipe, collegare la psichiatria agli eventi sociali, aprirsi ala psicopatologia antropofenomenologica, approfondire le dinamiche psicologiche, e la relazione interpersonale. Nasce così la collaborazione col collega tedesco di Jena Wolfgang Böker (più giovane di sei anni), anch’egli brillante ricercatore universitario di Waldau approdato alla corte di Müller e di Wyrsch.
Nel 1963 rientra in Italia. Transita dalla “Neuro” di Roma, frequenta soprattutto l’ambulatorio psichiatrico della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università romana dove dispensa consigli preziosi. Il suo insegnamento si aggiunge a quello di altri docenti illustri, che a quell’epoca affollavano l’Istituto romano, come Isidoro Tolentino, Luigi Frighi, Bruno Callieri, i quali allevarono una straordinaria “covata” di psichiatri: Mario Moreno, Roberto Tagliacozzo, Paolo Aite, Antonio Castellani, Nicola Ciani, Mirella Mattogno, Giuseppe Donini, Adele Scarinci, Graziella Nencini, Giovanni Jervis, Antonino Lo Cascio, Eleonora Trevi D’agostino, Massimo Marà, Jaime Ondarza Linares, Francesco Montanari (compagni di specializzazione di chi scrive) tanto per fare qualche nome.
Ora, poiché il direttore dell’Istituto aveva l’abitudine di correggere gli errori sintattici sulle cartelle cliniche con il lapis rosso e blu, nonché di criticare gli “orrori grafici” imponendo “la brutta” prima di trascrivere la scheda a macchina, affinché fosse leggibile a tutti, Michele Risso trovava insopportabile questa pignoleria, oltre che umiliante. Dunque, salutò e continuò altrove il suo magistero e le sue ricerche. L’episodio risulterebbe incomprensibile se non si precisasse che la Clinica Neuropsichiatrica dell’Università di Roma (non ancora La Sapienza, ma per nulla sprovveduta e, a quel tempo, molto accreditata presso le Università del mondo come dispensatrice di saperi accademici), allora era diretta da Mario Gozzano (1898-1986), un piemontese di Aglié, uomo coltissimo, cugino del poeta Guido, allievo della scuola partenopea di Osvaldo Fragnito, ma perfezionatosi (anch’egli) in Germania nel periodo in cui la “Mitologia del cervello” (nelle sue raffinate varianti odologiche o citologiche di neuroanatomia microscopica) cedeva ormai il passo all’elettroencefalografia e più in generale alla neurofisiologia. Forse l’essenzialità scarna di uomini delle Langhe, esaltata dalla acribia mutuata dagli svizzeri o dai tèutoni, potrebbe costituire una possibile interpretazione di quella lontana incomprensione tra piemontesi determinati.
Gli anni Sessanta e quelli del decennio successivo del secolo scorso, sono stati densi di radicali cambiamenti sociali. Proprio quelli tanto attesi dalle giovani generazioni di tutto il mondo che non erano avvenuti alla fine del secondo conflitto mondiale. La delusione accese la contestazione e incendiò la rabbia. La psichiatria, gli psichiatrici, i manicomi, i malati mentali, non furono esenti da questo fenomeno critico radicale, globale (analogo, sia pure con altri toni e dimensioni, a quello detto “della crisi” degli anni Venti), anzi costituirono il teatro ideale per un durissimo scontro ideologico transgenerazionale tra conservazione e distruzione, tra pro- e anti-, tra vecchio e nuovo. Ci furono schieramenti e ciascuno fece la sua parte: Michele Risso militò tra i riformatori più radicali. Dal punto di vista dell’agire psichiatrico, che qui maggiormente interessa per la storia di un “movimento”, il dibattito (e lo scontro) – depurato dalle ideologie che secondo Binswanger sono “esaltazioni fissate” (Verstiegenheit) – verteva essenzialmente su tre questioni: a) si può fare psicoterapia analitica agli psicotici? b) si può curare senza il manicomio? c) si può organizzare efficacemente un’assistenza per tutti, segnatamente i meno abbienti e fare prevenzione sul territorio?
Ebbene, per Michele Risso la psicoterapia agli psicotici, le visite domiciliari, e l’emergenza psichiatrica, erano una pratica quotidiana nella sua stagione romana. Eseguiva interventi di pronto soccorso psichiatrico antesignani di quello che verso la fine degli anni Novanta sarebbe stata la guardia psichiatrica dipartimentale istituita a fianco del “118”. «Certe volte i pazienti – mi ha ricordato testualmente la moglie Ursula – lo chiamavano per dirgli che si era bruciato l’appartamento e lui rispondeva tranquillizzando l’interlocutore: stai calmo che arrivo subito io, non ti preoccupare, tu buttami la chiave dalla finestra che io salgo». Quanto alla questione della rivoluzione manicomiale, nel 1965 non esitò a correre a Gorizia per collaborare con Basaglia. In quella circostanza, Ursula conobbe Franca Onagro Basaglia (scomparsa nel febbraio 2005) con cui strinse un’amicizia durata fino alla fine. Nei primi anni Settanta è a fianco di Callieri all’Ospedale psichiatrico di Guidonia (la “Martellona”) per organizzare il training psicoterapeutico di giovani psichiatri. Nel 1980, tornando da Ponza, va ai funerali di Basaglia, ma è già fiaccato dal male. Nel 1981 si spegne di leucemia all’età di appena 54 anni.
Ursula Risso è prodiga di particolari sulla vita del marito [6]: «Con Michele ho conosciuto e frequentato Ernesto de Martino. Spesso andavamo a cena con lui nelle osterie romane… ricordo molto bene il suo buonumore, il suo acume di osservatore e il suo fragoroso sorriso un po’ cavallino». – Che rapporti c’erano tra Risso e de Martino? – «Ottimi – risponde Ursula – ma circa la diceria che de Martino avesse mandato a chiamare Risso, le cose stanno diversamente. Entrambi si conoscevano, o almeno l’uno conosceva il lavoro dell’altro e viceversa. Fu Michele a cercare il professore napoletano, per motivi più che evidenti, ma nessuno dei due fu mai tanto superbo da “farsi” o “mandarsi a chiamare”».
Senza dubbio l’intuizione di Risso (diciamo pure la “scoperta”) che il Verexungswhan – ossia quella particolare categoria di “deliri” dove s’intessono credenze di malocchio, di filtri d’amore, di fatture a morte, in linea con una tradizione condivisa – altro non fosse che il risultato della lacerazione tra due culture, gli fu suggerita (o confermata) dai contatti avuti con de Martino. Il lacerante che affattura l’immigrato meridionale italiano in Svizzera è dovuto proprio alla com-presenza di queste due culture, che si trovano a co-abitare nello stesso vissuto esperienziale del migrante. Da un lato vi è quella “nuova”, che dà il lavoro, il denaro e il benessere materiale, dall’altro permane quella “antica” che si aggira fra la fame atavica e il denaro che manca. Michele Risso disvela la consonanza con la regola di un’etica pauperistica, ma invalicabile, e la ferita mortale di una credenza profondamente radicata ma rimossa troppo frettolosamente. Senza dubbio, di tale conclusione egli resta debitore verso Ernesto de Martino.
Per quanto mi riguarda, ebbi fin dal primo incontro con Michele Risso un intenso rapporto di stima e di simpatia, peraltro ricambiate, avvertendo come una sorta di affettuoso rispetto che generalmente i germani cadetti nutrono verso il primogenito; lo stesso che tutti sentiamo verso l’autorevolezza dei compagni più bravi o dei maestri sensibili. Vi erano inoltre straordinarie affinità nel modo di affrontare i temi clinici e teorici della psichiatria. In effetti, tale situazione mi derivava dalla duplice coincidenza che io avevo un fratello primogenito nato nel 1927 e che il personaggio Risso trasmetteva un forte carisma. Tale riflessione avvenne più tardi, dopo la sua scomparsa, allorché fu chiaro – e fu una piacevole sorpresa – che entrambi coltivavamo gli stessi interessi per gli “strani disturbi” che colpivano talvolta i lavoratori italiani all’estero ed avevamo lavorato (lui con dieci anni di anticipo) sulle patologie dei perdenti della migrazione ricoverati nei manicomi.
Michele Risso era un personaggio straordinario, un trascinatore che detestava le scorciatoie, ma non rinunciava al dubbio, alla riflessione, né evitava il confronto. Negli anni ’70 era uno dei pochi (forse l’unico a Roma) che curava gli psicotici gravi e congedava i nevrotici.
In quel periodo Bruno Callieri dirigeva l’Ospedale Psichiatrico di Guidonia e alla sua scuola erano accorsi numerosi giovani psichiatri (ricordiamo tra gli altri Concetto Gullotta, Stefano Piscitelli, ecc). Callieri oltre a circondarsi di nuove leve, aveva chiamato come supervisore per le psicoterapie proprio Michele Risso che aveva aderito, come a tutte le iniziative di rinnovamento, con grande entusiasmo.
Ho potuto conoscere meglio Michele Risso, giusto agli inizi degli anni Settanta, all’Ospedale psichiatrico di Guidonia. Alla “Neuro”, lo avevo incontrato di sfuggita in ambulatorio, ma la sua fama già correva tra i giovani specializzandi di Gozzano. Di questa conoscenza diretta e di tale profonda, binswangeriana, amicizia (purtroppo accompagnata solo da brevi frequentazioni) voglio riferire tre episodi, tutti occorsi nelle istituzioni manicomiali che sarebbero state chiuse nel 1978.
La prima occasione d’incontro si verificò in un contesto un po’ particolare: i famosi “martedì” di Callieri a Guidonia per presentare, ai giovani, personaggi famosi della psichiatria. Era stato invitato lo psicoterapeuta Stefano Fajrajzen, appena tornato dall’America, per una conferenza, sull’applicabilità della psicoterapia agli schizofrenici. L’evento fu memorabile proprio perché su questo tema, Risso – critico appassionato e animatore di dibattiti infiniti – era estremamente competente.
La seconda fu all’Ospedale Psichiatrico Provinciale “Santa Maria della Pietà” di Roma. Anche qui è necessaria una breve digressione. Negli anni Settanta lo dirigeva Massimiliano Bartoloni, raffinato patrizio delle Marche iesine, ascoltato consulente rotale per le questioni psichiatriche, conversatore amabile e munifico anfitrione. Attento al livello culturale dell’istituzione manicomiale romana (tradizionalmente di elevato prestigio fin dai tempi di Augusto Giannelli) aveva promosso (a sue spese) una serie di serate simposiali nella celebre biblioteca dell’ospedale, al termine delle quali seguiva un sontuoso buffet freddo servito dal maggiordomo di casa Bartoloni (il quale sceglieva con cura le portate e i vini) negli “scantinati” della direzione. Questi “scantinati”, puliti e ordinatissimi erano la sede del prezioso Archivio (una sorta di Ufficio matricola) dov’erano conservate le cartelle cliniche di tutti i malati passati dal “Santa Maria della Pietà” fin dai tempi del suo trasferimento, da Via della Lungara alla Collina di Sant’Onofrio in Campagna. Va da sé che il maggiordomo di casa Bartoloni usava la massima delicatezza per collocare le superbe bottiglie di Barolo, di Vermentino, di Brunello o di “Champagne millesimé” tra le preziosissime cartelle dell’Archivio che custodiva anche alcune “cinquecentine”, gioielli librari veri e propri, trasferiti dalla soprastante biblioteca del S. Maria della Pietà, a maggior custodia. Ho la certezza e dunque posso garantire il lettore, che nessuna di codeste delizie sfigurava rispetto all’altra o dava l’aria di trovarsi a dis-agio.
Inutile dire che vi partecipavano i più bei nomi della psichiatria romana e nazionale. La temperie dell’epoca era tale che gli schieramenti, le ideologie, gli scontri, erano frequenti e sempre molto vivaci. I rendiconti delle riunioni monotematiche, a cadenza mensile, venivano poi pubblicati su “il Lavoro Neuropsichiatrico” – la prestigiosa Rivista dell’Ospedale fondata da Ugo Cerletti e Francesco Bonfiglio – di cui ero redattore e, all’interno dell’appendice “Problemi e prospettive di assistenza psichiatrica” dedicata all’attualità, ero stato incaricato da Bartoloni di curarne una specifica rubrica intitolata “Temi di terapia prevenzione e riabilitazione in psichiatria”.
E veniamo al tema del 3 marzo 1972 intitolato “Le depressioni”. Ebbene, in tale circostanza Michele Risso – invitato da me – criticava lo schema di Paul Kielholz e le numerose sottospecie di depressioni proposte da Kurt Leonhard (allora citatissime), mentre sciorinava con competenza e passione le penetranti indagini di Binswanger sulle esperienze depressive come l’angoscia esistenziale (Daseinsangst), il cambio di polarità della situazione emotiva (Befindlichkeit), la contrazione della spazializzazione (Räumlichung), della temporalizzazione (Zeitlichung), l’interruzione del progetto mondano (Weltentwurf), magistralmente illuminate in Melanconia e Mania, Lola Voss, Ellen West. E, a Tullio Bazzi che gli ribatteva animosamente – «Ma con un caso mi fa una statistica?» – ricordo che Risso rispondeva puntigliosamente difendendo la psicopatologia antropofenomenologica come studio dell’esperienza del singolo – «Un caso è prima di tutto un essere umano!».
La terza occasione d’incontro si verificò il mese successivo e qui lo scontro fu davvero epocale. Il tema questa volta era incandescente: “L’elettroshock-terapia. Limiti, tematiche”. Relatore (temerario) era lo scrivente [6] – non ancora quarantenne, appena rientrato dai manicomi della Sardegna dove si era imbattuto per la prima volta nei fallimenti migratori, di cui si farà cenno oltre – che osava criticare la filosofia terapeutica della cura convulsivante. Ci fu una vera e propria tenzone verbale tra due schieramenti: da un lato Tullio Bazzi, Giannetto Cerquetelli, Clemente Catalano Nobili, Vanni Bonfiglio (la vecchia generazione, piuttosto scandalizzata dalla dissacrazione), dall’altro Antonino Lo Cascio, Massimo Marà e naturalmente io (la generazione intermedia, dissacrante e piuttosto facinorosa) spalleggiati, nella circostanza, da Michele Risso e Alberto Giordano. Massimiliano Bartoloni, come padrone di casa, tentò invano una mediazione, ma le violente polemiche non cessarono neppure al buffet che seguì. Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo anni, sembra di poter dire che in quello scontro, alle passioni fece velo una buona dose di ideologia da entrambe le parti.
Come s’è detto, alla fine degli anni ’50 Risso si era occupato di psichiatria transculturale e di problemi di psicopatologia applicata. Aveva condotto la sua indagine sui lavoratori meridionali italiani ricoverati tra il 1946 e il 1961 negli ospedali psichiatrici cantonali della Svizzera tedesca. La popolazione censita e studiata sistematicamente riguardava complessivamente 709 pazienti di nazionalità italiana immigrati in Svizzera. L’indagine era stata condotta «in 16 Cliniche psichiatriche, manicomi e case di cura della Svizzera di lingua tedesca, parte attraverso osservazioni personali, parte attraverso le cartelle cliniche, secondo numerosi fattori (Provenienza; Ereditarietà; Personalità premorbosa; Tipo di malattia psichica, etc.)»[8]. La casistica selezionata per il testo Verhexungswahn [9] è costituita da 11 pazienti maschi più una donna. Tutti presentavano disturbi psichici non facilmente diagnosticabili che facevano risalire ad influenze magiche (sortilegio, malocchio, fattura, stregamento).
Chi scrive, agli inizi degli anni ’70 – esattamente 20 anni dopo Risso – s’interrogava sulle ragioni nascoste di sofferenze, disagi e malasorte di cui si dolevano i ricoverati maschi incontrati negli ospedali psichiatrici della Sardegna. ”Malato sono”, “m’incresce ‘sa conca” (mi duole il capo), “non possu più traballare”, “mi è venuto l’esaurimento lavorando in Continente”, “no estotu assottau!” (non sono stato fortunato). Lamentazioni di gente umile difficilmente catalogabili come sintomi psichiatrici, che l’istituzione manicomiale dissimulava, invece, dietro importanti diagnosi psichiatriche di comodo atte a giustificare il domicilio ultimo di questa schiera di perdenti della migrazione. Probabilmente andavo a squarciare un velo (impietoso) sugli esiti a distanza di una sconfitta sociale – la demartiniana destorificazione del divenire – che Risso aveva visto manifestarsi in forma acuta, 20 anni prima, tra gli immigrati italiani ricoverati negli ospedali psichiatrici della Svizzera di lingua tedesca. Sospettavo fin da principio che in quegli “strani disturbi” degli ex migranti manicomializzati la fortuna non c’entrasse per niente. In seguito de Martino e Risso mi hanno suggerito che dovevo cercare altrove: lontano dalla psichiatria, lontanissimo dal manicomio.
Poiché era il tempo di grandi battaglie ideali alle quali Risso partecipava con grande impeto e convinto entusiasmo, non vi fu modo di confrontare le mie osservazioni sarde sugli emigrati italiani tornati sconfitti e finiti in Manicomio con quelle che egli aveva fatto a Berna. Anzi, ignoravo completamente il suo lavoro in Svizzera e non è escluso che nella popolazione manicomiale cagliaritana o di Dolianova vi fosse qualcuno di quei “bernesi” immigrati dall’Italia esaminati da Risso a Valdau. Solo più tardi, a battaglia antimanicomiale conclusa e con Risso ormai scomparso, scoprì che c’era un altro Risso; quella sorta di “fratello maggiore” di cui ho detto sopra. Egli aveva aperto la strada degli studi sull’improvviso cambio d’orizzonte da fiducioso a catastrofico nell’esperienza migratoria dei nostri connazionali più deboli: la manodopera alla ricerca del pane, del riscatto, della speranza che si andava spandendo per l’Europa postbellica da ricostruire. Una specie di “primogenito” – ed, in effetti, così è rimasto Risso nella mia memoria (o almeno come tale l’ho ritenuto e lo ricordo) – una bussola per orientarsi nella ricerca transculturale e nelle grandi incertezze della rivoluzione psichiatrica di quegli anni. La sua lezione etnopsichiatrica sarà raccolta e la sua opera continuata in Roma, alla fine degli anni Novanta, con la creazione di un ambulatorio per immigrati: il Centro “Michele Risso”[10].
È passato un po’ di tempo. Si sono esauriti tutti gli anni zero di questo micidiale inizio di terzo millennio. Terrificante decennio, purtroppo, di derive populiste tanto ottuse quanto crudeli soprattutto sull’immigrazione, vera e propria cartina di tornasole delle sedicenti società aperte, democratiche, civili (ex coloniali). Assistiamo increduli a politiche di chiusure, respingimenti, obbligo di delazione, accanimento sulla povertà immigrativa altrui, addirittura sanzionata come reato. Siamo al termine del secondo decennio e, abbiamo scoperto l’internazionalizzazione e la mondializzazione di criminali associazioni di mercanti di esseri umani indotti alla migrazione da false lusinghe. Lucrano cifre da capogiro, giocando sui bisogni, le speranze e le attese di gente poverissima o perseguitata. Proprio com’era oltre un secolo e mezzo fa in Italia (prima e dopo il 1870), dove c’erano manifesti appesi nelle piazze, che adescavano i poveri contadini del Veneto ad imbarcarsi su “Piroscafi moderni” per raggiungere, “con pochi giorni di viaggio”, “Le Americhe”. Si dice che l’Europa non può fare tutto. Ma certamente molto di più, in maniera intelligente, pianificata e dividendosi equamente l’onere. Addolora constatare che in questo ennesimo ritorno alla barbarie, l’Italia si sia scoperta più cattiva, meno solidale e più razzista di quanto non sia stata in passato.
Note a Michele Risso (p. 604)
[1] “Da quando, nel 1974 nelle sedi internazionali, si dichiarava in modo stupidamente miope la fine dei processi migratori di massa” – scriveva Franco Foschi (Relazione al I Convegno Internazionale “Medicina e migrazioni”, organizzato dalla Cattedra di igiene Mentale, Università di Roma “La Sapienza” (Roma, 9-10 aprile 1988). Atti del Convegno, p. 12). – le questioni “si sono moltiplicate e il problema è oggi diventato più complesso per l’intreccio di ragioni che spingono milioni di persone ad emigrare, immigrare, tornare, da aree e verso aree geografiche e culturali”. L’Autore, che è un politico e prima ancora uno psichiatra, ne spiega anche le ragioni più profonde: “In realtà si intendeva dire che i paesi di immigrazione non sentivano più il bisogno di manodopera che li aveva indotti a regolare in qualche modo i flussi d’ingresso, a condizione di limitare o procrastinare i diritti dei nuovi venuti. Questa, in termini brutali, la sostanza della legislazione migratoria”. parole dure, ma estremamente chiare, per denunciare l’intreccio tra migrazione, bisogno e sfruttamento del lavoro che si intendeva rinnovare: “Allora” – prosegue Foschi – “nel 1974 si fingeva di non conoscere i problemi, come quelli derivanti dallo squilibrio demografico, dal differenziale di sviluppo economico sociale e demografico tra il Nord e il Sud del mondo e dall’ampliarsi del fenomeno delle economie sommerse di cui lo sfruttamento dell’uomo diviene una logica variabile dipendente”. Inganno o finzione? Formalità o sostanza? Non possiamo non concordare con Franco Foschi allorché sottolineava, proprio in contrasto con i diritti da noi stessi reclamati per i nostri connazionali all’estero, che “noi oggi affermiamo che non siamo un paese d’immigrazione, perché formalmente noi non abbiamo mai chiesto con specifici accordi a nessuno di venire tra noi: così, quelli che ci sono, o non ci sono o comunque possono andarsene”. Mellina S, Medici e Sciamani fratelli separati. Lombardo, Roma 1997, p. 134.
[2] L’Ospedale psichiatrico universitario di Waldau-Berna – in competizione col vicino Istituto psichiatrico di Muensingen – è stato reso celebre oltre che dal direttore Walter Morgenthaler (1882-1965), assertore dei benefici effetti dell’art-therapy, il quale vi fondò un piccolo museo per conservare i quadri dei suoi pazienti. Fra questi spiccano le opere di Adolf Wölfli (1864-1930) pittore svizzero, esponente di spicco della Art Brut, ricoverato dal 1895 al 1930, sul quale lo stesso Morgenthaler ha scritto una monografia. Per il prestigio della psichiatria bernese non meno importante è stato Max Müller. Altro ospite famoso di Waldau fu lo scrittore Robert Walser che vi soggiornò nel periodo 1929-1933.
[3] Wyrsch in pieno accordo con Binswanger soleva dire che il paziente non va “spiegato” ma “compreso”. Si vuole che sia stato lui ad introdurre il termine “Daseinsanalyse” nel 1942.
[4] La prima la effettua con Ernst Blum (1892-1981), psicoanalista analizzato da Freud, la seconda con Arnold Weber, (1894-1976), fra i primi neuropsichiatri infantili dell’università bernese, cognato di Max Müller e analizzato da Emil Oberholzer (1883-1958).
[5] Tra l’altro, sia detto qui per inciso, Michele Risso proviene da un retroterra culturale (una zona del Piemonte) dove la massima espressione del colto razionalismo illuministico e massonico convive ossimoricamente col più convinto irrazionalismo esoterico.
[6] Intervista fatta personalmente ad Ursula Risso il 4 maggio 2005.
[7] Mellina Sergio. L’elettroshock-terapia: limiti, tematiche. Relazione alla II Riunione monotematica (3/5/1972) “Temi di terapia, prevenzione e riabilitazione in psichiatria” presso l’O.P.P. di Roma. In: “Problemi e Prospettive di Assistenza Psichiatrica” (pp. 16-41 della rubrica in fascicolo a parte). Il Lav. Neuropsichiat., 50: 1, 1972, 188-213.
[8] Michele Risso e Wolfgang Böker. Sortilegio e delirio a cura di Vittorio Lanternari, Virginia de Micco e Giuseppe Cardamone, Liguori Editore, Napoli, 2000, 2a ediz. p. 58.
[9] Apparso in Svizzera da S. Karger AG a Basilea nel 1964.
[10] Queste le motivazioni profonde che mi hanno indotto a far approvare, istituire e dirigere nella ASL “B” di Roma, in Via di Torre Spaccata 157, il “Centro ambulatoriale Michele Risso”, con un “Progetto-obiettivo per la tutela della salute mentale delle popolazioni migranti e per lo studio dell’etnopsichiatria”, che sarebbe dovuto durare dal 1997 al 2000, invece è stato interrotto il 1 ottobre 1999. Nel periodo in cui l’ambulatorio è stato attivo sono stati seguiti e curati 140 pazienti stranieri.
Bibliografia essenziale.
Benedetti G. L’emigrazione di manodopera italiana in Svizzera alla luce della psichiatria. «Seele», n. 20, 1972.
Beneduce R. Geografie della memoria. Considerazioni clinico-antropologiche su migrazione e salute mentale. In De Micco V, Martelli P. (a curai). “Passaggi di confine” Liguori, Napoli, 1993.
Frigessi-Castelnuovo D, Risso M. A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale. Einaudi, Torino, 1982.
Lanternari V. Medicina, magia, religione, valori. Liguori Napoli 1996.
Lanternari V, Ciminelli M L (a cura di). Medicina, Magia, Religione, Valori. 2. Dall’antropologia all’etnopsichiatria. Testi di Beneduce, Bernardi, Bibeau, Cardamone & Inglese, Charuty, Ciminelli, Corin, Csordas & Kleinman, Fiore, Gallini, Lanternari, Polia, Schirripa, Talamonti, Vulpiani. Liguori Napoli, 1998.
Mellina Sergio. L’elettroshock-terapia: limiti, tematiche. Relazione alla II Riunione monotematica (3/5/1972) “Temi di terapia, prevenzione e riabilitazione in psichiatria” presso l’O.P.P. di Roma. In: “Problemi e Prospettive di Assistenza Psichiatrica” (pp. 16-41 della rubrica in fascicolo a parte). Il Lav. Neuropsichiat., 50: 1, 1972, 188-213,
Mellina S. La tutela della salute mentale degli immigrati e il progetto «Michele Risso» nell’ASL Roma B. In: Anna Rotondo e Marco Mazzetti “Etnopsichiatria e psicoterapie transculturali. Il carro dalle molte ruote”, pp. 13-45. Dibattito con Sergio Mellina. Ibidem, L’Harmattan, Torino, 2001 pp. 47-64
Mellina S. La mediazione tra le culture della salute come necessità imposta dall’immigrazione. Un modello (ri)emergente di fare medicina nel servizio sanitario nazionale. In De Micco Virginia (a cura di). “Le culture della salute. Immigrazione e sanità: un approccio transculturale”, Liguori, Napoli, 2002 pp. 201-217.
Mellina S. Primo piatto: la pasta e la minestra. Un ricordo dell’ultimo grande esodo migratorio italiano. In: Ferdinando De Marco “Etnie in cammino. La riabilitazione psicosociale tra nuova e vecchia Social Mobility”, Artigrafiche Caramanica, Marina di Minturno (Latina), 2004 pp. 223-248.
Risso M, Böker W. Verhexungswahn Karger, Basel - New York, 1964.
Risso M, Böker W. Sortilegio e delirio a cura di Vittorio Lanternari, Virginia De Micco e Giuseppe Cardamone, Liguori Editore, Napoli, 2000.








