PENSIERI SPARSI
Tra psichiatria, impegno civile e suggestioni culturali
INTORNO A "LE NOSTRE OSCILLAZIONI. FILOSOFIA E FOLLIA" di P.A. ROVATTI
23 novembre, 2019 - 04:28
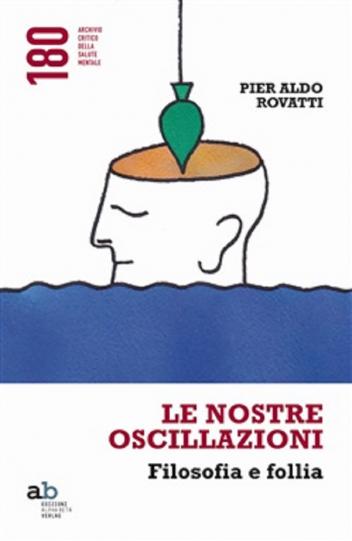
Le nostre oscillazioni. Filosofia e follia è il secondo volume che Pier Aldo Rovatti pubblica nella collana 180 dell’editore meranese Alpha Beta Verlag, diretta da Peppe Dell’Acqua.
Il primo era stato Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco Basaglia e risale al 2013. Raccoglieva le lezioni che Rovatti ha tenuto all’Università di Trieste sul pensiero di Basaglia e comprendeva interventi di Colucci, Dell’Acqua, Gallio, Giannichedda, Rotelli, Venturini e Zanetti. In esso il filosofo di origine modenese ripercorre con i suoi interlocutori gli aspetti più rilevanti del pensiero di Basaglia. Vorrei brevemente evocarlo, a partire da alcuni appunti disordinati che avevo preso allora, durante la lettura.
Mi avevano colpito del dialogo tra Rovatti e Mario Colucci sul rapporto tra Basaglia e il fondamento fenomenologico del suo pensiero, l’aver rilevato una tendenza della psichiatria a trasformare ciò che è elemento storico, umano, destinato ad evolvere, in fatto di natura dato per come è una volta per tutte. O l’idea che Rovatti riprende da Husserl della fenomenologia come qualcosa di incompiuto destinato a rimanere tale, che tanto ha a che fare con lo stile del pensare basagliano e spiazza chi vi cerca inutilmente insegnamenti e certezze da fare proprie o confutare. E mi richiama alla mente il concetto di utopia in Ernst Bloch, navigazione senza approdo, che trova nel navigare il proprio senso. Giovanna Gallio parla del pensiero di Basaglia come di un pensiero “in movimento”, in tensione, consapevole del fatto che le contraddizioni che apre occorre “riuscire a sopportarle senza affrettarsi a chiuderle”, e che porteranno ad altre contraddizioni, e ad altre ancora. Dialettica destinata a rimanere comunque aperta, a non arrivare mai a sintesi completa. Enigma del soggetto destinato a essere avvicinato con rispetto, curiosità, senza che si abbia necessariamente la pretesa di chiuderlo in una definizione, di risolverlo una volta per tutte. Sguardo rispettoso, capace di non inghiottire il suo oggetto e di lasciare al silenzio lo spazio che gli spetta.
La forza del dubbio, la trepidazione, l’incognita, il peso delle responsabilità di una proposta rivoluzionaria e le angosce dell’uomo Basaglia che si avventura e ci spinge ad avventurarci oltre il cancello, oltre il muro. Un dubbio che è debolezza, rispetto, ma che sa farsi forza nel momento in cui si deve contrapporre a ciò che impedisce, costringe, coarta la libertà del dubitare. Il rifiuto della parola che definisce, classifica, inquadra e corrisponde al manicomio che rinchiude, irrigidisce, separa la vita. La contraddizione dell’esercizio del potere psichiatrico e della sua contestuale messa in crisi. Il fascino di essere convocati se necessario anche la notte e la disponibilità – e mi sono sempre chiesto se non sia questo un elemento imprescindibile del discorso, e la sua mancanza oggi sia la vera ragione per cui le cose nella psichiatria della 180 non funzionano mai quanto vorremmo – a “portare lì dentro tutta la nostra vita”, della quale ci ha raccontato anche Giovanna Del Giudice in un incontro col nostro gruppo a Genova di qualche anno fa. Aprire le porte, e tollerare il rischio della fuga del malato; ma poi vestirsi di notte, per andare a cercarlo: a proposito di libertà, controllo, assunzione di responsabilità, (posizione di garanzia?). L’apertura massima all’altro come cifra caratteristica dell’uomo Basaglia, della casa Basaglia nella quale ciascun ospite può sentirsi libero di entrare e uscire ad ogni ora nel ricordo di Ernesto Venturini (gli anni ’60), ma anche radicali domande di onestà e di autenticità che spiazzano e imbarazzano l’interlocutore. Radicalità di un non rinunciare mai a interrogarsi e interrogare, su se stesso, sull’altro, sulla follia, sulla ragione. Interrogarsi e interrogare in modo radicale, cercando di riportare a nudo gli uomini e le cose per di lì ogni volta ripartire, che infondo corrisponde allo sforzo più autentico della fenomenologia.
Ancora, il rapporto tra il mistero della follia, nella sua relazione complessa con il soggetto e la sua libertà, e il dato storico della malattia mentale (il cui rischio di scivolamento semantico verso una “malattia cerebrale” è sempre in agguato) come è definita, codificata, assoggettata e addomesticata dalla medicina. L’idea dell’esitazione come esigenza di lasciare spazio all’altro prima di costringerlo in una definizione, prima di rifiutare cartesianamente che la follia – la sua e la nostra follia - possa essere parte del discorso. La relazione complessa tra il modo di darsi della follia e del suo rifiuto nella storia, il discorso (i discorsi) che la ragione fa sulla follia e la storia stessa, come l’ha indagata Foucault.
E poi una chiara presa di posizione di Rovatti, sulla quale bisognerebbe sì, tra psichiatri, non cessare mai di confrontarci: «Dopo la 180 ci sono due strade. O smettere di fare gli psichiatri, oppure essere gli psichiatri che si mettono al servizio di una situazione nuova e che quindi diventano i tecnici dei nuovi servizi di cura. Basaglia crede che non si debba abbandonare la psichiatria, e quindi neanche che si possa cancellare completamente quell’elemento di potere che la psichiatria contiene. Lo psichiatra mantiene un potere sul paziente e questo potere deve essere controllato, da chi? Dalla scienza o dai malati? La risposta di Basaglia è netta: dai malati. Quindi, restituire la soggettività significa passare attraverso i rapporti di potere» (p. 191).
Ma saranno davvero in grado, i malati, con la loro ragione intermittente e claudicante, di assumersi realmente, autenticamente, questa responsabilità? E noi, come possiamo essere controllati da qualcuno sul quale manteniamo comunque un “elemento di potere” e, a nostra volta, di controllo perché il controllo è implicito nel potere?
Come contraddizione, non è male questa con la quale cii confrontiamo quotidianamente, nei luoghi dell’urgenza come in quelli della riabilitazione: restituire potere (o meglio aprire spazi perché l’altro, che è colui che ha meno potere di tutti, che in quanto folle non è considerato soggetto possibile ma solo oggetto di ogni possibile discorso, possa appropriarsi di potere), mantenendo inevitabilmente per noi la riserva di qualche “elemento di potere”. Trovare ogni volta, caso per caso, l’equilibrio più avanzato possibile, un equilibrio comunque instabile e oggetto di continua ridefinizione e rinegoziazione. Come al mercato di Marrakesh, direbbe Rotelli. Vincere la paura che evoca la follia, quella degli altri e la nostra per riportarla nella città - costruita per essere un’organizzazione pulita, ordinata, razionale, rispettosa dello spazio privato di chi ha uno spazio privato - che di lì l’ha espulsa, e lì imparare a tollerarla, trovare modalità di convivenza che non implichino lo scambio tra la libertà e le vite di alcuni e la domanda di tranquillità degli altri. Aprire alla follia uno spazio nel discorso, senza però farcene sommergere.
Leggendo queste pagine, mi pare che la proposta rivoluzionaria e radicale di Basaglia, la sostanza della 180 infondo possa essere questa, una radicale rivoluzione antropologica capace di aprire spazi maggiori alla propria e all’altrui follia, spazi maggiori di libertà e di tolleranza; molto di più insomma che una riforma in senso umanitario dell’assistenza psichiatrica (che già sarebbe, comunque, importante). E con questo noi nuovi operatori psichiatrici, quelli della 180, dobbiamo misurarci ogni volta che un soggetto, un familiare, un condomino, un poliziotto, un giudice ci scrivono che hanno paura della follia e ci chiedono – a volte anche in modo talora isterico e prepotente, ultimativo - valutazione, competenza, responsabilità, rassicurazione, aiuto. E ci mettono di nuovo di fronte alla domanda di fondo della psichiatria: chiudere o aprire.
Questo secondo volume di Rovatti per la collana 180, Le nostre oscillazioni. Filosofia e follia, ha a che fare, mi pare, con le stesse questioni di fondo ma le affronta da un altro lato, quello della filosofia. In esso l'Autore ripropone vent’anni dopo questioni che aveva affrontato con un altro agile libello, La follia, in poche parole (Bompiani, 2000), nato da un corso di formazione tenuto agli operatori dei servizi di salute mentale triestini intorno ad alcune parole chiave: la follia, l’altro, il corpo, il gioco.
E ricorda come negli anni ’60-’70 vari intellettuali (Foucault e Basaglia, ad esempio) si siano sforzati di individuare - nello stretto iato tra la psichiatria classica che è poi tornata a prevalere e la oggettivizza come malattia, e l’antipsichiatria che la mitizza – un posto e un senso per la follia. Una funzione anche, se vogliamo, che è quella di fare da contraltare oscuro alla lucidità della ragione, e di consentire così al pensiero di rimanere aperto, insaturo, inconcluso, “oscillante” per mantenere l’espressione di Rovatti tra la ragione che sappiamo, che ben conosciamo nella sua consequenzialità, e un’altra cosa che ne costituisce il contrario e non sappiamo, non conosciamo ma della quale avvertiamo oscuramente la presenza: la follia. Che ci è ignota ma ci è anche indispensabile, e perciò è qualcosa di cui tutti gli uomini fanno, in maggiore o minore misura, esperienza; che non può essere considerata un difetto del pensiero ridotto a ragione, e neppure essere esaltata al punto di essere colta come la perfezione del pensiero, dal quale perciò è la ragione a dover essere espulsa. Che sta lì, dentro il pensiero, una forma altra del pensiero che deve coesistere in un rapporto dialettico con la ragione perché il pensiero non si irrigidisca correndo il rischio di perdere la capacità di dubitare, oscillare, aprirsi all’ignoto, che è ciò che lo vivifica e lo rende, infondo, così dolcemente umano.
Per aprire uno spazio alla follia è indispensabile insomma aprire alla diversità, all’instabilità, all’indecidibilità.
E qui si pone, credo, un’altra questione, quella del rapporto tra follia e libertà, che può essere letto in due modi. Da un lato considerando la follia come lo stato di massima libertà, nel quale il folle esprime, senza porsi il problema di limiti e vincoli imposti dalla propria o altrui ragione, il sé più autentico, il vero se stesso al quale deve essere concesso (nei limiti possibili, forse) massimo spazio. è questa la posizione degli antipsichiatri per i quali la storia della psichiatria è storia dell’oppressione dei folli, e come in un gioco di ribaltamento tra figura e sfondo, quelli che agli storici della psichiatria appaiono come gli errori e le esagerazioni nei quali la psichiatria è incorsa nei secoli, ne sono invece i momenti emblematici (ricordo di avere assistito, in occasione di un convegno della WPA a Firenze, a una contromostra di Scientology nella quale esattamente questa era la rappresentazione). Ma dall’altro lato, considerandola come una malattia che colpisce il soggetto nella sua ragione impedendone il funzionamento, la condizione della massima coazione della sua libertà della quale il soggetto deve essere aiutato a liberarsi (Henri Ey parla della psicosi come “patologia della libertà” e la psicopatologia fenomenologica del delirare come dell’essere prigioniero del delirio, impossibilitato a qualsiasi pensiero che esca dal delirio). Libertà nella follia; o libertà dalla follia, insomma? Nel primo caso lo psichiatra, con tutti i suoi strumenti, si sentirà e sarà avvertito come l’oppressore che impedisce, con l’imporgli i vincoli della società, alla libertà del soggetto di esprimersi; nel secondo, sarà il “liberatore” che generosamente si adopera a guarire il soggetto dalla malattia, per restituirlo così propria autentica libertà (ed è questa infondo la storia (il mito?) che noi psichiatri ci raccontiamo e tramandiamo).
Credo che questa alternativa non abbia soluzione e se lo psichiatra si sofferma a interrogarsi sul proprio atteggiamento verso la follia si accorga di oscillare – prendo a prestito questo termine pregnante dal titolo del volume - tra fermarsi talvolta ad ascoltare e contemplare la follia nel suo mistero e nella sua fascinazione, e impegnarsi altre volte a contrastarla per liberare il soggetto dalla crudeltà, dalla coazione e dalla deturpazione dei suoi morsi, che l’accomunano a ogni altra forma di sofferenza ed eventualmente malattia. E forse, mi viene da pensare, possiamo immaginare il rapporto con la follia (come quello con il gioco, infondo) come quello con qualcosa che sta di fronte a noi; possiamo salirlo in qualche misura e curiosare oltre, spiare, flirtare magari con lei e questo può ampliare il livello della libertà di cui godiamo. Ma non dobbiamo cadere dall’altra parte, o la follia, il delirare si trasformano nella mancanza di libertà. Forse, anche nella perdita dell’alterità.
Mi accorgo che sto procedendo a tentoni, e perciò ritorno al testo. Un problema sul quale Rovatti si sofferma è il rapporto tra ragione e follia dal punto di vista della storia, e lo affronta rievocando la polemica che ebbe protagonisti Michel Foucault e Jacques Derrida. La tesi di fondo della Storia della follia nell’età classica di Foucault è nota: la follia sarebbe stata messa a tacere, nella storia europea, dal Grande internamento del Seicento e poi definitivamente silenziata dalla nascita della psichiatria moderna nell’Ottocento. Quindi, mi pare di comprendere, per scrivere la storia della follia sarebbe stato necessario scrivere la storia di un silenzio, che dà semmai qua e là segno del proprio mormorio represso; ma siccome un silenzio è indicibile in parole, l’operazione di Foucault - osserva Rovatti - si risolve nell’essere in realtà una storia della ragione, delle pratiche sociali con le quali la ragione silenzia la follia. Per Foucault (così mi pare di poter sintetizzare il ragionamento), da Cartesio a Freud e oltre ogni volta che la ragione evoca la follia, con ciò stesso la mette a tacere, facendone un suo oggetto, leggendola con le proprie lenti. Per Derrida invece ogni volta che viene evocata, la follia è comunque presente come assenza, paradossalmente presente perciò, carta del mazzo – le efficaci metafore sono di Rovatti – che sta fuori dal mazzo, la pagina bianca nel libro, l’assenza delle quali contribuisce a renderle evidenti. Una paradossale presenza dell’assenza, perciò. E Rovatti sostiene che ciascuna delle posizioni, aspramente contese dai due interlocutori, contiene un pezzo di verità e si chiede qual è la posizione di Foucault rispetto al muro che separa ragione e follia, nel momento in cui scrive una storia del silenziamento della follia usando indubbiamente le lenti (il linguaggio, il rigore logico) della ragione. E la risposta che propone è spiazzante: la sua posizione è stare in un equilibrio instabile e rischioso a cavallo del muro, oscillando tra l’una e l’altra parte nel momento in cui continua ad appartenere indubbiamente alla ragione, ma si sporge sulla follia sforzandosi di coglierne il più possibile il mormorio che si fa a volte gemito e, direi, comprenderne empaticamente il punto di vista, ciò che essa può avere da dire sull’uomo e sulla storia.
Impegnato, in modo forse un po’ donchisciottesco, a farsi paladino delle sue ragioni, della sua possibilità, di quello che ha da dire, di una muta testimonianza. Traduttore forse, con tutte le ambiguità e i rischi che quest’operazione comporta. A cavallo, per di più, di un muro che insieme c’è e non c’è: perché un po’ di follia abita sempre la ragione, e non esiste forse follia che non sia anche contaminata da briciole di ragione. E una tradizione popolare, che nasconde forse nella carica retorica più che un briciolo di verità, recita che c’è sempre saggezza nelle parole degli uomini folli, e follia in quelle degli uomini ragionevoli. Ma non è, infondo, quella su quel muro la posizione che anche il nuovo psichiatra, per come Basaglia lo immagina, dovrebbe assumere a sua volta?
Attraverso la ricostruzione della polemica tra Foucault e Derrida, e forse tra Foucault e Foucault stesso, quando decide per ragioni sulle quali il filosofo modenese s’interroga e costituiscono già in sé un enigma, la soppressione della prefazione alla prima edizione della Storia della follia (recuperata per la seconda edizione italiana curata cinquant’anni dopo, nel 2011, da Mario Galzigna per Rizzoli). Rovatti insiste: è difficile parlare della follia, è un oggetto che continuamente sfugge e si duplica in un gioco di continui riverberi con la ragione che è impossibile conoscere in modo definitivo. è oggetto di continui tentativi di neutralizzazione, ma al contempo è ineliminabile.
La follia: Rovatti ce la fa ritrovare nel nostro rapporto con l’altro, in quello con il nostro corpo, nei giochi logici di due testi fondamentali: Nodi di Ronald Laing e Verso un’ecologia della mente di Gregory Bateson. Per poi metterci in guardia, e sono le ultime pagine - senz’altro coraggiose e non scontate - da una trappola: quella di considerare la follia, nella sua essenza, sofferenza, che è un modo certo più umano, empatico, meno saccente di considerarla ma non è poi così lontano, infondo, dal considerarla solo malattia. Perché la follia è sì anche sofferenza, una sofferenza che abbiamo il compito sicuramente di lenire, ammette, ma non dobbiamo dimenticarci, nell’avvicinarla con rispetto, che non è solo quello; è forse anche verità (una possibile verità certo, auspicabilmente non la Verità) forse in cerca di attenzione. è mormorio, rumore di fondo che vuole essere ascoltato (senza che, però, ci se ne lasci ammaliare). E credo che proprio tenere aperta questa contraddizione – la cura e l’ascolto – che Rovatti mette in luce con chiarezza, sia la cosa più difficile quando s’inciampa nella follia, la propria o quella dell’altro non importa.
Non so, insomma, se ho ben inteso né ben sintetizzato la complessità di quello che Rovatti intende esprimere, ma mi sembra che abbia a che fare con questioni imprescindibili e importanti quando ci si avvicina alla follia, quando ci si sforza di conoscerla e di concettualizzarla. Ma certo credo che l’allarme con cui l’Autore introduce le sue considerazioni vada raccolto: questi primi vent’anni del nuovo millennio hanno visto l’affermazione, nella cultura generale ma forse ancora più drammaticamente nel mondo psichiatrico, di un pensiero unico fatto di semplificazioni ad ogni costo, classificazioni categoriali, allineamento, riduzione dei soggetti a numeri, ideologico riduzionismo cerebroiatrico, disciplinamento e omologazione delle pratiche. Per il pensiero critico, i dubbi, le oscillazioni sembrano non esserci posto né attenzione. E tanto meno per l’atteggiamento indispensabile per la possibilità della fenomenologia: la riduzione fenomenologica, la sospensione di giudizio (il giudizio deve anzi essere oggi folgorante, immediato, sintetico, possibilmente espresso ad alta voce, aggressivo, autoritario e ultimativo), l’enigma dell’intersoggettività. Nessun enigma, nessun dubbio, nessuna obiezione che intralci! Figuriamoci se posto e attenzione, ascolto possono esserci, quindi, per la follia, con il suo mormorio timido e sofferto, fragile, confuso, il mistero delle sue oscure illuminazioni, le sue chiaroscurali oscillazioni ed i suoi dubbi.
Il primo era stato Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco Basaglia e risale al 2013. Raccoglieva le lezioni che Rovatti ha tenuto all’Università di Trieste sul pensiero di Basaglia e comprendeva interventi di Colucci, Dell’Acqua, Gallio, Giannichedda, Rotelli, Venturini e Zanetti. In esso il filosofo di origine modenese ripercorre con i suoi interlocutori gli aspetti più rilevanti del pensiero di Basaglia. Vorrei brevemente evocarlo, a partire da alcuni appunti disordinati che avevo preso allora, durante la lettura.
Mi avevano colpito del dialogo tra Rovatti e Mario Colucci sul rapporto tra Basaglia e il fondamento fenomenologico del suo pensiero, l’aver rilevato una tendenza della psichiatria a trasformare ciò che è elemento storico, umano, destinato ad evolvere, in fatto di natura dato per come è una volta per tutte. O l’idea che Rovatti riprende da Husserl della fenomenologia come qualcosa di incompiuto destinato a rimanere tale, che tanto ha a che fare con lo stile del pensare basagliano e spiazza chi vi cerca inutilmente insegnamenti e certezze da fare proprie o confutare. E mi richiama alla mente il concetto di utopia in Ernst Bloch, navigazione senza approdo, che trova nel navigare il proprio senso. Giovanna Gallio parla del pensiero di Basaglia come di un pensiero “in movimento”, in tensione, consapevole del fatto che le contraddizioni che apre occorre “riuscire a sopportarle senza affrettarsi a chiuderle”, e che porteranno ad altre contraddizioni, e ad altre ancora. Dialettica destinata a rimanere comunque aperta, a non arrivare mai a sintesi completa. Enigma del soggetto destinato a essere avvicinato con rispetto, curiosità, senza che si abbia necessariamente la pretesa di chiuderlo in una definizione, di risolverlo una volta per tutte. Sguardo rispettoso, capace di non inghiottire il suo oggetto e di lasciare al silenzio lo spazio che gli spetta.
La forza del dubbio, la trepidazione, l’incognita, il peso delle responsabilità di una proposta rivoluzionaria e le angosce dell’uomo Basaglia che si avventura e ci spinge ad avventurarci oltre il cancello, oltre il muro. Un dubbio che è debolezza, rispetto, ma che sa farsi forza nel momento in cui si deve contrapporre a ciò che impedisce, costringe, coarta la libertà del dubitare. Il rifiuto della parola che definisce, classifica, inquadra e corrisponde al manicomio che rinchiude, irrigidisce, separa la vita. La contraddizione dell’esercizio del potere psichiatrico e della sua contestuale messa in crisi. Il fascino di essere convocati se necessario anche la notte e la disponibilità – e mi sono sempre chiesto se non sia questo un elemento imprescindibile del discorso, e la sua mancanza oggi sia la vera ragione per cui le cose nella psichiatria della 180 non funzionano mai quanto vorremmo – a “portare lì dentro tutta la nostra vita”, della quale ci ha raccontato anche Giovanna Del Giudice in un incontro col nostro gruppo a Genova di qualche anno fa. Aprire le porte, e tollerare il rischio della fuga del malato; ma poi vestirsi di notte, per andare a cercarlo: a proposito di libertà, controllo, assunzione di responsabilità, (posizione di garanzia?). L’apertura massima all’altro come cifra caratteristica dell’uomo Basaglia, della casa Basaglia nella quale ciascun ospite può sentirsi libero di entrare e uscire ad ogni ora nel ricordo di Ernesto Venturini (gli anni ’60), ma anche radicali domande di onestà e di autenticità che spiazzano e imbarazzano l’interlocutore. Radicalità di un non rinunciare mai a interrogarsi e interrogare, su se stesso, sull’altro, sulla follia, sulla ragione. Interrogarsi e interrogare in modo radicale, cercando di riportare a nudo gli uomini e le cose per di lì ogni volta ripartire, che infondo corrisponde allo sforzo più autentico della fenomenologia.
Ancora, il rapporto tra il mistero della follia, nella sua relazione complessa con il soggetto e la sua libertà, e il dato storico della malattia mentale (il cui rischio di scivolamento semantico verso una “malattia cerebrale” è sempre in agguato) come è definita, codificata, assoggettata e addomesticata dalla medicina. L’idea dell’esitazione come esigenza di lasciare spazio all’altro prima di costringerlo in una definizione, prima di rifiutare cartesianamente che la follia – la sua e la nostra follia - possa essere parte del discorso. La relazione complessa tra il modo di darsi della follia e del suo rifiuto nella storia, il discorso (i discorsi) che la ragione fa sulla follia e la storia stessa, come l’ha indagata Foucault.
E poi una chiara presa di posizione di Rovatti, sulla quale bisognerebbe sì, tra psichiatri, non cessare mai di confrontarci: «Dopo la 180 ci sono due strade. O smettere di fare gli psichiatri, oppure essere gli psichiatri che si mettono al servizio di una situazione nuova e che quindi diventano i tecnici dei nuovi servizi di cura. Basaglia crede che non si debba abbandonare la psichiatria, e quindi neanche che si possa cancellare completamente quell’elemento di potere che la psichiatria contiene. Lo psichiatra mantiene un potere sul paziente e questo potere deve essere controllato, da chi? Dalla scienza o dai malati? La risposta di Basaglia è netta: dai malati. Quindi, restituire la soggettività significa passare attraverso i rapporti di potere» (p. 191).
Ma saranno davvero in grado, i malati, con la loro ragione intermittente e claudicante, di assumersi realmente, autenticamente, questa responsabilità? E noi, come possiamo essere controllati da qualcuno sul quale manteniamo comunque un “elemento di potere” e, a nostra volta, di controllo perché il controllo è implicito nel potere?
Come contraddizione, non è male questa con la quale cii confrontiamo quotidianamente, nei luoghi dell’urgenza come in quelli della riabilitazione: restituire potere (o meglio aprire spazi perché l’altro, che è colui che ha meno potere di tutti, che in quanto folle non è considerato soggetto possibile ma solo oggetto di ogni possibile discorso, possa appropriarsi di potere), mantenendo inevitabilmente per noi la riserva di qualche “elemento di potere”. Trovare ogni volta, caso per caso, l’equilibrio più avanzato possibile, un equilibrio comunque instabile e oggetto di continua ridefinizione e rinegoziazione. Come al mercato di Marrakesh, direbbe Rotelli. Vincere la paura che evoca la follia, quella degli altri e la nostra per riportarla nella città - costruita per essere un’organizzazione pulita, ordinata, razionale, rispettosa dello spazio privato di chi ha uno spazio privato - che di lì l’ha espulsa, e lì imparare a tollerarla, trovare modalità di convivenza che non implichino lo scambio tra la libertà e le vite di alcuni e la domanda di tranquillità degli altri. Aprire alla follia uno spazio nel discorso, senza però farcene sommergere.
Leggendo queste pagine, mi pare che la proposta rivoluzionaria e radicale di Basaglia, la sostanza della 180 infondo possa essere questa, una radicale rivoluzione antropologica capace di aprire spazi maggiori alla propria e all’altrui follia, spazi maggiori di libertà e di tolleranza; molto di più insomma che una riforma in senso umanitario dell’assistenza psichiatrica (che già sarebbe, comunque, importante). E con questo noi nuovi operatori psichiatrici, quelli della 180, dobbiamo misurarci ogni volta che un soggetto, un familiare, un condomino, un poliziotto, un giudice ci scrivono che hanno paura della follia e ci chiedono – a volte anche in modo talora isterico e prepotente, ultimativo - valutazione, competenza, responsabilità, rassicurazione, aiuto. E ci mettono di nuovo di fronte alla domanda di fondo della psichiatria: chiudere o aprire.
Questo secondo volume di Rovatti per la collana 180, Le nostre oscillazioni. Filosofia e follia, ha a che fare, mi pare, con le stesse questioni di fondo ma le affronta da un altro lato, quello della filosofia. In esso l'Autore ripropone vent’anni dopo questioni che aveva affrontato con un altro agile libello, La follia, in poche parole (Bompiani, 2000), nato da un corso di formazione tenuto agli operatori dei servizi di salute mentale triestini intorno ad alcune parole chiave: la follia, l’altro, il corpo, il gioco.
E ricorda come negli anni ’60-’70 vari intellettuali (Foucault e Basaglia, ad esempio) si siano sforzati di individuare - nello stretto iato tra la psichiatria classica che è poi tornata a prevalere e la oggettivizza come malattia, e l’antipsichiatria che la mitizza – un posto e un senso per la follia. Una funzione anche, se vogliamo, che è quella di fare da contraltare oscuro alla lucidità della ragione, e di consentire così al pensiero di rimanere aperto, insaturo, inconcluso, “oscillante” per mantenere l’espressione di Rovatti tra la ragione che sappiamo, che ben conosciamo nella sua consequenzialità, e un’altra cosa che ne costituisce il contrario e non sappiamo, non conosciamo ma della quale avvertiamo oscuramente la presenza: la follia. Che ci è ignota ma ci è anche indispensabile, e perciò è qualcosa di cui tutti gli uomini fanno, in maggiore o minore misura, esperienza; che non può essere considerata un difetto del pensiero ridotto a ragione, e neppure essere esaltata al punto di essere colta come la perfezione del pensiero, dal quale perciò è la ragione a dover essere espulsa. Che sta lì, dentro il pensiero, una forma altra del pensiero che deve coesistere in un rapporto dialettico con la ragione perché il pensiero non si irrigidisca correndo il rischio di perdere la capacità di dubitare, oscillare, aprirsi all’ignoto, che è ciò che lo vivifica e lo rende, infondo, così dolcemente umano.
Per aprire uno spazio alla follia è indispensabile insomma aprire alla diversità, all’instabilità, all’indecidibilità.
E qui si pone, credo, un’altra questione, quella del rapporto tra follia e libertà, che può essere letto in due modi. Da un lato considerando la follia come lo stato di massima libertà, nel quale il folle esprime, senza porsi il problema di limiti e vincoli imposti dalla propria o altrui ragione, il sé più autentico, il vero se stesso al quale deve essere concesso (nei limiti possibili, forse) massimo spazio. è questa la posizione degli antipsichiatri per i quali la storia della psichiatria è storia dell’oppressione dei folli, e come in un gioco di ribaltamento tra figura e sfondo, quelli che agli storici della psichiatria appaiono come gli errori e le esagerazioni nei quali la psichiatria è incorsa nei secoli, ne sono invece i momenti emblematici (ricordo di avere assistito, in occasione di un convegno della WPA a Firenze, a una contromostra di Scientology nella quale esattamente questa era la rappresentazione). Ma dall’altro lato, considerandola come una malattia che colpisce il soggetto nella sua ragione impedendone il funzionamento, la condizione della massima coazione della sua libertà della quale il soggetto deve essere aiutato a liberarsi (Henri Ey parla della psicosi come “patologia della libertà” e la psicopatologia fenomenologica del delirare come dell’essere prigioniero del delirio, impossibilitato a qualsiasi pensiero che esca dal delirio). Libertà nella follia; o libertà dalla follia, insomma? Nel primo caso lo psichiatra, con tutti i suoi strumenti, si sentirà e sarà avvertito come l’oppressore che impedisce, con l’imporgli i vincoli della società, alla libertà del soggetto di esprimersi; nel secondo, sarà il “liberatore” che generosamente si adopera a guarire il soggetto dalla malattia, per restituirlo così propria autentica libertà (ed è questa infondo la storia (il mito?) che noi psichiatri ci raccontiamo e tramandiamo).
Credo che questa alternativa non abbia soluzione e se lo psichiatra si sofferma a interrogarsi sul proprio atteggiamento verso la follia si accorga di oscillare – prendo a prestito questo termine pregnante dal titolo del volume - tra fermarsi talvolta ad ascoltare e contemplare la follia nel suo mistero e nella sua fascinazione, e impegnarsi altre volte a contrastarla per liberare il soggetto dalla crudeltà, dalla coazione e dalla deturpazione dei suoi morsi, che l’accomunano a ogni altra forma di sofferenza ed eventualmente malattia. E forse, mi viene da pensare, possiamo immaginare il rapporto con la follia (come quello con il gioco, infondo) come quello con qualcosa che sta di fronte a noi; possiamo salirlo in qualche misura e curiosare oltre, spiare, flirtare magari con lei e questo può ampliare il livello della libertà di cui godiamo. Ma non dobbiamo cadere dall’altra parte, o la follia, il delirare si trasformano nella mancanza di libertà. Forse, anche nella perdita dell’alterità.
Mi accorgo che sto procedendo a tentoni, e perciò ritorno al testo. Un problema sul quale Rovatti si sofferma è il rapporto tra ragione e follia dal punto di vista della storia, e lo affronta rievocando la polemica che ebbe protagonisti Michel Foucault e Jacques Derrida. La tesi di fondo della Storia della follia nell’età classica di Foucault è nota: la follia sarebbe stata messa a tacere, nella storia europea, dal Grande internamento del Seicento e poi definitivamente silenziata dalla nascita della psichiatria moderna nell’Ottocento. Quindi, mi pare di comprendere, per scrivere la storia della follia sarebbe stato necessario scrivere la storia di un silenzio, che dà semmai qua e là segno del proprio mormorio represso; ma siccome un silenzio è indicibile in parole, l’operazione di Foucault - osserva Rovatti - si risolve nell’essere in realtà una storia della ragione, delle pratiche sociali con le quali la ragione silenzia la follia. Per Foucault (così mi pare di poter sintetizzare il ragionamento), da Cartesio a Freud e oltre ogni volta che la ragione evoca la follia, con ciò stesso la mette a tacere, facendone un suo oggetto, leggendola con le proprie lenti. Per Derrida invece ogni volta che viene evocata, la follia è comunque presente come assenza, paradossalmente presente perciò, carta del mazzo – le efficaci metafore sono di Rovatti – che sta fuori dal mazzo, la pagina bianca nel libro, l’assenza delle quali contribuisce a renderle evidenti. Una paradossale presenza dell’assenza, perciò. E Rovatti sostiene che ciascuna delle posizioni, aspramente contese dai due interlocutori, contiene un pezzo di verità e si chiede qual è la posizione di Foucault rispetto al muro che separa ragione e follia, nel momento in cui scrive una storia del silenziamento della follia usando indubbiamente le lenti (il linguaggio, il rigore logico) della ragione. E la risposta che propone è spiazzante: la sua posizione è stare in un equilibrio instabile e rischioso a cavallo del muro, oscillando tra l’una e l’altra parte nel momento in cui continua ad appartenere indubbiamente alla ragione, ma si sporge sulla follia sforzandosi di coglierne il più possibile il mormorio che si fa a volte gemito e, direi, comprenderne empaticamente il punto di vista, ciò che essa può avere da dire sull’uomo e sulla storia.
Impegnato, in modo forse un po’ donchisciottesco, a farsi paladino delle sue ragioni, della sua possibilità, di quello che ha da dire, di una muta testimonianza. Traduttore forse, con tutte le ambiguità e i rischi che quest’operazione comporta. A cavallo, per di più, di un muro che insieme c’è e non c’è: perché un po’ di follia abita sempre la ragione, e non esiste forse follia che non sia anche contaminata da briciole di ragione. E una tradizione popolare, che nasconde forse nella carica retorica più che un briciolo di verità, recita che c’è sempre saggezza nelle parole degli uomini folli, e follia in quelle degli uomini ragionevoli. Ma non è, infondo, quella su quel muro la posizione che anche il nuovo psichiatra, per come Basaglia lo immagina, dovrebbe assumere a sua volta?
Attraverso la ricostruzione della polemica tra Foucault e Derrida, e forse tra Foucault e Foucault stesso, quando decide per ragioni sulle quali il filosofo modenese s’interroga e costituiscono già in sé un enigma, la soppressione della prefazione alla prima edizione della Storia della follia (recuperata per la seconda edizione italiana curata cinquant’anni dopo, nel 2011, da Mario Galzigna per Rizzoli). Rovatti insiste: è difficile parlare della follia, è un oggetto che continuamente sfugge e si duplica in un gioco di continui riverberi con la ragione che è impossibile conoscere in modo definitivo. è oggetto di continui tentativi di neutralizzazione, ma al contempo è ineliminabile.
La follia: Rovatti ce la fa ritrovare nel nostro rapporto con l’altro, in quello con il nostro corpo, nei giochi logici di due testi fondamentali: Nodi di Ronald Laing e Verso un’ecologia della mente di Gregory Bateson. Per poi metterci in guardia, e sono le ultime pagine - senz’altro coraggiose e non scontate - da una trappola: quella di considerare la follia, nella sua essenza, sofferenza, che è un modo certo più umano, empatico, meno saccente di considerarla ma non è poi così lontano, infondo, dal considerarla solo malattia. Perché la follia è sì anche sofferenza, una sofferenza che abbiamo il compito sicuramente di lenire, ammette, ma non dobbiamo dimenticarci, nell’avvicinarla con rispetto, che non è solo quello; è forse anche verità (una possibile verità certo, auspicabilmente non la Verità) forse in cerca di attenzione. è mormorio, rumore di fondo che vuole essere ascoltato (senza che, però, ci se ne lasci ammaliare). E credo che proprio tenere aperta questa contraddizione – la cura e l’ascolto – che Rovatti mette in luce con chiarezza, sia la cosa più difficile quando s’inciampa nella follia, la propria o quella dell’altro non importa.
Non so, insomma, se ho ben inteso né ben sintetizzato la complessità di quello che Rovatti intende esprimere, ma mi sembra che abbia a che fare con questioni imprescindibili e importanti quando ci si avvicina alla follia, quando ci si sforza di conoscerla e di concettualizzarla. Ma certo credo che l’allarme con cui l’Autore introduce le sue considerazioni vada raccolto: questi primi vent’anni del nuovo millennio hanno visto l’affermazione, nella cultura generale ma forse ancora più drammaticamente nel mondo psichiatrico, di un pensiero unico fatto di semplificazioni ad ogni costo, classificazioni categoriali, allineamento, riduzione dei soggetti a numeri, ideologico riduzionismo cerebroiatrico, disciplinamento e omologazione delle pratiche. Per il pensiero critico, i dubbi, le oscillazioni sembrano non esserci posto né attenzione. E tanto meno per l’atteggiamento indispensabile per la possibilità della fenomenologia: la riduzione fenomenologica, la sospensione di giudizio (il giudizio deve anzi essere oggi folgorante, immediato, sintetico, possibilmente espresso ad alta voce, aggressivo, autoritario e ultimativo), l’enigma dell’intersoggettività. Nessun enigma, nessun dubbio, nessuna obiezione che intralci! Figuriamoci se posto e attenzione, ascolto possono esserci, quindi, per la follia, con il suo mormorio timido e sofferto, fragile, confuso, il mistero delle sue oscure illuminazioni, le sue chiaroscurali oscillazioni ed i suoi dubbi.
Nel video allegato la lezione di P.A. Rovatti: “Un’oscillazione ci può salvare”.









Commenti
PUOI ABBONARTI AL CANALE YOUTUBE DI PSYCHIATRY ON LINE ITALIA.
Si parte da 2,99 € al mese.
E' un modo semplice per supportare il nostro lavoro on line.
SEGUI IL LINKPER FARLO : https://www.youtube.com/watch?v=4rKvnJE-My0