LA VOCE DELL'INDICIBILE
I suggerimenti della rêverie degli Artisti
Farmaci antipsicotici: strumenti di cura o di controllo sociale e repressione?
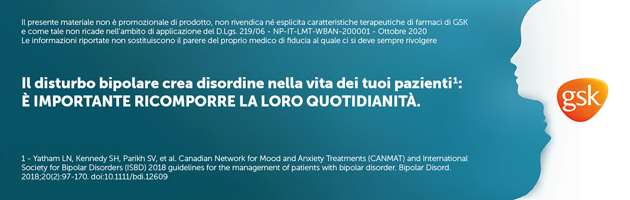 Perché impedire ad una persona, con mezzi farmacologici, di delirare? Se il medico non si pone questa domanda, e se non si dà una specifica risposta di fronte a ciascun caso, il suo intervento rischia d’essere autoritario, intollerante, al servizio (di fatto) di un potere politico che non tollera alcuna forma di dissenso o anticonformismo; un intervento che di autenticamente terapeutico non ha proprio nulla. Cerco di spiegarmi con un linguaggio comprensibile a tutti; gli “addetti ai lavori” potranno[NS1] capire facilmente di cosa sto parlando. Ritengo quest’argomento particolarmente importante e attuale; ragione per cui, pur essendo “off topics” nella mia rubrica, pubblico ugualmente qui questa discussione.
Perché impedire ad una persona, con mezzi farmacologici, di delirare? Se il medico non si pone questa domanda, e se non si dà una specifica risposta di fronte a ciascun caso, il suo intervento rischia d’essere autoritario, intollerante, al servizio (di fatto) di un potere politico che non tollera alcuna forma di dissenso o anticonformismo; un intervento che di autenticamente terapeutico non ha proprio nulla. Cerco di spiegarmi con un linguaggio comprensibile a tutti; gli “addetti ai lavori” potranno[NS1] capire facilmente di cosa sto parlando. Ritengo quest’argomento particolarmente importante e attuale; ragione per cui, pur essendo “off topics” nella mia rubrica, pubblico ugualmente qui questa discussione.

Da un punto di vista psicopatologico, è bene non dimenticare che i deliri sono sintomi “reintegrativi” (Freud): benché rientrino nella patologia, sono modi con cui il pazienta evita la completa disintegrazione schizofrenica della sua vita interiore. Costruendosi un’immagine del mondo diversa da quella reale, il malato crea le condizioni che gli consentono di sfuggire a lacerazioni interiori. Il suo mondo interno mantiene la sua compattezza ed evita di dissolversi, a differenza di quanto avviene in altri casi di schizofrenia. In effetti, le forme “paranoidi” (deliranti) di questa malattia sono quelle a prognosi migliore.
Per quale ragione, quindi, e in che modo utilizzare correttamente gli antipsicotici? Purtroppo, nella maggior parte dei casi, il delirio crea una barriera fra il paziente ed il resto del mondo. Le incomprensioni ed i conflitti coi propri simili sono all’ordine del giorno. Tutto questo, inevitabilmente, danneggia il malato sul piano emotivo e sociale, il che finisce per riflettersi negativamente, in vari modi, anche sulla sfera biologica, già alterata dalla malattia. Siamo sicuri che il paziente non se ne renda conto? Che non capisca del tutto che il suo modo di essere e di pensare lo sta danneggiando? Rispondere a questa domanda fornisce già un primo criterio per l’uso corretto, ossia terapeutico, dei farmaci antipsicotici.
In molti pazienti deliranti (la maggior parte? tutti?) esiste un “doppio registro”: ad una parte psicotica del mondo interno, se ne affianca un’altra rimasta sana, ossia aderente alla realtà esterna e in grado di comprendere in modo realistico quel che sta succedendo. Il più delle volte è una parte nascosta, mascherata, per cogliere la quale è necessario che il terapeuta possegga una valida capacità di mettersi nei panni del malato, e ne faccia uso. Raramente questa parte sana assiste del tutto impotente e inerte ai danni che il malato si sta procurando. Tuttavia, per esprimersi, essa non può entrare in aperto contrasto con la visione delirante del mondo che, come spiegavo più sopra, rappresenta, per il malato, un mezzo irrinunciabile per mantenere la sua coesione interiore. Ecco il motivo per cui una sana richiesta d’aiuto, da parte di questi pazienti, si manifesta, il più delle volte, in modo implicito, allusivo, poco chiaro. Un esempio: l’atteggiamento minaccioso del delirante di persecuzione che tanto spaventa i familiari e chi lo circonda. In molti casi ho avuto la conferma che, atteggiandosi in questo modo, il malato implicitamente trasmette un messaggio che si può tradurre in questi termini: “qualcuno mi fermi, altrimenti faccio un macello!”. Prova ne è che un atteggiamento franco, deciso, fermo ma non punitivo, da parte dei curanti (se necessario, anche con l’uso della forza) finisce per non incontrare un’eccessiva resistenza al ricovero ospedaliero da parte di questi malati. Il paziente instaura un saldo legame con i curanti che l’hanno fronteggiato in questo modo (legame che può essere utilizzato a scopo terapeutico) perché, in ultima analisi, ha capito d’essere stato capito; cosa che non avviene con chi l’ha affrontato con la paura di chi non capisce, o con l’aggressività di chi sa esprimere solo giudizi moralistici, o con la falsa affabilità del “buonista”.

Che ruolo può avere il farmaco antipsicotico in un trattamento autenticamente terapeutico? Parlo di una cura che rappresenti la risposta ad una richiesta d’aiuto, che sia fondata sulla relazione col medico, ed il cui scopo sia restituire al paziente, il più possibile, la padronanza di sé stesso ed una vita per lui vivibile. Occorre premettere che una cura di questo genere ha il carattere di “esperienza correttiva”: rappresenta il supplemento, o il completamento, e la correzione di un rapporto coi genitori che, per vari possibili motivi (i fattori costituzionali di ordine biologico, e/o quelli ambientali e sociali, e/o quelli legati ai limiti e ad un basso livello di equilibrio interiore dei genitori stessi) si è rivelato insufficiente e/o inadeguato. In questo tipo di rapporto, il farmaco antipsicotico (e/o il ricovero coatto in ospedale) svolge lo stesso ruolo degli inevitabili interventi limitanti la libertà che anche il migliore dei genitori deve, all’occorrenza, imporre ai propri figli. Si tratta, cioè, di scoraggiare quelle tendenze “non maturative” che ostacolano una sana evoluzione mentale e sociale, e che si riscontrano nel minore e, mutatis mutandis, anche nel paziente delirante. Sono false scorciatoie, animate dall’esigenza narcisistica primitiva d’ottenere “tutto e subito”. Il bambino e l’adolescente adottano spesso comportamenti irresponsabili, ispirati da un ribellismo sterile, e dall’illusione d’essere già divenuti, di colpo, adulti in grado di gestire autonomamente la propria libertà. Allo stesso modo il delirante adotta la sua visione alterata del mondo come “scorciatoia” con cui s’illude d’aver colmato di colpo le proprie carenze interiori e d’aver risolto i conflitti col mondo esterno. Esattamente come l’intervento ragionevolmente repressivo del genitore che rientri in una strategia autenticamente educativa, anche l’uso dell’antipsicotico è necessario possegga il carattere di “frustrazione ottimale” (Kohut), ossia una limitazione del pensiero che sia commisurata al grado d’evoluzione raggiunto, in quel momento, dal paziente e soprattutto che sia temperata dalla comprensione empatica del curante: è necessario che questi comprenda empaticamente che una limitazione farmacologica della presunta libertà interiore non può essere piacevole per il malato; e che questi può accettarla (come il bambino con papà e mamma) solo se è sicuro che essa non è fine a sé stessa: se percepisce che nel contempo, il curante riconosce, favorisce, appoggia le sue potenzialità evolutive (le sue ambizioni più sane, le sue attitudini, i suoi interessi, i suoi scopi ideali) che possono portarlo ad una più autentica libertà interiore e ad una sua personale affermazione nel mondo. Quella del delirante, infatti, non è vera libertà: è la schiavitù nei confronti di una convinzione anomala che crea una barriera invalicabile fra il malato e i propri simili, impedendogli di capirli, di farsi capire e di rapportarsi in modo produttivo con loro; crea, inoltre, una barriera con la sua parte sana che le impedisce di prevalere in lui.

Rispondo anticipatamente all’accusa di “paternalismo” che potrebbe essere mossa all’impostazione della cura che ho più sopra esposto. La respingo: il paternalismo inteso come atteggiamento sostanzialmente autoritario è un atteggiamento adottato nei confronti di persone adulte, dotate di autonomia e di senso di responsabilità, il cui scopo è renderle come bambini da tenere perennemente “sotto tutela”. I pazienti psicotici non sono adulti autonomi: sono come bambini che hanno bisogno di cure adeguate per poter crescere. Sarebbe assurdo accusare di “paternalismo” i genitori attenti alle necessità dei propri figli. Come questi genitori con la propria prole, il medico che sappia fare il proprio mestiere vedrà, come scopo del suo lavoro, rendere il malato autonomo, libero, capace di realizzarsi, e non perennemente sottomesso e dipendente da lui. Come i buoni genitori coi figli, considererà, quindi, la propria autorità sui malati come tipo di rapporto destinato ad aver termine appena raggiunto il suo scopo.
Più insidioso è il rischio che lo psichiatra divenga un puro strumento di controllo sociale, al servizio, di fatto, dell’autorità politica vigente, e non della persona del malato. È un rischio che si corre soprattutto quando si commette l’errore di considerare il delirio come tale più per il suo contenuto, ritenuto “non aderente alla realtà”, che per le altre caratteristiche di questa patologia. Siamo sicuri che la convinzione, di solito singolare, del presunto delirante non sia “aderente alla realtà”? Come possiamo escludere che l’opinione di noi curanti, di solito condivisa dalla maggior parte delle persone, non sia essa stessa delirante? È l’errore che, nella storia, ha portato all’uso perverso della psichiatria come modo per zittire il dissenso politico, e in generale l’anticonformismo, da parte dei regimi autoritari. Per evitarlo, occorre tener presente, come ci ha suggerito Jaspers, che il delirio è essenzialmente una convinzione ferrea, immune dal dubbio, incrollabile, refrattaria alla più paziente e documentata delle confutazioni logiche, resistente persino di fronte all’evidenza dei fatti. Come tale, oppone un serio ostacolo alla capacità di comprensione empatica che possiede la maggior parte delle persone; è necessario che il terapeuta ne disponga in misura maggiore ed in una forma particolarmente acuta. In questo caso, il rapporto col paziente diviene più flessibile: maggiore diviene la tolleranza nei confronti dell’opinione del paziente che il curante non condivide, e minore l’importanza attribuita a dichiarazioni del paziente ritenute “non conformi alla realtà”. L'obbiettivo da raggiungere non è tanto che il paziente "cambi idea" sul mondo, quanto piuttosto che divenga più aperto al dubbio e disponibile a correggere le sue convinzioni qualora emergano fatti, per lui nuovi. Compito del medico non è certo quello di togliere al paziente la libertà di scegliersi le sue opinioni, indipendentemente dalla loro natura.
Aggiungo un post-scriptum di natura strettamente tecnica, ad uso degli “addetti ai lavori”. Gli antipsicotici che più si prestano all’uso suggerito più sopra sono quelli di ultima generazione. Alludo agli agonisti dopaminergici “parziali”, come ad esempio l’aripiprazolo. A differenza dei precedenti antipsicotici (antagonisti “puri” dei recettori D2), riducono gli effetti della dopamina sul nucleus accumbens quando essi sono in eccesso, ma li incrementano quando sono in difetto. Si prestano, quindi, ad un effetto anti-delirante più “soft”, più compatibile con il trattamento psicoterapico del delirio. Il paziente delirante non viene zittito del tutto, e può abbandonare più gradualmente la sua convinzione anomala, mentre, nel contempo, si lavora per rendergliela non più necessaria.








