IL SOGGETTO COLLETTIVO
Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale
Com’è difficile concepire la probabilità!
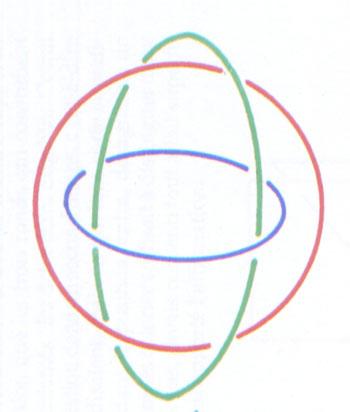
J.M. Keynes, A treatise on probability, 1920, cap. III
È tuttora difficile pensare razionalmente la probabilità. Perché? Perché è il portato di un’evoluzione epocale del pensiero collettivo, che dura da quattro secoli e non è ancora finita, per certi filosofi – penso agli esistenzialisti – non è neppure cominciata. Oggi, per affrontare il pensiero probabilistico, abbiamo due opzioni, a seconda che si tratti della probabilità di eventi o della probabilità di enunciati: la prima frequentista o oggettiva, la seconda bayesiana o soggettiva.
La prima opzione, ontologica, opera in contesto cognitivo; identifica la probabilità di un evento con la frequenza nella serie potenzialmente infinita delle prove, espressa dal rapporto tra numero di eventi e numero di prove; è l’opzione più antica, sostenuta addirittura da Aristotele.[1]
La seconda opzione, epistemica, opera in contesto operativo; identifica la probabilità di un enunciato con il prezzo equo pagato per ottenere un guadagno unitario al verificarsi dell’evento previsto dall’enunciato. In contesto soggettivo la probabilità è previsione, non predizione, precisa de Finetti; è la certezza media nel contesto incerto della scommessa.
Per Keynes, la probabilità ha due dimensioni: sintattica e semantica; sintatticamente, è una forma di argomentazione (argument) che poggia sul peso relativo di certi argomenti rispetto ad altri; semanticamente, è un grado di credenza (degree of belief), misurato quantitativamente, compreso tra zero, nel caso impossibile, e uno, nel caso certo. Le due opzioni producono teorie equivalenti, ma con finalità pratiche diverse. Personalmente ritengo l’opzione oggettiva meno scientifica della soggettiva, perché basata sulla conferma delle frequenze, ma non ha criteri di confutazione. Una scienza senza possibili confutazioni è astrologia. È l’obiezione che si fa alla psicanalisi.
Particolarmente difficile è agire in modo rigorosamente casuale. L’azione presuppone un algoritmo che fissi la successione degli atti; ma, se c’è algoritmo, c’è determinismo e la casualità evapora. Ci si deve accontentare di procedure che generano numeri pseudocasuali, equiprobabili e privi di correlazioni lineari, come gli algoritmi congruenziali, che calcolano i resti di divisioni successive per un numero fisso molto grande. L’uomo non riesce a battere su un tamburo in modo casuale, senza seguire un ritmo, cioè senza un determinismo. Ciò è connesso alla finitezza della macchina umana. Prima o poi, in algoritmo finito deve finire e ricominciare da capo, quindi non può essere casuale. Il fenomeno casuale convoca di necessità l’infinito, l’oggetto fobico della cultura classica. La fobia dell’infinito si basa sul principio di ragion sufficiente. Il pensiero classico è storicistico e deterministico, cioè pensa le cause che producono effetti nel tempo. Se la successione delle cause è infinita, è impossibile identificare la “causa prima”. Allora il filosofo intavola l’eterna ripetizione dell’identico e con una fava prende due piccioni: nega insieme causalità e casualità. La prima negazione lo avvicina alla scienza moderna, la seconda lo allontana. Sta qui la singolarità di Nietzsche, pensatore tra antico e moderno, che in Gaia Scienza (1882) usò wahrscheinlich solo nel senso di “enunciato verosimile” mai di “evento probabile”, come Freud del resto.
Da dove derivano le difficoltà, allora? Essenzialmente, da quanto appena detto, dall’essere quello del caso un discorso opposto a quello della causa, determinata con certezza sin dai primi filosofi ilozoisti, che si sforzavano di pensare la prima causa di tutto. Tradizionalmente non si può pensare ciò che è, senza supporre la causa che lo fa essere: l’acqua, l’etere, l’omeomeria. Non c’è fenomeno senza causa; da Aristotele in poi tutta la fenomenologia poggia sulla certezza dell’assioma eziologico, applicato “a prescindere”. La scienza eziologica è la storia; è lei da sempre a stabilire la “causa” dei vincitori.
Si apre qui la frattura tra le “due culture”: le scienze umane, che “comprendono” (begreifen) la natura dell’uomo, riconducendola a schemi eziologici, che così si confermano, e le scienze della natura, che “spiegano” (erklären) i fenomeni naturali attraverso simmetrie da confutare. La natura congetturale della probabilità, in genere delle galileiane “sensate esperienze e dimostrazioni necessarie”, non è ammessa da chi vuole comprendere la natura dei fenomeni. Ma oggi è giunto il tempo di sapere Because without cause.[2]
La mia opinione, derivante dalla pratica dell’inconscio, inteso come sapere che non si sa di sapere, situa il discorso probabilistico là dove abita l’inconscio, al giunto problematico – origine di tutte le incertezze – tra ontologia ed epistemologia, tra essere e sapere. Il luogo fu individuato da Cartesio, ma fu poco frequentato dalla filosofia accademica, che si è distinta per volontà di ignoranza, a favore di certezze metafisiche. Del resto, neanche Cartesio trattò la probabilità, nel senso dell’accadere di fenomeni aleatori. Il problema è come arrivare a sapere ciò che non esiste ancora, ontologicamente indeterminato, “potenziale” avrebbe detto Aristotele, “preontico”, disse a proposito dell’inconscio Lacan, che con la stocastica ebbe qualche familiarità. La probabilità confina con il luogo di elezione del discorso eziologico, dove si presuppone una causa per ogni effetto e si racconta la storiella “sensata” di come l’effetto si produce in presenza della causa, lasciando impregiudicato il caso della sua assenza. Si chiama principio di ragion sufficiente. È sufficiente a garantire l’ignoranza, coperta da una scienza di impianto storico: i fatti sono sempre determinati da fatti precedenti; la certezza sempre storica; la verità sempre narrativa. Verum et factum convertuntur. La storia dà senso alla vita, narrata nei romanzi, nei tribunali e nelle cartelle cliniche degli ospedali.[3] La narrazione del senso nutre la vita collettiva. O si vuole lasciarla a digiuno?
La verità eziologica è narrativa, diacronica; presuppone una sola causa per ogni effetto; è monofattoriale. La verità probabilistica è sincronica; presuppone più cause per un solo effetto. È polifattoriale; abita fuori dal tempo nello spazio delle possibilità. Il calcolo delle probabilità è la logica del possibile, secondo Keynes, che si spostò dalla probabilità degli eventi alla probabilità delle proposizioni sugli eventi, facendone un discorso indiretto. Aristotele non conobbe la transizione. La difficoltà epistemica consiste nel riconoscere che le frequenze di una serie stocastica, per esempio del lancio di una moneta, sono localmente irregolari ma globalmente regolari; in piccolo sono permesse le più bizzarre variazioni nelle frequenze di un evento, purché nulla vari in grande; la probabilità che, lanciando una moneta, esca Testa è sempre ½, nonostante gli infiniti (e sempre meno probabili) spostamenti locali da ½. Tutto cambia purché nulla cambi; la probabilità è gattopardesca; sfugge a definizioni razionalistiche.
La probabilità esordisce nei giochi d’azzardo, i cui eventi non sembrano avere causa perché hanno tutti la stessa causa, da cui nacque la nozione laplaciana di equiprobabile, la prima formula del calcolo delle probabilità (plurale!). Ma deve passare ancora molto tempo prima che il calcolo delle probabilità si formalizzi, dopo gli abbozzi di Cardano e Pacioli. La data convenzionale è il 1654, l’anno della famosa corrispondenza tra Pascal e Fermat. Il calcolo sarà assiomatizzato da Kolmogorov solo nel 1933, sulla scorta del lavoro di sistemazione della materia data da Laplace in Théorie Analytique des Probabilités del 1812.
Segnalo la notevole, ma tuttora sottovalutata, nota di Galilei, Sulla scoperta dei dadi (1612), che spiega un’apparente quisquilia: perché lanciando tre dadi è più facile fare 10 che 9, pur essendo uguale il numero delle loro somme? Spiegando il fatto curioso, Galilei inventò il metodo moderno di costruzione dello spazio dei campioni, qui le triplette delle “scoperte” dei dadi. In un dato futile vide la connessione tra meccanica e probabilità, che tre secoli dopo prenderà consistenza definitiva in meccanica quantistica nel principio di indeterminazione di Heisenberg (1926, da Freud ignorato). Certe coppie di variabili (ora dette osservabili) – velocità e posizione oppure tempo ed energia – non sono misurabili insieme con la precisione voluta: determinarne una lascia indeterminata l’altra. È la scienza, bellezza!
Grazie alla probabilità, il vecchio discorso eziologico si trasforma in discorso dell’inferenza o dell’induzione. Si chiede quale sia la probabilità che una certa causa abbia prodotto l’effetto. Sfrutta l’algoritmo statistico dell’ipotesi zero. Calcola la probabilità che un effetto come quello osservato, o maggiore, si produca in assenza di cause. Se tale probabilità è inferiore a una soglia arbitrariamente prestabilita di significatività, si conclude che il fenomeno ha una causa, per esempio il trattamento terapeutico in un esperimento randomizzato. Il bosone di Higgs fu scoperto da dati distanti cinque volte la deviazione standard dal rumore di fondo, pari a circa qualche milionesimo di probabilità dell’ipotesi zero. C’è da scommettere che qualcosa di simile al bosone di Higgs esista davvero, come previde la teoria delle particelle. NB. I risultati sperimentali non esisterebbero se non fossero previsti dalla teoria, che predispone i dispositivi sperimentali per registrarli. In un certo senso i risultati sperimentali sono determinati dalla teoria, prima che dall’esperimento.
Tuttavia, la cittadella eziologica è difficile da espugnare, blindata com’è da un potente discorso millenario, per la precisione eziopatogenetico, cioè dalla medicina, fondata da Ippocrate.[4] Che dà man forte alla filosofia, non essendo disposta ad accettare fenomeni senza causa, come il moto inerziale nella dinamica galileiana, ignota agli antichi, perfino ad Archimede. Perché questo non voler sapere? Semplice, perché il discorso medico è il discorso delle contro-cause. Se togli la causa, togli la ragion d’essere all’azione terapeutica del medico, che agisce contro la causa morbosa, per ristabilire lo stato pre-morboso, quando ci riesce. Il discorso medico è in essenza finalistico. Il finalismo è presente in ogni filosofia dell’azione.
L’approccio medico, codificato da Freud nella metapsicologia delle cause pulsionali efficienti e finali, le prime sessuali, le seconde di morte, ha rischiato di rendere non avvenuta l’invenzione freudiana dell’inconscio, l’unica invenzione scientifica del dott. Freud. Il sapere inconscio, che non si sa di sapere, è una congettura scientifica, che la metapsicologia rischia di vanificare. Per paradosso, la psicanalisi si è salvata dall’oblio proprio grazie alla sua versione psicoterapeutica, che tuttavia ora la sta strangolando. Freud lo previde e nella postfazione alla Questione dell’analisi laica (1927) lanciò l’allarme: “Pretendo solo la garanzia di sapere che la terapia non colpisca a morte la scienza”.[5] Nella traduzione ufficiale italiana fu silenziato così: “Voglio solo cautelarmi, ed esser sicuro che la terapia non soverchi la scienza”.[6]
Mi chiedo se esista qualcosa che accomuni la resistenza a concepire correttamente la probabilità nell’uomo comune, che gioca al Lotto i numeri ritardatari, e nell’uomo di scienza, che sostiene che Dio non gioca a dadi (Einstein). A parte il fatto che la pulsione al gioco è più forte dell’ignoranza, nell’uomo opera un bisogno religioso di certezza, che il discorso probabilistico inevitabilmente smonta. In Freud ein gebieterisches Kausalbedürfnis (un “imperativo bisogno di causalità”) prese la forma di religione delle cause. Non a caso Freud confessò tale bisogno nel terzo saggio “scientifico” su L’uomo Mosè e la religione monoteista (1938), a 45 anni dalla minuta sull’eziologia sessuale delle nevrosi (Minuta B, 1893). Per l’ateo Freud Dio era inconscio; lo riconobbe Lacan nell’XI seminario. La religione vende certezze, ma la scienza non le compra. Preferisce congetture, che evolvono in altre congetture, mentre le certezze sono immobili. Le certezze religiose sono costruite in modo antropomorfo, alla larga da processi stocastici, analizzabili in modo meccanico con assiomi e formule matematiche; c’è, però, la dea Fortuna (Tuche) che distribuisce i numeri vincenti (e i perdenti) ai suoi prediletti. A ciascuno il suo.
Si pone la questione di come sarebbe la psicanalisi se Freud avesse adottato il calcolo delle probabilità invece dell’eziologia pulsionale. Esisterebbe ancora? Rassicuro i dubbiosi, aggrappati a certezze religiose: c’è una profonda affinità tra inconscio e probabilità. Le due teorie riguardano un sapere che non si sa di sapere, da trattare in via congetturale, mettendo da parte le eterne esigenze di certezza di marca religiosa, da credere per fede. La scienza fa a meno di Dio come Dio fa a meno della scienza, a maggior ragione della probabilità, sapendo già tutto. O ci identifichiamo con Dio?
O probabilità o religione: questa è la scommessa dell’uomo moderno. Chi intravide l’alternativa fu un grande matematico. Si chiamava Blaise Pascal. Intuì che la probabilità misura l’esistenza. L’intuizione rimase lettera morta per i grandi filosofi esistenzialisti moderni da Heidegger a Sartre, dai quali il significante “probabilità” fu estromesso dal discorso. Si apre qui il discorso sulla follia collettiva, dovuta alla fuorclusione del significante paterno; nel caso del rifiuto della probabilità come forma di pensiero non si vuole ammettere di essere incerti sull’esistenza del padre.









Commenti
Sempre più criptico ed autoreferenziale il buon dottor Sciacchitano. In questo ci somigliamo molto: "noi ce la cantiamo, noi ce la suoniamo" (elogio dell'autoreferenzialitá). Da buon vecchio esistenzialista fenomenologo che da sempre traffica con significanti e significati (per dirla con Lacan) in nome di un pensiero magico mai fin troppo nascosto mi incuriosisce intellettualmente il suo essere "radicalmente-Altro-da-me". La mathesis universalis che tracima dai suoi scritti confligge- direi amabilmente tuttavia- con le Geisteswissenschaften della mia intera vita. Indubbiamente lei è uno degli spiriti- guida (uso provocatoriamente questi termini idealistici e trascendentali) della mia formazione di uomo e di pensatore "agente".