IL SOGGETTO COLLETTIVO
Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale
La paranoia tra verità e certezza
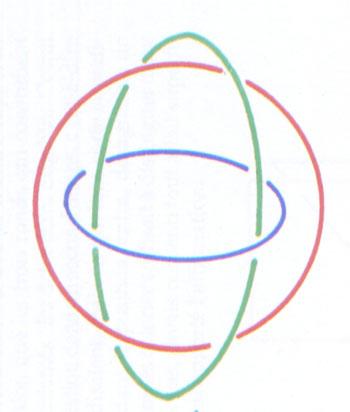
Il Medioevo non mutò l’assetto epistemico classico: la fede religiosa sa con certezza la verità, perché rivelata dall’alto. Il pensiero medievale perfezionò il sistema di garanzie del pensiero idealistico, istituendo il controllo pubblico del pensiero, che ne “certificava” la verità, da parte di Dio in prima istanza, della sua Chiesa in seconda. La sentenza di approvazione e conferma era codificata nella formula: Nihil obstat quominus imprimatur. Si pretendeva che la conoscenza fosse adaequatio rei et intellectus. In realtà era una richiesta di ortodossia; l’intelletto doveva adeguarsi innanzitutto alla dottrina stabilita, in seconda battuta alla cosa. Con la propria componente di certezza paranoica l’idealismo porta dritto al conformismo; perciò è amato e incoraggiato da ogni potere, antico o moderno, rivoluzionario o restauratore, credente o ateo. (I rapporti tra paranoia e potere sono un tema di studio della società psicoanalitica di Berlino Freud Lacan Gesellschaft.)
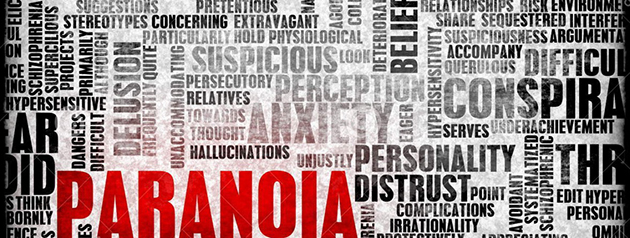
Nel collettivo di pensiero religioso il pensatore pensava da autorizzato da Dio o inviato da lui: era il suo profeta. L’aspetto profetico della trasmissione delle certezze, persino false, sopravvive in molte attuali scuole di pensiero, per esempio psicoanalitico. Sul finire del XV secolo il primo tempo della partita, ontologia vs epistemologia, si concluse 1 a 0 a favore dell’ontologia.
Le cose cambiano nel secondo tempo della partita, iniziato poco tempo fa e tuttora in corso (dall’esito incerto). In età scientifica il discorso muta radicalmente impostazione. Entra in scena il modo di pensare come dubitare, ma non in modo scettico e sterile come ai tempi di Pirrone. Il dubbio scientifico è fecondo: genera altri dubbi meno dubitabili. In questo processo epistemico il vero è solo congetturabile, quindi confutabile come non vero. La conferma passa in secondo piano: non si può più dire che il vero è vero perché è empiricamente vero. Bisogna aspettare la confutazione; emerge così il tempo di sapere. La verità scientifica non è più qualcosa di certo in assoluto e a priori (anche se non resta meno vera); può solo essere approssimata quanto si vuole, per esempio nei modi della topologia, privilegiando considerazioni locali rispetto alle globali.
La località è il punto dolente della transizione da antico a moderno. Già protagonista del calcolo differenziale, la località diventerà il nocciolo della teoria della relatività, secondo la quale non esiste il tempo assoluto universale, ma tanti “tempi propri”, ossia locali, tra loro non confrontabili (ordinamento parziale dei tempi già anticipato dalle equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico). L’uno globale decade a causa dell’avvento dei molti locali. Ciò è particolarmente evidente nella decadenza del tempo assoluto di Newton, che si sbriciola nei tempi locali di Einstein. Questa è la fisiologia del pensiero moderno, che arriva a concepire e a formulare matematicamente la logica dell’incerto: il calcolo delle probabilità, un’attività epistemica ignota ai classici, che sapevano matematizzare solo la nozione di misura geometrica, e solo parzialmente, come proporzionalità.
Ma l’idealismo è duro a morire. (Perché?) Sopravvive arroccato nella psicopatologia, forse a difesa dall’atavica paura dell’incertezza infantile: “Cosa vuole l’altro da me? La mia morte?”. Su questa base immaginaria la patologia del pensiero moderno si organizza attorno al ritorno del pensiero prescientifico rimosso, che offre false certezze. Si chiama paranoia, che con i propri deliri propone verità incontrovertibili sulla falsariga dell’idealismo classico. La paranoia è il fossile del pensiero prescientifico in epoca scientifica. Conferisce al pensiero quelle certezze che il pensiero, essendo scientifico, non può più avere. (Forse questa è la funzione ultima e lo scopo di tutte le malattie mentali.) Innocua quando si esprime nel delirio individuale, persecutorio o megalomane, la paranoia è però pericolosa quando diventa collettiva e pretende imporre al mondo le proprie certezze tanto assolute quanto indimostrate. Oggi c’è un’ampia varietà di scelta tra paranoie collettive non poco pericolose: i gradi di libertà di scelta della paranoia si estendono dal movimento antivax al terrorismo islamico.
Fuori dalla psicopatologia, sopravvive una forma debole, ma ben radicata e molto diffusa, di paranoia collettiva; è poco vistosa, perché non coltiva deliri, né di persecuzione né di grandezza; è una forma di diffidenza verso il nuovo metodo scientifico di trattare la verità; reincarna la nostalgia umanistica per i vecchi tempi in cui il vero era certo; oggi, in epoca scientifica, si ripropone come resistenza alla scienza (di cui soffrono perfino gli scienziati); allora si confonde scienza con tecnologia, unificandole (e disprezzandole) sotto l’etichetta di scientismo.
Quel che ancora oggi ci rifiutiamo di pensare è il relativismo; non ammettiamo che la certezza sia meno universalmente certa: non sia più globale ma resti locale. Ci ripugna che il reale scientifico non sia qualcosa che esiste oggettivamente ed è dappertutto uguale a sé stesso, ma sia solo un movimento relativistico diverso in punti diversi dello spaziotempo. Non vogliamo riconoscere che il reale d’antan è morto. Non ci sono più delle cose là fuori, ma degli eventi, scrive Carlo Rovelli nel suo ultimo libro L’ordine del tempo (Adelphi, Milano). È anche il teorema di apertura del Tractatus di Wittgenstein: Il mondo è tutto ciò che accade. (Quindi non può essere descritto prima che accada nell’evento di misura, insegna la meccanica quantistica). L’oggetto è perduto sin dall’origine, insegnava Jacques Lacan, e il reale “non cessa di non scriversi”; è diventato logicamente impossibile. Ma non tutto è perduto; qualcosa si può ancora affermare: Cogito ergo sum, diceva il nuovo pensatore. “Sono” è l’evento locale conseguente al fatto che qui e ora “penso”; esisto par provision, finché penso. L’esistenza sarà contingenza anche per Darwin.
Sullo sfondo di queste incolmabili mancanze introdotte dalla località nella cogitazione, il pensiero scientifico è vivo e pensa la varianza, la covarianza e la controvarianza dei fenomeni; li inquadra nel calcolo tensoriale, che fa a meno della nozione newtoniana di tempo come flusso assoluto, testimone di tutti mutamenti fenomenologici del mondo. La paranoia, invece, è la paladina dell’ontologia delle essenze fisse e immutabili degli enti, date una volta per tutte e per sempre; esclude eventi e accadimenti nuovi e improvvisi. Detto in estrema sintesi astratta (“astratto” non è una parolaccia, ma indica una via di pensiero), la paranoia pensa per essenze e non per variabili. Prolunga la metafisica degli enti fissi, che invano Heidegger ha tentato di decostruire. Questa è la “normale” psicopatologia psichica, da cui non è esente neppure la teoria psicoanalitica, che non ha ancora imparato a pensare le variabili “mondane” e le loro correlazioni, trattandole con un’algebra adeguata.
Il dato psicopatologico da acquisire storicamente e da tenere presente anche nella nostra attualità è che la paranoia, intesa come pensiero certo (del vero come del falso), non esisteva ai tempi di Platone, per la semplice ragione che il pensatore, pensando già in regime di certezza ideale, non ne aveva bisogno. A quei tempi felici non esistevano le psicosi intellettuali (paranoia e il gruppo delle schizofrenie), anche perché sul mercato non c’era molta varietà di pensiero tra cui scegliere: o si pensava idealistico o si pensava scettico, ma la seconda opzione era per il non pensiero. Allora esistevano solo le psicosi affettive: tipicamente la furia e la melanconia e loro combinazioni. Per loro il diritto romano inventò la figura del curator, che non era un terapeuta ma il difensore del patrimonio familiare.
La paranoia, come malattia intellettuale, era ignota agli antichi. La paranoia è invece una malattia recente, una conquista – negativa – dell’epoca scientifica; la paranoia è la malattia intellettuale per eccellenza dell’epoca scientifica che reagisce alla scienza, tentando di renderla non avvenuta; è l’anticorrelato del procedere scientifico che procede dal dubbio; è la malattia che non conosce dubbi; è la malattia della certezza, non importa quanto falsa, purché codificata in un sistema dottrinario. (Parlo a chi ne sa.)
Ha, pertanto, un nemico, persecutore dichiarato, la paranoia: è l’uomo di scienza, il vero nemico delle certezze dogmatiche e dottrinarie.
Il primo a soffrire in modo plateale di questa moderna regressione psicopatologica fu il pontefice Urbano VIII, già Maffeo Barberini, che perseguitò Galilei inquisendolo; dal Pisano quel Maffeo si sentiva a sua volta perseguitato nelle proprie certezze catechistiche, pur essendo stato dapprima suo amico. Torna qui a fagiolo la teoria freudiana della paranoia come inversione di libido omosessuale da amore in odio, una teoria interessante nella clinica del soggetto individuale ma di applicazione problematica al soggetto collettivo.
Freud a parte, qui mi interessa sottolineare la posizione “umanistica”, conservatrice e antiscientifica, della Chiesa Cattolica, che capziosamente distingueva tra due certezze. Ammetteva la certezza matematica astratta (cioè la teoria copernicana) solo come esercizio algebrico sulla carta, ma professava quella concreta filosofica-teologica del mondo reale, ispirata all’idealismo aristotelico-tolemaico; naturalmente imponeva la seconda alla prima e bruciava chi non era d’accordo. Il processo e la condanna di Galilei fu il suo ultimo clamoroso atto di protervia. Fu un calcio di rigore che l’attaccante, l’Inquisizione, fallì clamorosamente, decretando la propria fine. (Ricorda per analogia il rigore fallito da Baggio nella finale mondiale Italia-Brasile del 1994).
Formalmente non diverso e non meno violento rispetto all’Inquisizione cattolica nel propagandare le proprie certezze, anche se con contenuti ideativi diversi, è il pensiero paranoico dell’attuale terrorismo islamico, animato dal delirio di grandezza di Allah. Non brucia streghe ed eretici; brucia sé stesso oltre a qualche casuale infedele di passaggio in convulse e scenografiche esplosioni di collera teologica. La paranoia passa facilmente all’atto, mi hanno insegnato alla scuola di Lacan. Le conferme sono tante, anche se in proposito mi resta qualche dubbio. Constato che l’Islam è una religione di seicento anni più giovane della cattolica. Ha dovuto passare e sta passando per gli stessi errori (orrori) della religione cattolica: le crociate, le inquisizioni, i roghi... (Parlo come chi ha avuto una profonda educazione cattolica, che non rinnega.)
A proposito di terrorismo islamico non posso non ricordare attonito che gli arabi hanno inventato l’algebra moderna ben otto secoli prima di Cartesio. Abu Ja’far Mohammad ibn Musa Al Khowarizmi , matematico, astronomo e letterato, vissuto tra il 780 e l’850 circa d.C., scrisse verso l’820 d.C. il trattato Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa al-mukabala. Ci insegnò a scrivere la matematica, cioè il sapere scientifico, in modalità che persino Euclide ignorava. Il nostro Leonardo Pisano, detto Fibonacci, lo studiò a fondo e lo importò in Europa alle soglie del XIII secolo. Einstein non avrebbe potuto scrivere la teoria della relatività senza l’algebra di Levi-Civita e di Ricci-Curbastro, il calcolo differenziale assoluto (con l’aiuto dell’amico Grassmann).
Oggi l’algebra serve a fare geometria, scrivendo gli invarianti degli spazi geometrici (per esempio, delle varietà topologiche e differenziali). Gli invarianti non sono elementi costanti appartenenti allo spazio; non sono figure dello e nello spazio, come quelle che riempiono i 13 libri di Euclide; sono enti (numeri, gruppi, anelli, campi), costruiti a latere dello spazio, i quali restano uguali a sé stessi applicando allo spazio certe trasformazioni (in topologia le trasformazioni di continuità). Non variando danno informazioni su ciò che, date certe trasformazioni, non varia spazialmente, per esempio, il numero di buchi o la caratteristica di Eulero. In un certo senso, l’algebra recupera in corner il discorso delle essenze che sembrava perso.
Avendo nostalgia del pensiero idealistico, essendo di suo tendenzialmente paranoica (supponendo che ogni fenomeno psichico abbia una causa, per Freud la pulsione), non essendo ancora transitata verso la scientificità, preferendo la scrittura narrativa (quella dei casi clinici che “si leggono come novelle”, diceva Freud), la psicoanalisi si sforza di evitare la scrittura algebrica delle variabili e delle funzioni; allora si adagia nel conformismo dottrinario dei padri fondatori, predicato dai loro profeti (oggi diventati ben remunerati professionisti).
Allora dico che è ora di svegliarsi. Siamo in epoca postgalileiana!








