Un milione di vite. Recensione
17 dicembre, 2017 - 11:59
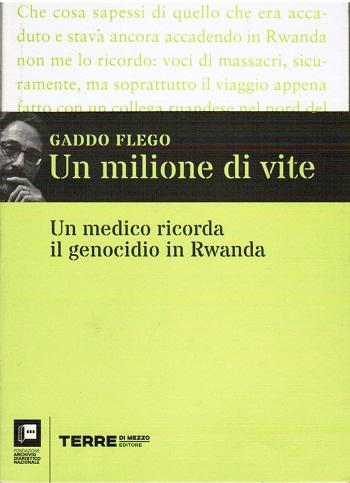
Editore: Terre di Mezzo
Anno: 2015
Pagine: 125
Costo: €12.00
In un recente intervento sulla rubrica che tengo su questa rivista, Pensieri sparsi[i], ho avuto modo di riflettere sulle posizioni che il medico può assumere durante la guerra, identificandone cinque principali. La quarta di esse è quella che definisco di neutralità attiva e attribuisco alle ONG presenti su molti teatri bellici e il diario del suo intervento durante i drammatici fatti ruandesi del 1994 scritto da Gaddo Flego ci offre un’occasione importante per approfondirne le caratteristiche, e anche gli aspetti problematici.
S’intitola infatti Un milione di vite. Un medico ricorda il genocidio in Rwanda il diario con il quale Gaddo Flego ha vinto il Premio letterario riservato ai diari “Pieve Saverio Tutino” del 2014, l’anno del ventennale del genocidio. Conosco Gaddo dai primi anni di università e mi legano a lui da allora un forte sentimento di amicizia e di stima e molte idee in comune, anche se la nostra frequentazione non è sempre stata regolare come avremmo voluto e ci sono stati periodi anche piuttosto lunghi nei quali ci siamo persi di vista; mai però dimenticati. Uno di questi è stato quello della sua lunga esperienza africana, che lo ha portato prima in Ciad e poi in Rwanda con Medici senza frontiere (MSF). Leggere questo libro, così, mi ha permesso di riempire una lacuna, conoscere uno di quei suoi periodi dei quali sapevo poco.
Dirò subito che il libro intanto è piacevole alla lettura, ha l’immediatezza del diario e riesce a trasmettere le passioni: la sensazione di fare una cosa importante, necessaria; la rabbia di trovarsi sul ciglio di un genocidio, di un’enorme ingiustizia cui si aggiunge l’ulteriore ingiustizia che il mondo fatichi a riconoscerne la dimensione, l’importanza e individuarne le responsabilità. Come nei migliori diari, in quello ruandese di Gaddo non trovano posto soltanto i fatti, ma ampio spazio è destinato alle emozioni che quei fatti riempiono di significato.
Gaddo arriva in Rwanda a trent’anni nel giugno 1994 dopo 5 anni trascorsi nel sud del Ciad come umanitario e un anno di master a Londra. In quel momento il massacro dei Tutsi da parte degli Hutu, le due etnie principali che popolano il Paese (la terza, non coinvolta, è quella dei Twa), è ancora in pieno svolgimento e contemporaneamente la formazione armata della minoranza Tutsi, il Fronte Patriottico Rwandese (FPR), è rientrato per difendere la propria etnia e sta guadagnando terreno. Gaddo, come ho detto, si muove sul ciglio del genocidio, non assiste in modo diretto al suo svolgimento ma trasmette la sensazione di essere vicinissimo all’epicentro. Probabilmente l’italiano che vi è più vicino. Si è mosso infatti in controtendenza: è andato in Rwanda mentre dal Rwanda tutti gli Occidentali venivano evacuati, segno che i governi sapevano che una catastrofe che si stava avvicinando e hanno lasciato il popolo ruandese in sua balia. Ma già, questa è solo una delle tante delle dimostrazioni di come in questo mondo postcoloniale che non cessa mai di essere indelebilmente coloniale il sangue degli esseri umani abbia diverso valore[ii].
Quello che ha appena avuto luogo non può essere ignorato se ci si trova a muoversi tra cumuli di terra sospetti dai quali emergono talvolta resti umani, che hanno tutta la parvenza di fosse comuni. O se ci si trova a intervenire con feriti che presentano i tagli netti del machete; particolarmente eloquente è quello con una mano amputata, verosimilmente nel tentativo di proteggersi il capo, e un taglio sul capo che proprio per il sacrificio dell’arto non è stato letale. O la donna dal capo reclinato, per un taglio netto che le ha reciso i tendini del collo. E ci sono certo questi danni direttamente legati alla guerra da curare; ma ci sono anche malattie intercorrenti, dissenteria, malaria, morbillo, meningite; ci sono i parti complicati nei quali è richiesto il suo soccorso. C’è il dramma dei bambini, quasi tutti morti i più piccoli, traumatizzati gli altri che, in un’occasione, tentano in un piccolo gruppo intorno ai sei anni il suicidio. Tutto precipita improvvisamente ancora di più quando, per le esigenze della guerra, si rende necessario un grande spostamento di popolazioni, nel quale i più deboli soccombono e muoiono come mosche davanti allo sguardo impotente del medico. E di nuovo i problemi sono, certo, l’intervento medico e chirurgico e le medicine, ma anche il cibo, l’acqua pulita e l’igiene degli spazi di cura, le coperte perché anche al centro dell’Africa la notte fa freddo, l’organizzazione delle latrine.
C’è uno psichiatra, e non ci fa una bella figura, impegnato a documentare il dolore che è nelle evidenze; mentre occorre invece, Gaddo commenta, in quel momento rimboccarsi le maniche per affrontarne le cause immediate. Gaddo documenta i locali sanitari che portano ancora chiari i segni dell’eccidio e della guerra in atto, e proprio accanto a essi i luoghi della vita che tenta, comunque, di ricominciare: «attraverso il terreno smosso e passo accanto ai resti umani, e mi chiedo se vivere lì sia segno di insensibilità, o al contrario di rispetto, o forse è soltanto la vita che deve andare avanti…» (p. 54). E di tutte queste cose riesce a dare un’impressione vivida e concreta.
Perché il diario registra anche la scansione della vita quotidiana degli umanitari impegnati in un’emergenza, le relazioni con l’organizzazione cui appartengono, quelle con le altre organizzazioni, con le autorità civili e militari e i medici e gli operatori sanitari del posto, quelle con gli operatori locali. Perché in quel luogo pieno di morti e di vivi feriti, traumatizzati che è Nyamata, schiaffeggiata, violentata continua comunque ad affermarsi la vita.
L’atteggiamento tipico di ogni ONG è di neutralità, certo, tra le formazioni combattenti, il che tra l’altro è necessario per garantire la sicurezza del proprio personale sul posto. Ma è anche un’attività di denuncia della guerra, i suoi danni e le sue cause, anche se queste due esigenze non sono sempre compatibili. Così, Gaddo ricorda le responsabilità remote del colonialismo nell’avere trasformato quella che era una storica e pacifica convivenza tra Hutu e Tutsi, due termini che si riferivano soprattutto al lavoro svolto, in contrapposizione; con l’avere trasformato queste definizioni in segni di appartenenza etnica, averne indagato presunte tracce nel corpo, averne imposto l’iscrizione sulla carta d’identità che fu poi strumento indispensabile ai genocidari per identificare le vittime designate[iii]. Abbiamo, insomma, noi europei “civilizzato” il Rwanda nel senso che lo abbiamo impregnato della nostra cultura razzista. La distinzione etnica imposta dal colono belga, poi, ha contribuito ad attribuire ai Tutsi una posizione preminente, il che ha spinto gli Hutu, maggioritari, a cercare di ribaltare la situazione dopo l’indipendenza. Dai primi anni ’90 si erano così osservati sporadici pogrom da parte degli Hutu e un’attività di guerriglia da parte dei Tutsi, che avevano in parte cercato rifugio nei Paesi vicini. Questa la situazione quando il 6 aprile 1994 la caduta dell’aereo sul quale viaggiava il presidente, un Hutu, ha scatenato l’inferno. La reazione degli estremisti Hutu, le milizie interahamwe, parrebbe con una certa connivenza di una parte almeno delle forze armate e della polizia, in gran parte appartenenti a quell’etnia, incoraggiati dalla radio del movimento, hanno scatenato una caccia all’uomo contro i Tutsi che non risparmiava né donne né bambini, allargandosi poi a quella parte degli Hutu che cercava di proteggere quei Tutsi che erano stati fino al giorno prima parenti, amici, vicini di casa. Il massacro avrebbe assunto la dimensione del genocidio, con un numero di morti stimato tra 500.000 e 1.000.000 in circa cento giorni, senza che nessuno operasse alcunché per fermarlo. E la denuncia di Gaddo investe la distrazione del mondo così detto civile rispetto a quanto stava accadendo e il fatto che la Francia, abbia continuato ad armare il governo Hutu fino alla vigilia del genocidio, e forse addirittura oltre, e si sia decisa a intervenire militarmente con un’operazione presentata come pacificatrice soltanto a genocidio avvenuto, quando la situazione si era ribaltata ed erano ora gli Hutu a essere messi a mal partito dall’avanzata dell’FPR.
Nell’articolo da cui sono partito a proposito del rapporto tra il medico e la guerra, accennavo anche alla difficoltà per chi è in posizione di neutralità attiva a mantenersi neutrale, a non schierarsi con una delle due parti sul campo soprattutto quando sembra evidente che sia essa ad avere ragione. Mi pare che, a questo riguardo, il diario di Gaddo ci consenta di passare da questo assunto teorico alla possibilità di verificare sul campo quali siano i meccanismi attraverso i quali questa difficoltà prende corpo. E mi pare di averne potuto individuare almeno tre:
S’intitola infatti Un milione di vite. Un medico ricorda il genocidio in Rwanda il diario con il quale Gaddo Flego ha vinto il Premio letterario riservato ai diari “Pieve Saverio Tutino” del 2014, l’anno del ventennale del genocidio. Conosco Gaddo dai primi anni di università e mi legano a lui da allora un forte sentimento di amicizia e di stima e molte idee in comune, anche se la nostra frequentazione non è sempre stata regolare come avremmo voluto e ci sono stati periodi anche piuttosto lunghi nei quali ci siamo persi di vista; mai però dimenticati. Uno di questi è stato quello della sua lunga esperienza africana, che lo ha portato prima in Ciad e poi in Rwanda con Medici senza frontiere (MSF). Leggere questo libro, così, mi ha permesso di riempire una lacuna, conoscere uno di quei suoi periodi dei quali sapevo poco.
Dirò subito che il libro intanto è piacevole alla lettura, ha l’immediatezza del diario e riesce a trasmettere le passioni: la sensazione di fare una cosa importante, necessaria; la rabbia di trovarsi sul ciglio di un genocidio, di un’enorme ingiustizia cui si aggiunge l’ulteriore ingiustizia che il mondo fatichi a riconoscerne la dimensione, l’importanza e individuarne le responsabilità. Come nei migliori diari, in quello ruandese di Gaddo non trovano posto soltanto i fatti, ma ampio spazio è destinato alle emozioni che quei fatti riempiono di significato.
Gaddo arriva in Rwanda a trent’anni nel giugno 1994 dopo 5 anni trascorsi nel sud del Ciad come umanitario e un anno di master a Londra. In quel momento il massacro dei Tutsi da parte degli Hutu, le due etnie principali che popolano il Paese (la terza, non coinvolta, è quella dei Twa), è ancora in pieno svolgimento e contemporaneamente la formazione armata della minoranza Tutsi, il Fronte Patriottico Rwandese (FPR), è rientrato per difendere la propria etnia e sta guadagnando terreno. Gaddo, come ho detto, si muove sul ciglio del genocidio, non assiste in modo diretto al suo svolgimento ma trasmette la sensazione di essere vicinissimo all’epicentro. Probabilmente l’italiano che vi è più vicino. Si è mosso infatti in controtendenza: è andato in Rwanda mentre dal Rwanda tutti gli Occidentali venivano evacuati, segno che i governi sapevano che una catastrofe che si stava avvicinando e hanno lasciato il popolo ruandese in sua balia. Ma già, questa è solo una delle tante delle dimostrazioni di come in questo mondo postcoloniale che non cessa mai di essere indelebilmente coloniale il sangue degli esseri umani abbia diverso valore[ii].
Quello che ha appena avuto luogo non può essere ignorato se ci si trova a muoversi tra cumuli di terra sospetti dai quali emergono talvolta resti umani, che hanno tutta la parvenza di fosse comuni. O se ci si trova a intervenire con feriti che presentano i tagli netti del machete; particolarmente eloquente è quello con una mano amputata, verosimilmente nel tentativo di proteggersi il capo, e un taglio sul capo che proprio per il sacrificio dell’arto non è stato letale. O la donna dal capo reclinato, per un taglio netto che le ha reciso i tendini del collo. E ci sono certo questi danni direttamente legati alla guerra da curare; ma ci sono anche malattie intercorrenti, dissenteria, malaria, morbillo, meningite; ci sono i parti complicati nei quali è richiesto il suo soccorso. C’è il dramma dei bambini, quasi tutti morti i più piccoli, traumatizzati gli altri che, in un’occasione, tentano in un piccolo gruppo intorno ai sei anni il suicidio. Tutto precipita improvvisamente ancora di più quando, per le esigenze della guerra, si rende necessario un grande spostamento di popolazioni, nel quale i più deboli soccombono e muoiono come mosche davanti allo sguardo impotente del medico. E di nuovo i problemi sono, certo, l’intervento medico e chirurgico e le medicine, ma anche il cibo, l’acqua pulita e l’igiene degli spazi di cura, le coperte perché anche al centro dell’Africa la notte fa freddo, l’organizzazione delle latrine.
C’è uno psichiatra, e non ci fa una bella figura, impegnato a documentare il dolore che è nelle evidenze; mentre occorre invece, Gaddo commenta, in quel momento rimboccarsi le maniche per affrontarne le cause immediate. Gaddo documenta i locali sanitari che portano ancora chiari i segni dell’eccidio e della guerra in atto, e proprio accanto a essi i luoghi della vita che tenta, comunque, di ricominciare: «attraverso il terreno smosso e passo accanto ai resti umani, e mi chiedo se vivere lì sia segno di insensibilità, o al contrario di rispetto, o forse è soltanto la vita che deve andare avanti…» (p. 54). E di tutte queste cose riesce a dare un’impressione vivida e concreta.
Perché il diario registra anche la scansione della vita quotidiana degli umanitari impegnati in un’emergenza, le relazioni con l’organizzazione cui appartengono, quelle con le altre organizzazioni, con le autorità civili e militari e i medici e gli operatori sanitari del posto, quelle con gli operatori locali. Perché in quel luogo pieno di morti e di vivi feriti, traumatizzati che è Nyamata, schiaffeggiata, violentata continua comunque ad affermarsi la vita.
L’atteggiamento tipico di ogni ONG è di neutralità, certo, tra le formazioni combattenti, il che tra l’altro è necessario per garantire la sicurezza del proprio personale sul posto. Ma è anche un’attività di denuncia della guerra, i suoi danni e le sue cause, anche se queste due esigenze non sono sempre compatibili. Così, Gaddo ricorda le responsabilità remote del colonialismo nell’avere trasformato quella che era una storica e pacifica convivenza tra Hutu e Tutsi, due termini che si riferivano soprattutto al lavoro svolto, in contrapposizione; con l’avere trasformato queste definizioni in segni di appartenenza etnica, averne indagato presunte tracce nel corpo, averne imposto l’iscrizione sulla carta d’identità che fu poi strumento indispensabile ai genocidari per identificare le vittime designate[iii]. Abbiamo, insomma, noi europei “civilizzato” il Rwanda nel senso che lo abbiamo impregnato della nostra cultura razzista. La distinzione etnica imposta dal colono belga, poi, ha contribuito ad attribuire ai Tutsi una posizione preminente, il che ha spinto gli Hutu, maggioritari, a cercare di ribaltare la situazione dopo l’indipendenza. Dai primi anni ’90 si erano così osservati sporadici pogrom da parte degli Hutu e un’attività di guerriglia da parte dei Tutsi, che avevano in parte cercato rifugio nei Paesi vicini. Questa la situazione quando il 6 aprile 1994 la caduta dell’aereo sul quale viaggiava il presidente, un Hutu, ha scatenato l’inferno. La reazione degli estremisti Hutu, le milizie interahamwe, parrebbe con una certa connivenza di una parte almeno delle forze armate e della polizia, in gran parte appartenenti a quell’etnia, incoraggiati dalla radio del movimento, hanno scatenato una caccia all’uomo contro i Tutsi che non risparmiava né donne né bambini, allargandosi poi a quella parte degli Hutu che cercava di proteggere quei Tutsi che erano stati fino al giorno prima parenti, amici, vicini di casa. Il massacro avrebbe assunto la dimensione del genocidio, con un numero di morti stimato tra 500.000 e 1.000.000 in circa cento giorni, senza che nessuno operasse alcunché per fermarlo. E la denuncia di Gaddo investe la distrazione del mondo così detto civile rispetto a quanto stava accadendo e il fatto che la Francia, abbia continuato ad armare il governo Hutu fino alla vigilia del genocidio, e forse addirittura oltre, e si sia decisa a intervenire militarmente con un’operazione presentata come pacificatrice soltanto a genocidio avvenuto, quando la situazione si era ribaltata ed erano ora gli Hutu a essere messi a mal partito dall’avanzata dell’FPR.
Nell’articolo da cui sono partito a proposito del rapporto tra il medico e la guerra, accennavo anche alla difficoltà per chi è in posizione di neutralità attiva a mantenersi neutrale, a non schierarsi con una delle due parti sul campo soprattutto quando sembra evidente che sia essa ad avere ragione. Mi pare che, a questo riguardo, il diario di Gaddo ci consenta di passare da questo assunto teorico alla possibilità di verificare sul campo quali siano i meccanismi attraverso i quali questa difficoltà prende corpo. E mi pare di averne potuto individuare almeno tre:
- Il primo, è che per tutta la durata della loro permanenza Gaddo e i suoi colleghi si muovono tra i cadaveri dei Tutsi e si trovano a testimoniare e curare le loro ferite e i loro traumi: le ragioni dei Tutsi, dunque, prendono letteralmente corpo per loro in modo ben diverso da quelle, che pure ci saranno state sebbene in misura quantitativamente inferiore, di parte Hutu;
- per muoversi e operare in quella zona Gaddo e i suoi collaboratori hanno comunque necessità che l’FPR metta a disposizione un contatto logistico e una scorta armata - se ho ben capito per lo più femminile e priva di divisa, ma pur sempre appartenente all’FPR - e con queste persone si finisce inevitabilmente per convivere quotidianamente, si stabiliscono in ogni caso rapporti, a volte rapporti profondi, di comprensione e condivisione di emozioni che non è possibile che trascorrano senza lasciar traccia;
- direttamente presenti in quella situazione, testimoni di quelle scene di morti e feriti, è difficile per gli operatori umanitari non farsi un’idea, o almeno non avvertire emotivamente un’impressione, di chi stia combattendo dalla parte della ragione e chi del torto; e, il punto che pare più delicato, se ci si stia trovando in quel caso in presenza di una guerra civile caratterizzata da un coinvolgimento particolarmente importante dei civili (ma quale guerra civile degli ultimi anni non ha pesantemente coinvolto i civili?), o del genocidio pianificato dei Tutsi da parte degli Hutu.
Mi pare che queste ragioni siano più che sufficienti a far sì che la questione della neutralità rappresenti un punto di costante tensione emotiva per l’operatore umanitario e di fisiologica frizione tra chi, di una ONG, sta più direttamente sul campo o più nelle retrovie a svolgere un - altrettanto indispensabile e prezioso - lavoro di logistica. E così, sono parecchie le pagine del diario nelle quali si avverte che a Gaddo la neutralità che MSF si/gli impone sta veramente stretta, lo si sente in polemica con altre organizzazioni ancora più scrupolose nell’applicazione di quel principio soprattutto e, in qualche misura, anche con la propria. Non si può, insomma, fare finta in nome della neutralità che genocidio non sia stato se è stato, e a commetterlo è stata una delle due parti in conflitto; né si può ignorare il fatto che, pur coi limiti di ogni organizzazione armata, nell’inerzia generale l’FPR sia stato il solo soggetto a combattere il genocidio fino a riuscire a porvi fine. Al punto che, nelle pagine finali, Gaddo scherzando su se stesso confessa la fantasia di lasciare il Rwanda indossando la T-Shirt dell’FPR (p. 99). Fantasie, emozioni che qui tali rimangono, ma ci consentono di comprendere quanto possa essere delicato il crinale tra chi opera in posizione di neutralità attiva, e chi avverte la necessità di prendere parte, trasformandosi così - secondo la partizione che ho proposto - nel medico rivoluzionario.
Ma il problema, in quel frangente, non ha riguardato solo lui. Nella stessa organizzazione di MSF ha avuto luogo un serrato dibattito interno su quei fatti, del quale l’organizzazione ha scelto di rendere conto con un dossier pubblicato anch’esso in occasione del ventennale[iv].
E, ancora, il diario documenta le emozioni dell’uscita da quel vortice intenso, uno dei momenti più difficili per l’umanitario, il ritorno al mondo normale quando: «verso l’uscita dalla città superiamo Sylvie che cammina sul bordo della strada, ci saluta con la mano e con un bellissimo sorriso al quale io rispondo, e forse vorrei saltare giù dall’auto e dire “io resto”, invece la vedo scomparire lontano, nella polvere, e sento morire un pezzo della mia anima e staccarsi un brandello di cuore (…) e già sento tutta la nostalgia del mondo spaccarmi in due e l’innocenza perduta per sempre e la certezza che la morte d’ora in avanti mi abiterà senza scampo» (pp. 97-98). Il trauma di un ritorno alla “normalità” che credo senz’altro non sia stato facile. E che ha portato Gaddo, mi pare, ancora vent’anni dopo a cercare di saldare una parte del debito umano che avverte per quelle persone con le quali, e per le quali, ha lavorato in quel breve periodo ruandese attraverso la pubblicazione di questa testimonianza e la collaborazione con Emilio Di Maria all’organizzazione del convegno “Noi e altri. Identità e differenze al confine tra scienze diverse” nel 2014[v]. Quando i vent’anni dai fatti gli sono parsi, evidentemente, la distanza giusta perché quelle emozioni non si fossero ancora spente del tutto, ma non fossero più tanto incandescenti da non poterle maneggiare.
Oggi Gaddo è direttore sanitario della ASL di uno degli ospedali genovesi, l’Ospedale Evangelico di Voltri, è stato tra i fondatori dell’Ambulatorio Internazionale Città Aperta di Genova e partecipa alle attività del Gruppo Regionale Immigrazione e Salute della Liguria; quanto ai suoi collaboratori più stretti, Peter è uscito da MSF per poi rientrarvi; Nadine - che era originariamente una delle scorte messe a disposizione dall’FPR - ora fa la psicologa in Belgio; alla storia di una bambina sopravvissuta al massacro della chiesa di Nyamata, soccorsa dalla CRI di Maria Pia Fanfani mentre Gaddo era nei pressi, il programma Radici di RAI 3 ha dedicato una puntata.
Chiudono il libro quattro testimonianze di vittime tutsi: la psicoterapeuta Esther Majawayo, autrice del romanzo Il fiore di Stephanie (e/o, 2007); il regista Gilbert Ndahayo; Jean Paul Habimana, che come Gaddo è intervenuto a proposito della vicenda ruandese anche al convegno genovese cui accennavo; George Gatera, la cui storia attraverso il genocidio è stata pubblicata su Primapersona, periodioco dell'Archivio Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano.
E credo, così, che chi voglia capire qualcosa in più di questa catastrofe umanitaria di enormi dimensioni, del basso valore che alla vita umana può essere attribuito in certe situazioni e del fatto che per ammazzare in serie non siano indispensabili treni e camere a gas ma possa essere sufficiente il machete, possa trovare una testimonianza utile in questo diario. E credo che possa anche trovarcela chi vuole avvicinarsi a comprendere il lavoro umanitario, le difficoltà, i dubbi, le sensazioni di disperazione e quelli di trionfo, le emozioni in ogni caso forti, le difficoltà a uscirne per ritornare alla vita normale di una relativamente tranquilla e ricca città del nord del mondo.
Mi pare allora di dover ringraziare Gaddo, e le persone che hanno lavorato con lui, per quello che hanno fatto in Rwunda in quell’estate 1994, e anche per averci dato la possibilità di conoscerlo e rifletterci attraverso questo diario.
[i] P. F. Peloso, GUEVARA, MORSELLI: IL MEDICO E LA GUERRA, Pol. it, 25 novembre 2017 (clicca qui per il link).
[ii] P. F. Peloso, IL VALORE DEL SANGUE. UN PENSIERO ALLE STRAGI TERRORISTE DEL 12 E 13 NOVEMBRE, Pol. it, 15 novembre 2015 (clicca qui per il link).
[iii] L’introduzione dell’appartenenza etnica sulla carta d’identità avrebbe così giocato, nel momento in cui è partito il genocidio, un ruolo facilitatore analogo, se ho ben compreso, a quello che l’iscrizione dell’appartenenza etnica sui documenti imposta dalle Leggi fasciste per la difesa della razza del 1938 giocarono quando, con l’occupazione tedesca del 1943, la caccia all’ebreo investì anche l’Italia.
[iv] Tra i dubbi principali che agitavano l’organizzazione, che ricaviamo dal suo sito, c’erano questi: “era accettabile che Médecins Sans Frontières, come organizzazione umanitaria, rimanesse in silenzio di fronte a un genocidio o al contrario richieda un intervento armato, cioè un’azione che comporterebbe la morte di esseri umani? Ci si doveva augurare che Médecins Sans Frontières chiedesse agli Stati altri tipi d’intervento, col rischio di giustificare una risposta da parte loro totalmente inefficace, rispetto alla natura stessa del genocidio? Lanciato nel momento in cui la Francia si proponeva d’intervenire in Rwanda, l’appello di Médecins Sans Frontières non rischiava di essere strumentalizzato politicamente?”. Queste domande e altre notizie sono facilmente rinvenibili digitando Médecins Sans Frontières, Dossier Rwanda. 20 ans après dove è anche disponibile il ricco PDF “Médecins sens frontières. Prises de parole puubliques, Génocide des Rwandais Tutsis 1994”.
[v] Del convegno sono disponibili gli Atti pubblicati a cura di Emilio Di Maria (De Ferrari, 2017) che saranno presentati a Genova, al Circolo ARCI “Zenzero”, Martedì 19 dicembre 2017 .








