PENSIERI SPARSI
Tra psichiatria, impegno civile e suggestioni culturali
VARCARE I CONFINI. Spunti antiistituzionali dalla storia dei manicomi genovesi Parte I – Ubicazione, dimensioni, alternative
4 ottobre, 2019 - 23:30
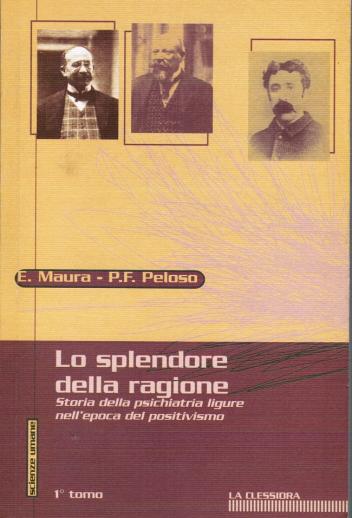
Parte I – Ubicazione, dimensioni, alternative
Nel leggere la storia del secolo e mezzo di vita del manicomio in Italia e la sua conclusione negli anni ’60-’70 viene spontanea una domanda: ma possibile che se il manicomio costituiva una cosa così contraria al sentimento di umanità e così antiterapeutico, questo non fosse venuto in mente prima di quel decennio alle migliaia di psichiatri e amministratori pubblici che se n’erano occupati?
Una prima risposta ce la dà il gruppo diretto da Franco Basaglia quado, nel porsi nel 1967 la domanda cruciale Che cos’è la psichiatria?, individua – sia pure cogliendone soprattutto nel secondo caso anche i limiti, due illustri predecessori nell’inglese John Conolly e nel francese Evariste Marandon de Montyel[i]. Ma in Italia - ora che negli ultimi anni, pur mantenendo un carattere di nicchia e di asistematicità, gli studi delle varie istituzioni psichiatriche stanno facendo indubbi progressi - non è proprio possibile cogliere voci che, tra gli amministratori e gli psichiatri, si sono levate negli anni contro gli aspetti più deleteri del manicomio (l’isolamento, la serialità, le condizioni spesso indecenti di sovraffollamento e di degrado, l’uso spregiudicato della contenzione fisica) e hanno tentato di varcare i confini?
E così, il modo migliore di celebrare i vent’anni dalla pubblicazione, a quattro mani con Emilio Maura, del volume Lo splendore della ragione. La psichiatria ligure nell’epoca del positivismo (Genova, La clessidra, 1999), mi è parso quello di cercare all’interno di quel corposo volume in due tomi, arricchito da un’abbondante riproduzione delle fonti, risposta a questo quesito per quel che riguarda il caso genovese, certo uno soltanto tra molti altri possibili.
E l’occasione mi è stata data dal cortese invito di Vanessa Federico - organizzatrice in collaborazione con Mattia Mariani, come lei dell’Associazione “Cara Milena”, Andrea Trafeli dell’Associazione “Inclusione Graffio e Parola” e con Fondazione CR Volterra - a partecipare a Volterra il 28 e 29 settembre al convegno Storie italiane di psichiatria. Primo memoriale Fernando Nannetti, al quale ho preso parte con la relazione: Spunti antiistituzionali nella psichiatria genovese dell’800.
Con essa, ho inteso richiamare alcuni dei non pochi riferimenti alla possibilità che si procedesse in senso contrario all’istituzionalizzazione su alcune questioni che presentano peraltro, mutatis mutandis, ancora un profilo di attualità nel dibattito psichiatrico attuale. Riferimenti che credo sarebbe interessante cercare anche nella storia di altre realtà italiane, e questo vuole essere anche uno stimolo in tal senso; e penso ad esempio, in omaggio al luogo che ci ha ospitati, al dibettito nella Provincia di Pisa, ricostruito da Vinzia Fiorino[ii], sulla costruzione del manicomio a Volterra, 70 chilometri dal capoluogo.
Una nota mi pare indispensabile: i manicomi ai quali faremo qui riferimento sono cinque: quello di via Galata, a brevissima distanza dal centro città, che ha funzionato dal 1841 al 1912, quando è stato demolito; quello di Quarto, fondato nel 1894 a una distanza maggiore ma non drammatica dalla città, raddoppiato nel 1932 e ancora visitabile; quello di Prato Zanino presso Cogoleto, pensato come manicomio-città, sorto a notevole distanza per i mezzi di allora dalla città, e destinato a superare negli anni ’70 del ‘900 i 2.000 internati; quello di Paverano, in città e di piccole dimensioni, che ospitò per qualche decennio la clinica universitaria e un reparto femminile, poi anche uno maschile; la succursale di La Spezia, aperta per contribuire ad affrontare il sovraffollamento e chiusa, dopo qualche anno, con l’apertura di Prato Zanino.
La prima questione è quella della distanza dalla città, dalla famiglia e dalla casa della maggior parte dei ricoverati. è un tema che emerge all’attenzione negli anni ’80 dell’800, quando il sovraffollamento nel primo manicomio, quello di via Galata, e nelle succursali che via via si erano aggiunte in giro per la città si era fatto insostenibile, e l’ipotesi dell’Amministrazione provinciale era quella di aprire un grande manicomio a Prato Zanino, nell’entroterra di Cogoleto, lontano dalla città. Di tutt’altro parere il direttore del manicomio e titolare dell’insegnamento universitario, Dario Maragliano, il quale puntava alla costruzione di vari manicomi piccoli, collocati in modo tale che tutti i malati della provincia potessero averne uno vicino a casa propria, alla propria famiglia e nel contesto di vita. Per sostenere le sue tesi, Maragliano fece pubblicare un supplemento de Il secolo XIX, già allora il primo quotidiano della città, dove espose il proprio parere e chiese di esprimersi su di esso a una cinquantina di direttori di altri manicomi italiani. E tra gli argomenti che affronta c’è appunto quello della distanza, in termini che dovremmo tenere anche oggi presenti quando inseriamo uno dei nostri pazienti in una struttura residenziale. Scrive infatti Maragliano: «Importantissima a considerarsi è quella dei rapporti fra i malati e le loro famiglie, rapporti, che sono ritenuti indispensabili dai più illustri alienisti, e che perciò è d'uopo facilitare quanto più è possibile. Perocché se bene spesso nei primordi del ricovero le visite dei parenti sotto inopportune o dannose pel malato, più tardi esse sono invece utilissime per ridestare e mantenere i sopiti sentimenti affettivi per la famiglia, per scacciare gli ultimi resti di un delirio depressivo specialmente quando ha per contenuto l'idea delirante (l'essere abbandonati dalla famiglia o che questa sia morta), per confortare il malato alla speranza di una prossima sortita, per rendere meno penoso il soggiorno del manicomio in quelli che hanno poca speranza di sortirne. Non di rado la vista dei parenti è valsa a togliere il malinconico da uno stato di mutismo e di stupore o a decidere a mangiare un malato che era da tempo d'uopo alimentare artificialmente». E ancora: «Né va trascurata la soddisfazione pel ricoverato povero che certo non riceve laute somministrazioni dell'Istituto, di poter ricevere la domenica e altri giorni di festa qualche ghiottoneria dalla famiglia, di comunicarle qualche desiderio o qualche bisogno che essa può soddisfare, di potere avere da essa qualche oggetto di abbigliamento o di indumento non largito dall'Istituto (…). Perocchè, dopo tutto, il manicomio non è una caserma da essere militarmente regolata e dove il ricoverato deve per corredo e per rancio uniformarsi alle prescrizioni soldatesche». Ma non è solo la necessità di mantenere i legami della persona con la famiglia a suggerire per una collocazione del manicomio in area urbana: «Perocché, oltre alle ordinarie distrazioni che possono attuarsi anche in un manicomio isolato, quali i trattenimenti musicali, le rappresentazioni teatrali, le festicciuole da ballo, giovano spesso in certi periodi della malattia o per certe categorie di malati le distrazioni che la città può offrire ne' suoi pubblici ritrovi, o in qualche straordinaria occasione. Spesso è questo anzi un mezzo per abituare un’altra volta il convalescente ai contatti sociali. Il grande Esquirol come mezzo di cura morale e di ricompensa faceva passare i suoi malati da Ivry a Parigi e spesso il compianto Prof. Verdona, suo allievo, prima di dimettere un malato usava mandarlo a passeggiare per le vie della città onde abituarlo un'altra volta alla vista delle persone, al rumore della vita. . Il manicomio di Reggio [Emilia], prossimo alla città, usa inviare molti de' suoi malati al gran Teatro Municipale quando è aperto, ed anche a Genova da parecchi anni un palco del Politeama Margherita è nella stagione di Carnevale preso in affitto dal manicomio che v'invia per turno i suoi pensionanti insieme a qualche povero».
E tra i commenti raccolti da Maragliano, mi pare particolarmente interessante su questo punto quello di Clodomiro Bonfigli, direttore a Ferrara: «Ciò che io allora diceva per Mombello devo ripeterlo oggi per Genova, la cui provincia ha una forma che in nessun modo si presta per l'istruzione di un Manicomio Centrale. Riguardo alle altre ragioni che Ella espone contro l'idea di un Manicomio unico, ed eccentrico per certe parti della provincia, talune di esse sono di tale gravità, che un Consiglio Provinciale non potrebbe porle in non cale senza meritarsi la taccia di curare assai poco il proletario, per il quale, disgraziatamente, più che per i ricchi, sono aperte le porte del Manicomio. Quindi è che su questo punto neppure, credo vi sia bisogno che la mia voce, qualunque essa sia, si aggiunga alla sua per stigmatizzare quella specie di relegazione a cui si vorrebbero condannare i pazzi poveri di gran parte della provincia di Genova»
Né la polemica risparmiava l’altro quotidiano genovese – mi pare importante notare anche il coinvolgimento della città nel problema - il quotidiano Il Caffaro, dove una lettera anonima sosteneva: «Lo stabilimento lassù, a grande distanza da Genova, obbligherebbe i parenti e gli amici dei ricoverati a una lunga e dispendiosa gita, mentre molti degli ammalati stessi ricevono visite e sussidi di viveri e indumenti. Nessuno può del pari ignorare che numerosi malati devono (oltre le amorevoli cure di quell'egregio sanitario che è il Dr. Maragliano, direttore del nostro Manicomio e del degnissimo vice direttore Dr. De Paoli) grande sollievo alle frequenti visite e alle conversazioni dei loro cari che ne possono rialzare il morale e contribuire in modo serio e positivo alla guarigione».
E così, la posizione di Maragliano raggiungeva anche il Consiglio provinciale, dove il consigliere Elia la riproponeva in questi termini: «In Genova - egli dice - i parenti degli alienati sono spesso chiamati da ragioni politiche amministrative e da mille bisogni della vita, possono quindi profittare di queste occasioni per visitare i loro cari, per richiamarli al consorzio, agli affetti della famiglia, alla realtà della vita, possono soccorrerli con piccoli doni, con qualche offerta, possono averli (quando tranquilli) ore e giorni in prova, e possono così contribuire al loro miglioramento. A Prato Zanino - continua l'oratore - chi potrà andar dagli infelici parenti? Pochi o nessuno». Ed è una sensibilità, questa al disagio di malati e familiari per la distanza del manicomio da casa, che ritorna nel 1912 in una lettera di Cesare Mannini, direttore della succursale di La spezia, nel momento in cui se ne prospettava la chiusura e il trasferimento dei malati a circa 100 chilometri di distanza nei manicomi genovesi: «Bisognerebbe aver assistito alle lamentele dei parenti dei ricoverati, alla notizia del trasferimento di questi altrove ed in luogo lontano, per convincerne quanto insieme di benevolenza, quanto affetto circonda spesso questi poveri disgraziati mentecatti! La maggior parte delle famiglie vive con i congiunti alienati la vita affettiva ed ama averli vicino: il culto degli affetti familiari verso i colpiti dalla malattia è indice di progredita civilizzazione (…). Che cosa dire infine del dolore sofferto da alcuni e non pochi alienati all’atto del trasferimento dal loro paese di nascita o di domicilio? Non in tutti i mentecatti è spenta la vita affettiva, gli affetti di simpatia all’ambiente ed alle persone di famiglia sono di quelli che più a lungo permangono anche nelle menti di coloro che furono colpiti dalla pazzia».
Parrà davvero strano, ma ancora oggi quando capita di dover sostenere che soprattutto i pazienti più gravi quando hanno necessità di un inserimento nella residenzialità dovrebbero trovarlo a breve distanza dal servizio, perché restino comunque in contatto con esso, non tutti sono convinti di questo e capita ancora di imbattersi in chi sostiene che è meglio non fissarsi sui principi, non fare dell’”ideologia”, essere flessibili e accomodanti… lontano dagli occhi lontano dal cuore, insomma, oggi come allora, soprattutto chi al cuore può dare qualche sobbalzo, e può rischiare di rendere un po’ meno semplicistica, tranquilli, lineare e comodi il nostro lavoro e la nostra idea della vita!
Altro tema sul quale Maragliano insiste è quello della dimensione ottimale per un manicomio, in riferimento al quale scrive: «Se v'ha principio saldo e quasi indiscusso nella nostra specialità è quello che i Manicomi non devono essere di troppo grande dimensione, senza di che l'ordine, la quiete restano compromessi e l’individualità del malato, che è caratteristica tendenza dell'odierna psichiatria di voler rispettata, resta perduta, confusa nella massa con danno nella sua cura, nella sua assistenza. Questo dogma, riconosciuto dai grandi maestri forestieri, ha avuto in Italia a volgarizzatori Gerolami, Zurli, Cardona e fra i viventi il Verga, il Biffi, il Roncati. Venne anzi fissata una cifra e questa, a seconda dei vari autori, oscillò fra i 300 e i 600 malati».
E lo conforta in questa posizione il collega Angelucci, direttore in quel di Mantova, per il quale: «Io molte volte mi sono domandato; ma come potrà un Direttore conoscere intimamente mille pazzi, e dirigere la cura secondo le varie attitudini e abitudini? Perché il Manicomio, come tu dici benissimo, non è niente affatto un carcere od un ricovero qualunque, dove il Direttore ha solamente l'obbligo dell'indirizzo e della sorveglianza, il Manicomio è un Istituto speciale, dove occorre che il Direttore si trovi a contatto co' suoi ricoverati e di loro si occupi individualmente. Spesso ho veduto che molti malati provavano una soddisfazione viva nell'esser ricordati, mentre se qualcuno viene dimenticato s'offende. Del resto, ciò è molto umano, perché nel piccolo mondo in cui viviamo, si sentono affetti e passioni come nel grande mondo».
E non solo questi argomenti di Maragliano riusciranno a bloccare in quel 1888 e per ventiquattro anni il progetto di costruzione di un grande manicomio a Prato Zanino, ma vengono anche ripresi con citazioni dirette allorché, nove anni dopo, in alternativa a quell’ipotesi si considera quella di raddoppiare le dimensioni del manicomio di Quarto, che avrebbero così anch’esse superato il migliaio di letti (anche questo progetto, bloccato in quella fase, sarebbe poi stato realizzato nel 1932). E così, le parole di Maragliano in difesa dei propri pazienti riecheggiano in Consiglio provinciale il 20 dicembre 1897 in quelle del consigliere Celso Motta: «Considerando anche la questione dal lato scientifico, è facile vedere che se un grande manicomio-città può servir benissimo a sbarazzare la società di tanti disgraziati, non riesce certo di vantaggio a questi ultimi, e si capisce facilmente il perché. Più si fa grande il numero dei malati, e più va perdendosi l'individualità di ciascuno, confondendosi nella massa con danno della sua cura e sorveglianza (…). Peisdesdorf, il celebre clinico di Vienna, dice che «prima legge nell'andamento di un buon manicomio deve essere l'osservazione e la cura INDIVIDUALE dei malati», e che pertanto esso non deve essere troppo grande: niun direttore può accordare la propria attenzione a più di 500 o 600 ammalati (…). Il Tucker, alienista australiano, che visitò più di 400 manicomi e di molti altri assunse per corrispondenza informazioni, veniva alla conclusione che (…) i migliori manicomi sono quelli che ne contengono solamente 300». O in quelle del consigliere Piaggio: «Nei piccoli Manicomi il malato è meglio conosciuto, osservato dall'alienista; nei grandi resta un numero di matricola, e viene reggimentato e inviato nella sezione piena zeppa di altri pazzi che lo contagiano moralmente e che finiscono coll'impedirgli di guarire. E poi nei piccoli Manicomi la cura si può fare individualmente: nei grandi no, ché l'individuo non è più distinguibile dalla massa. I Manicomi grandi - oltre a 800 malati - costituiranno la vergogna del XIX e forse anche del XX secolo. Essi non sono più nè ospedali, né ospizi, né luoghi di cura, né luoghi di studio: sono caserme, alveari dove tutte le individualità morbose si amalgamano in un intreccio di pazzia e di contagio di pazzia. E quando i nostri posteri domanderanno i perché furono costruiti, e si sentiranno rispondere dai vecchi resoconti dei nostri Consigli Provinciali che lo furono per economia, allora forse arrossiranno per noi e ci compatiranno come poco previdenti».
Ubicazioni e dimensioni del manicomio, dunque, agitano il dibattito già in quegli anni, e non manca chi si è accorto che il rapporto con la famiglia, con la casa, l’individualizzazione della cura sono strumenti che vanno contro l’istituzionalizzazione, cioè l’assoggettamento totalizzante della persona e la sua serializzazione da parte dell’istituzione, e favoriscono processi di guarigione. Così, sul manicomio sembra pesare costantemente l’alternativa costituita dal modello di Geel, il villaggio belga dove, per motivi inizialmente devozionali, attraverso i secoli comuni cittadini si sono specializzati nella cura degli alienati presso le proprie famiglie[iii]. Insomma, in alternativa alla costruzione di nuovi e più grandi manicomi, che sarà poi sempre la soluzione adottata nella storia genovese come nella maggioranza delle altre, non è proprio possibile mettere a pensione i malati presso famiglie, evitando così loro, tra l’altro, i danni dell’istituzionalizzazione.
E fa riferimento, sia pure in senso negativo (ma comunque Geel è nominata, a quell’ipotesi alternativa e antiistituzionale bisogna pensare, sia pure per scartarla), una delle tre lettere anonime sull’argomento dei manicomi che l’avvocato Stefano Castagnola riceve nel 1878, dieci anni prima dunque della polemica che ha visto protagonista Maragliano, quando già si poneva il problema dell’affollamento: «La prima volta si pensò di provvedere all'agglomeramento, collocando dei mentecatti cronici ed innocui in campagna presso famiglie di onesti ed agiati contadini. Non si pensò che questo rimedio non era attuabile che per un numero scarso di mentecatti - quello dei convalescenti - e non mai come norma generale; ma giova ancora osservare che, anche per i convalescenti, tale sistema non ha dato risultati soddisfacenti fuori di Geel dove speciali circostanze da epoche, direi, quasi immemorabili ne favorirono gradatamente l'attuazione». L’anno successivo, è la commissione d’inchiesta sul manicomio nominata dalla Provincia e formata da Serafino Biffi, Gaetano Pini e Augusto Tamburini a prendere di nuovo in considerazione l’ipotesi per ribadirne l’impraticabilità: «Riguardo poi al collocamento de' malati in pensione presso le famiglie non è attuabile che per un numero scarso, quello dei convalescenti ,0 e non mai come norma generale, ma regolandosi sempre secondo i casi speciali: fuori di questi casi tale sistema non ha dato risultati soddisfacenti, fuori di Geel dove speciali circostanze da molti secoli ne favorirono gradatamente l'attuazione». E ancora vent’anni dopo, nell’esporre le proprie conclusioni sulla questione manicomiale, è il relatore G.B. Segale ad affossare alla seduta del Consiglio provinciale del 25 novembre 1897 definitivamente l’ipotesi: «Il sistema della cura in case private presso famiglie che se ne prendono volontariamente l'incarico si è alquanto diffuso negli ultimi anni nel Belgio, nella Scozia, nell’Inghilterra, nella Germania e, nel Nord-America limitatamente al Massachussets. In alcuni di tali paesi gli alienati assistiti in questo modo costituiscono delle colonie libere, in altri sono alla dipendenza e sotto la sorveglianza dei manicomi. Pregi del sistema sono: evitare l'agglomeramento degli alienati in genere; evitare il contatto troppo comune e dannoso dei ricoverati coscienti e depressi cogli altri alienati; sbarazzare il manicomio di un certo numero di alienati inoffensivo ed incurabili; evitare le spese di costruzione di nuovi asili e di diminuire le spese del ricovero. Difetti dello stesso sistema sono: non essere applicabile che a un numero ristretto di alienati; esigere molto tempo per abituare le famiglie e il pubblico ad avere cura di tali malati e tollerarne il contatto; richiedere per essere attuato condizioni speciali economiche locali e d'indole adatta nei custodi. In complesso i difetti sono superiori ai pregi, tantoché anche nei Paesi dove venne adottato il sistema dell'assistenza in famiglia, questo è usato in proporzioni assai minori del ricovero nel manicomio; in una regione inoltre, il Massachussets, non ha, dato buoni risultati. E’ pure degno di nota che il suddetto metodo non è usato in Italia (salvo eccezioni individuali) e nemmeno in altri paesi di origine latina o greca, evidentemente perché l'indole vivace degli abitanti e per conseguenza degli alienati non vi si presta».
Miopia, mancanza di originalità e di coraggio, pregiudizi e stigma? Probabilmente sì; in ogni caso l’ombra di Geel, con un riferimento alla psichiatria ambulatoriale che pare già in direzione dei CIM, riaffiora di nuovo quando il consigliere Piaggio, nei verbali della Commissione d’inchiesta su Quarto del 1910-11, afferma: «Per parte mia ricordo di aver consigliato, fin dal 1907, l’assistenza extra-manicomiale, che è poi diventata quasi un preciso dovere nel regolamento del 1909: ed ora consiglierei di provvedere alla prevenzione della pazzia istituendo un ambulatorio per la diagnosi e la cura dei disturbi di carattere nervoso, onde arrestarli nei loro primi sintomi. Così si fa in parecchie città americane; questo richiede insistentemente in Francia Roubinovitch, medico capo dell’ospizio di Bicètre».
Il video allegato è dedicato alla figura e l’opera di Fernando Nannetti.a Volterra.
A seguire la parte II – Rivolte, no-restraint, lotta allo stigma (clicca qui per proseguire)
Nel leggere la storia del secolo e mezzo di vita del manicomio in Italia e la sua conclusione negli anni ’60-’70 viene spontanea una domanda: ma possibile che se il manicomio costituiva una cosa così contraria al sentimento di umanità e così antiterapeutico, questo non fosse venuto in mente prima di quel decennio alle migliaia di psichiatri e amministratori pubblici che se n’erano occupati?
Una prima risposta ce la dà il gruppo diretto da Franco Basaglia quado, nel porsi nel 1967 la domanda cruciale Che cos’è la psichiatria?, individua – sia pure cogliendone soprattutto nel secondo caso anche i limiti, due illustri predecessori nell’inglese John Conolly e nel francese Evariste Marandon de Montyel[i]. Ma in Italia - ora che negli ultimi anni, pur mantenendo un carattere di nicchia e di asistematicità, gli studi delle varie istituzioni psichiatriche stanno facendo indubbi progressi - non è proprio possibile cogliere voci che, tra gli amministratori e gli psichiatri, si sono levate negli anni contro gli aspetti più deleteri del manicomio (l’isolamento, la serialità, le condizioni spesso indecenti di sovraffollamento e di degrado, l’uso spregiudicato della contenzione fisica) e hanno tentato di varcare i confini?
E così, il modo migliore di celebrare i vent’anni dalla pubblicazione, a quattro mani con Emilio Maura, del volume Lo splendore della ragione. La psichiatria ligure nell’epoca del positivismo (Genova, La clessidra, 1999), mi è parso quello di cercare all’interno di quel corposo volume in due tomi, arricchito da un’abbondante riproduzione delle fonti, risposta a questo quesito per quel che riguarda il caso genovese, certo uno soltanto tra molti altri possibili.
E l’occasione mi è stata data dal cortese invito di Vanessa Federico - organizzatrice in collaborazione con Mattia Mariani, come lei dell’Associazione “Cara Milena”, Andrea Trafeli dell’Associazione “Inclusione Graffio e Parola” e con Fondazione CR Volterra - a partecipare a Volterra il 28 e 29 settembre al convegno Storie italiane di psichiatria. Primo memoriale Fernando Nannetti, al quale ho preso parte con la relazione: Spunti antiistituzionali nella psichiatria genovese dell’800.
Con essa, ho inteso richiamare alcuni dei non pochi riferimenti alla possibilità che si procedesse in senso contrario all’istituzionalizzazione su alcune questioni che presentano peraltro, mutatis mutandis, ancora un profilo di attualità nel dibattito psichiatrico attuale. Riferimenti che credo sarebbe interessante cercare anche nella storia di altre realtà italiane, e questo vuole essere anche uno stimolo in tal senso; e penso ad esempio, in omaggio al luogo che ci ha ospitati, al dibettito nella Provincia di Pisa, ricostruito da Vinzia Fiorino[ii], sulla costruzione del manicomio a Volterra, 70 chilometri dal capoluogo.
Una nota mi pare indispensabile: i manicomi ai quali faremo qui riferimento sono cinque: quello di via Galata, a brevissima distanza dal centro città, che ha funzionato dal 1841 al 1912, quando è stato demolito; quello di Quarto, fondato nel 1894 a una distanza maggiore ma non drammatica dalla città, raddoppiato nel 1932 e ancora visitabile; quello di Prato Zanino presso Cogoleto, pensato come manicomio-città, sorto a notevole distanza per i mezzi di allora dalla città, e destinato a superare negli anni ’70 del ‘900 i 2.000 internati; quello di Paverano, in città e di piccole dimensioni, che ospitò per qualche decennio la clinica universitaria e un reparto femminile, poi anche uno maschile; la succursale di La Spezia, aperta per contribuire ad affrontare il sovraffollamento e chiusa, dopo qualche anno, con l’apertura di Prato Zanino.
La prima questione è quella della distanza dalla città, dalla famiglia e dalla casa della maggior parte dei ricoverati. è un tema che emerge all’attenzione negli anni ’80 dell’800, quando il sovraffollamento nel primo manicomio, quello di via Galata, e nelle succursali che via via si erano aggiunte in giro per la città si era fatto insostenibile, e l’ipotesi dell’Amministrazione provinciale era quella di aprire un grande manicomio a Prato Zanino, nell’entroterra di Cogoleto, lontano dalla città. Di tutt’altro parere il direttore del manicomio e titolare dell’insegnamento universitario, Dario Maragliano, il quale puntava alla costruzione di vari manicomi piccoli, collocati in modo tale che tutti i malati della provincia potessero averne uno vicino a casa propria, alla propria famiglia e nel contesto di vita. Per sostenere le sue tesi, Maragliano fece pubblicare un supplemento de Il secolo XIX, già allora il primo quotidiano della città, dove espose il proprio parere e chiese di esprimersi su di esso a una cinquantina di direttori di altri manicomi italiani. E tra gli argomenti che affronta c’è appunto quello della distanza, in termini che dovremmo tenere anche oggi presenti quando inseriamo uno dei nostri pazienti in una struttura residenziale. Scrive infatti Maragliano: «Importantissima a considerarsi è quella dei rapporti fra i malati e le loro famiglie, rapporti, che sono ritenuti indispensabili dai più illustri alienisti, e che perciò è d'uopo facilitare quanto più è possibile. Perocché se bene spesso nei primordi del ricovero le visite dei parenti sotto inopportune o dannose pel malato, più tardi esse sono invece utilissime per ridestare e mantenere i sopiti sentimenti affettivi per la famiglia, per scacciare gli ultimi resti di un delirio depressivo specialmente quando ha per contenuto l'idea delirante (l'essere abbandonati dalla famiglia o che questa sia morta), per confortare il malato alla speranza di una prossima sortita, per rendere meno penoso il soggiorno del manicomio in quelli che hanno poca speranza di sortirne. Non di rado la vista dei parenti è valsa a togliere il malinconico da uno stato di mutismo e di stupore o a decidere a mangiare un malato che era da tempo d'uopo alimentare artificialmente». E ancora: «Né va trascurata la soddisfazione pel ricoverato povero che certo non riceve laute somministrazioni dell'Istituto, di poter ricevere la domenica e altri giorni di festa qualche ghiottoneria dalla famiglia, di comunicarle qualche desiderio o qualche bisogno che essa può soddisfare, di potere avere da essa qualche oggetto di abbigliamento o di indumento non largito dall'Istituto (…). Perocchè, dopo tutto, il manicomio non è una caserma da essere militarmente regolata e dove il ricoverato deve per corredo e per rancio uniformarsi alle prescrizioni soldatesche». Ma non è solo la necessità di mantenere i legami della persona con la famiglia a suggerire per una collocazione del manicomio in area urbana: «Perocché, oltre alle ordinarie distrazioni che possono attuarsi anche in un manicomio isolato, quali i trattenimenti musicali, le rappresentazioni teatrali, le festicciuole da ballo, giovano spesso in certi periodi della malattia o per certe categorie di malati le distrazioni che la città può offrire ne' suoi pubblici ritrovi, o in qualche straordinaria occasione. Spesso è questo anzi un mezzo per abituare un’altra volta il convalescente ai contatti sociali. Il grande Esquirol come mezzo di cura morale e di ricompensa faceva passare i suoi malati da Ivry a Parigi e spesso il compianto Prof. Verdona, suo allievo, prima di dimettere un malato usava mandarlo a passeggiare per le vie della città onde abituarlo un'altra volta alla vista delle persone, al rumore della vita. . Il manicomio di Reggio [Emilia], prossimo alla città, usa inviare molti de' suoi malati al gran Teatro Municipale quando è aperto, ed anche a Genova da parecchi anni un palco del Politeama Margherita è nella stagione di Carnevale preso in affitto dal manicomio che v'invia per turno i suoi pensionanti insieme a qualche povero».
E tra i commenti raccolti da Maragliano, mi pare particolarmente interessante su questo punto quello di Clodomiro Bonfigli, direttore a Ferrara: «Ciò che io allora diceva per Mombello devo ripeterlo oggi per Genova, la cui provincia ha una forma che in nessun modo si presta per l'istruzione di un Manicomio Centrale. Riguardo alle altre ragioni che Ella espone contro l'idea di un Manicomio unico, ed eccentrico per certe parti della provincia, talune di esse sono di tale gravità, che un Consiglio Provinciale non potrebbe porle in non cale senza meritarsi la taccia di curare assai poco il proletario, per il quale, disgraziatamente, più che per i ricchi, sono aperte le porte del Manicomio. Quindi è che su questo punto neppure, credo vi sia bisogno che la mia voce, qualunque essa sia, si aggiunga alla sua per stigmatizzare quella specie di relegazione a cui si vorrebbero condannare i pazzi poveri di gran parte della provincia di Genova»
Né la polemica risparmiava l’altro quotidiano genovese – mi pare importante notare anche il coinvolgimento della città nel problema - il quotidiano Il Caffaro, dove una lettera anonima sosteneva: «Lo stabilimento lassù, a grande distanza da Genova, obbligherebbe i parenti e gli amici dei ricoverati a una lunga e dispendiosa gita, mentre molti degli ammalati stessi ricevono visite e sussidi di viveri e indumenti. Nessuno può del pari ignorare che numerosi malati devono (oltre le amorevoli cure di quell'egregio sanitario che è il Dr. Maragliano, direttore del nostro Manicomio e del degnissimo vice direttore Dr. De Paoli) grande sollievo alle frequenti visite e alle conversazioni dei loro cari che ne possono rialzare il morale e contribuire in modo serio e positivo alla guarigione».
E così, la posizione di Maragliano raggiungeva anche il Consiglio provinciale, dove il consigliere Elia la riproponeva in questi termini: «In Genova - egli dice - i parenti degli alienati sono spesso chiamati da ragioni politiche amministrative e da mille bisogni della vita, possono quindi profittare di queste occasioni per visitare i loro cari, per richiamarli al consorzio, agli affetti della famiglia, alla realtà della vita, possono soccorrerli con piccoli doni, con qualche offerta, possono averli (quando tranquilli) ore e giorni in prova, e possono così contribuire al loro miglioramento. A Prato Zanino - continua l'oratore - chi potrà andar dagli infelici parenti? Pochi o nessuno». Ed è una sensibilità, questa al disagio di malati e familiari per la distanza del manicomio da casa, che ritorna nel 1912 in una lettera di Cesare Mannini, direttore della succursale di La spezia, nel momento in cui se ne prospettava la chiusura e il trasferimento dei malati a circa 100 chilometri di distanza nei manicomi genovesi: «Bisognerebbe aver assistito alle lamentele dei parenti dei ricoverati, alla notizia del trasferimento di questi altrove ed in luogo lontano, per convincerne quanto insieme di benevolenza, quanto affetto circonda spesso questi poveri disgraziati mentecatti! La maggior parte delle famiglie vive con i congiunti alienati la vita affettiva ed ama averli vicino: il culto degli affetti familiari verso i colpiti dalla malattia è indice di progredita civilizzazione (…). Che cosa dire infine del dolore sofferto da alcuni e non pochi alienati all’atto del trasferimento dal loro paese di nascita o di domicilio? Non in tutti i mentecatti è spenta la vita affettiva, gli affetti di simpatia all’ambiente ed alle persone di famiglia sono di quelli che più a lungo permangono anche nelle menti di coloro che furono colpiti dalla pazzia».
Parrà davvero strano, ma ancora oggi quando capita di dover sostenere che soprattutto i pazienti più gravi quando hanno necessità di un inserimento nella residenzialità dovrebbero trovarlo a breve distanza dal servizio, perché restino comunque in contatto con esso, non tutti sono convinti di questo e capita ancora di imbattersi in chi sostiene che è meglio non fissarsi sui principi, non fare dell’”ideologia”, essere flessibili e accomodanti… lontano dagli occhi lontano dal cuore, insomma, oggi come allora, soprattutto chi al cuore può dare qualche sobbalzo, e può rischiare di rendere un po’ meno semplicistica, tranquilli, lineare e comodi il nostro lavoro e la nostra idea della vita!
Altro tema sul quale Maragliano insiste è quello della dimensione ottimale per un manicomio, in riferimento al quale scrive: «Se v'ha principio saldo e quasi indiscusso nella nostra specialità è quello che i Manicomi non devono essere di troppo grande dimensione, senza di che l'ordine, la quiete restano compromessi e l’individualità del malato, che è caratteristica tendenza dell'odierna psichiatria di voler rispettata, resta perduta, confusa nella massa con danno nella sua cura, nella sua assistenza. Questo dogma, riconosciuto dai grandi maestri forestieri, ha avuto in Italia a volgarizzatori Gerolami, Zurli, Cardona e fra i viventi il Verga, il Biffi, il Roncati. Venne anzi fissata una cifra e questa, a seconda dei vari autori, oscillò fra i 300 e i 600 malati».
E lo conforta in questa posizione il collega Angelucci, direttore in quel di Mantova, per il quale: «Io molte volte mi sono domandato; ma come potrà un Direttore conoscere intimamente mille pazzi, e dirigere la cura secondo le varie attitudini e abitudini? Perché il Manicomio, come tu dici benissimo, non è niente affatto un carcere od un ricovero qualunque, dove il Direttore ha solamente l'obbligo dell'indirizzo e della sorveglianza, il Manicomio è un Istituto speciale, dove occorre che il Direttore si trovi a contatto co' suoi ricoverati e di loro si occupi individualmente. Spesso ho veduto che molti malati provavano una soddisfazione viva nell'esser ricordati, mentre se qualcuno viene dimenticato s'offende. Del resto, ciò è molto umano, perché nel piccolo mondo in cui viviamo, si sentono affetti e passioni come nel grande mondo».
E non solo questi argomenti di Maragliano riusciranno a bloccare in quel 1888 e per ventiquattro anni il progetto di costruzione di un grande manicomio a Prato Zanino, ma vengono anche ripresi con citazioni dirette allorché, nove anni dopo, in alternativa a quell’ipotesi si considera quella di raddoppiare le dimensioni del manicomio di Quarto, che avrebbero così anch’esse superato il migliaio di letti (anche questo progetto, bloccato in quella fase, sarebbe poi stato realizzato nel 1932). E così, le parole di Maragliano in difesa dei propri pazienti riecheggiano in Consiglio provinciale il 20 dicembre 1897 in quelle del consigliere Celso Motta: «Considerando anche la questione dal lato scientifico, è facile vedere che se un grande manicomio-città può servir benissimo a sbarazzare la società di tanti disgraziati, non riesce certo di vantaggio a questi ultimi, e si capisce facilmente il perché. Più si fa grande il numero dei malati, e più va perdendosi l'individualità di ciascuno, confondendosi nella massa con danno della sua cura e sorveglianza (…). Peisdesdorf, il celebre clinico di Vienna, dice che «prima legge nell'andamento di un buon manicomio deve essere l'osservazione e la cura INDIVIDUALE dei malati», e che pertanto esso non deve essere troppo grande: niun direttore può accordare la propria attenzione a più di 500 o 600 ammalati (…). Il Tucker, alienista australiano, che visitò più di 400 manicomi e di molti altri assunse per corrispondenza informazioni, veniva alla conclusione che (…) i migliori manicomi sono quelli che ne contengono solamente 300». O in quelle del consigliere Piaggio: «Nei piccoli Manicomi il malato è meglio conosciuto, osservato dall'alienista; nei grandi resta un numero di matricola, e viene reggimentato e inviato nella sezione piena zeppa di altri pazzi che lo contagiano moralmente e che finiscono coll'impedirgli di guarire. E poi nei piccoli Manicomi la cura si può fare individualmente: nei grandi no, ché l'individuo non è più distinguibile dalla massa. I Manicomi grandi - oltre a 800 malati - costituiranno la vergogna del XIX e forse anche del XX secolo. Essi non sono più nè ospedali, né ospizi, né luoghi di cura, né luoghi di studio: sono caserme, alveari dove tutte le individualità morbose si amalgamano in un intreccio di pazzia e di contagio di pazzia. E quando i nostri posteri domanderanno i perché furono costruiti, e si sentiranno rispondere dai vecchi resoconti dei nostri Consigli Provinciali che lo furono per economia, allora forse arrossiranno per noi e ci compatiranno come poco previdenti».
Ubicazioni e dimensioni del manicomio, dunque, agitano il dibattito già in quegli anni, e non manca chi si è accorto che il rapporto con la famiglia, con la casa, l’individualizzazione della cura sono strumenti che vanno contro l’istituzionalizzazione, cioè l’assoggettamento totalizzante della persona e la sua serializzazione da parte dell’istituzione, e favoriscono processi di guarigione. Così, sul manicomio sembra pesare costantemente l’alternativa costituita dal modello di Geel, il villaggio belga dove, per motivi inizialmente devozionali, attraverso i secoli comuni cittadini si sono specializzati nella cura degli alienati presso le proprie famiglie[iii]. Insomma, in alternativa alla costruzione di nuovi e più grandi manicomi, che sarà poi sempre la soluzione adottata nella storia genovese come nella maggioranza delle altre, non è proprio possibile mettere a pensione i malati presso famiglie, evitando così loro, tra l’altro, i danni dell’istituzionalizzazione.
E fa riferimento, sia pure in senso negativo (ma comunque Geel è nominata, a quell’ipotesi alternativa e antiistituzionale bisogna pensare, sia pure per scartarla), una delle tre lettere anonime sull’argomento dei manicomi che l’avvocato Stefano Castagnola riceve nel 1878, dieci anni prima dunque della polemica che ha visto protagonista Maragliano, quando già si poneva il problema dell’affollamento: «La prima volta si pensò di provvedere all'agglomeramento, collocando dei mentecatti cronici ed innocui in campagna presso famiglie di onesti ed agiati contadini. Non si pensò che questo rimedio non era attuabile che per un numero scarso di mentecatti - quello dei convalescenti - e non mai come norma generale; ma giova ancora osservare che, anche per i convalescenti, tale sistema non ha dato risultati soddisfacenti fuori di Geel dove speciali circostanze da epoche, direi, quasi immemorabili ne favorirono gradatamente l'attuazione». L’anno successivo, è la commissione d’inchiesta sul manicomio nominata dalla Provincia e formata da Serafino Biffi, Gaetano Pini e Augusto Tamburini a prendere di nuovo in considerazione l’ipotesi per ribadirne l’impraticabilità: «Riguardo poi al collocamento de' malati in pensione presso le famiglie non è attuabile che per un numero scarso, quello dei convalescenti ,0 e non mai come norma generale, ma regolandosi sempre secondo i casi speciali: fuori di questi casi tale sistema non ha dato risultati soddisfacenti, fuori di Geel dove speciali circostanze da molti secoli ne favorirono gradatamente l'attuazione». E ancora vent’anni dopo, nell’esporre le proprie conclusioni sulla questione manicomiale, è il relatore G.B. Segale ad affossare alla seduta del Consiglio provinciale del 25 novembre 1897 definitivamente l’ipotesi: «Il sistema della cura in case private presso famiglie che se ne prendono volontariamente l'incarico si è alquanto diffuso negli ultimi anni nel Belgio, nella Scozia, nell’Inghilterra, nella Germania e, nel Nord-America limitatamente al Massachussets. In alcuni di tali paesi gli alienati assistiti in questo modo costituiscono delle colonie libere, in altri sono alla dipendenza e sotto la sorveglianza dei manicomi. Pregi del sistema sono: evitare l'agglomeramento degli alienati in genere; evitare il contatto troppo comune e dannoso dei ricoverati coscienti e depressi cogli altri alienati; sbarazzare il manicomio di un certo numero di alienati inoffensivo ed incurabili; evitare le spese di costruzione di nuovi asili e di diminuire le spese del ricovero. Difetti dello stesso sistema sono: non essere applicabile che a un numero ristretto di alienati; esigere molto tempo per abituare le famiglie e il pubblico ad avere cura di tali malati e tollerarne il contatto; richiedere per essere attuato condizioni speciali economiche locali e d'indole adatta nei custodi. In complesso i difetti sono superiori ai pregi, tantoché anche nei Paesi dove venne adottato il sistema dell'assistenza in famiglia, questo è usato in proporzioni assai minori del ricovero nel manicomio; in una regione inoltre, il Massachussets, non ha, dato buoni risultati. E’ pure degno di nota che il suddetto metodo non è usato in Italia (salvo eccezioni individuali) e nemmeno in altri paesi di origine latina o greca, evidentemente perché l'indole vivace degli abitanti e per conseguenza degli alienati non vi si presta».
Miopia, mancanza di originalità e di coraggio, pregiudizi e stigma? Probabilmente sì; in ogni caso l’ombra di Geel, con un riferimento alla psichiatria ambulatoriale che pare già in direzione dei CIM, riaffiora di nuovo quando il consigliere Piaggio, nei verbali della Commissione d’inchiesta su Quarto del 1910-11, afferma: «Per parte mia ricordo di aver consigliato, fin dal 1907, l’assistenza extra-manicomiale, che è poi diventata quasi un preciso dovere nel regolamento del 1909: ed ora consiglierei di provvedere alla prevenzione della pazzia istituendo un ambulatorio per la diagnosi e la cura dei disturbi di carattere nervoso, onde arrestarli nei loro primi sintomi. Così si fa in parecchie città americane; questo richiede insistentemente in Francia Roubinovitch, medico capo dell’ospizio di Bicètre».
Il video allegato è dedicato alla figura e l’opera di Fernando Nannetti.a Volterra.
A seguire la parte II – Rivolte, no-restraint, lotta allo stigma (clicca qui per proseguire)
[i] Cfr. in questa rubrica: Che cos’è la psichiatria? 50 anni dopo. Parte III. Tutta un’altra storia, POL. it, 17 giugno 2017.
[ii] Cfr. V. Fiorino, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), Pisa, ETS, 2011.
[iii] Ricordo in proposito il contributo personale: P.F. Peloso, Psichiatri a scuola dai contadini? Il “miracolo” di Geel tra devozione, integrazione e terapia dei folli, Humanitas, 70, 2015, 3, pp. 379-388.








