La follia da dentro RECENSIONE A "LA DOPPIA MORTE DI GEROLAMO RIZZO - DIARIO "CLINICO" DI UNA FOLLIA VISSUTA
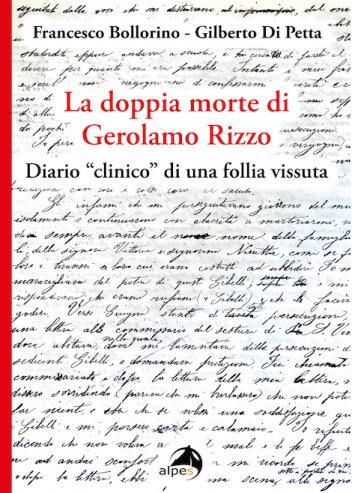
Questo libro che tenete tra le mani e state sfogliando, è un testo breve e avvincente, scritto a quattro mani da Francesco Bollorino e Gilberto Di Petta, che di professione fanno gli psichiatri, in prevalenza, ma anche molto altro. Per la verità la storia che vi si narra non l’hanno scritta loro, ma il proprietario di quella storia, di quella vita tormentata dalla pazzia, di cui era perfettamente cosciente e in grado di prevederne la cronicizzazione, un maestro elementare genovese di nome Gerolamo Rizzo. Nato nella città della lanterna nel 1867, era stato internato nel manicomio di Quarto, dopo essere passato dal carcere di Marassi per aver ucciso un prete con un revolver in Piazza Umberto I. A questo punto è necessario prestare la massima attenzione a luoghi, vie, date e circostanze, altrimenti quello che in fondo potrebbe essere letto anche come un “giallo”, lasciando perdere la psichiatria e tutto quanto le galleggia intorno, diventerebbe un complicato cruciverba. Uno stordente rompicapo tra normalità/follia, presente/passato. ordine/disordine, logico/illogico, congruente/incongruente, e così via all’infinito per opposti.
Intanto bisogna partire dalla toponomastica per ripristinare l’ordine delle cose e chiarire come i genovesi, durante la baraonda dell’8 settembre 1944 (per noi una vera e propria guerra civile,), cambiarono il nome alla Piazza intitola a quel re d’Italia ucciso a Monza dall’anarchico Bresci, in quello del repubblichino Ettore Muti, per mutarla frettolosamente in Cesare Matteotti a guerra finita, nel 1945, dov’è chiaro chi ha vinto e chi ha perso.

Ristabilito così un minimo di orientamento urbano e temporale, diciamo che il delitto di Gerolamo Rizzo, risale alla mattina del 30 settembre del 1908 quando, perseguitato da un’esperienza delirante-allucinatoria, iniziata 4 anni avanti (1904) a Campoligure, in Val Stura, il nostro uccide a revolverate, senza motivo apparente, un prete, il primo a caso, essendo il “comando esteriore” divenuto imperioso e ormai una sorta di “destino” si doveva compiere. Il proposito insano era giunto al passaggio all’atto. «Decisi di farla finita col primo signore o il primo prete che avessi incontrato per istrada - scrive Rizzo - mi avviai per via XX Settembre e in questa, vidi un prete, ma era lontano da me e mi avviai verso il Palazzo Ducale dove incontrai un altro prete e là successe quello che doveva succedere». Come ci spiega Gilberto Di Petta «Si trattava di don Paolo Canessa», per l’appunto il primo prete che gli venne a tiro.
Tratto in arresto e condotto al carcere di Marassi, vi fu tenuto «per sei mesi e sei giorni ... insieme a finti matti» come scrive il nostro “vero matto” Gerolamo Rizzo, prima di essere internato al manicomio di Quarto. Ebbe, tra l’altro, il meschinettu, l’onta infamante di traversare « ... una parte di Marassi e di San Fruttuoso, esposto alla berlina, perché tutti si affollavano per vedermi, e questo mi amareggia molto, perché io sono conosciuto a Marassi dove ho fatto scuola [come insegnante n.d.r.] non più tardi dell’anno scorso».
Ecco proprio di questo contenuto eccezionale si è voluto dare un anticipo tacendo di proposito che l’11 febbraio 1932, ossia 24 anni dopo una “custodia” manicomiale ininterrotta, senza motivo apparente Gerolamo Rizzo viene massacrato, a mani nude, da tale Merlati Francesco un “altro ammalato”, un compagno di sventura, nella latrina dello stesso manicomio di Genova Quarto, che avrebbe dovuto almeno “custodirli”, se non curarli. Evidentemente era proprio il manicomio in sé, come “istituzione” inutile, oltre che nociva, che non aveva custodito un bel nulla. Non è neppure tollerabile una (tragica) distrazione, se l’asilo dei matti, che li conteneva entrambi, non aveva saputo impedire che un “morto civile” avesse potuto dare la morte fisica ad un altro trapassato “civile” tale e quale a lui.
Se ne possono dare diverse letture, o meglio, ciascuno può leggerselo come gli pare. Ma, visto da uno psichiatra come chi scrive, nato proprio l’anno in cui il nostro povero Gerolamo moriva, ovvero di quei medici che dopo aver praticato la clinica medica (Frugoni, Condorelli) del Policlinico Umberto I di Roma, profondamente insoddisfatto del suo sapere intorno alla mente umana, aveva tratto il dado e passato il suo Rubicone. Traversato il Viale dell’Università era andato a specializzarsi in neuropsichiatria con Gozzano, sennonché l’ultima sterzata definitiva è stata quella di salire al Manicomio di Santa Maria della Pietà per iniziare e portare a termine la rivoluzione del 1978. Nondimeno i piani di lettura restano infiniti. Anzi, le idee che si possono affacciare alla mente dei lettori durante e dopo l’incontro con questa pubblicazione non hanno limite. Voglio dire oltre l’interpretazione psicoanalitica e perfino al di la della lettura fenomenologia perchè tutta la narrazione, meno che le paure allucinatorie e le diffidenze persecutorie, restano di una logica inoppugnabile, stringente, analitica, geometrica. Un esempio? Leggiamo come ragiona.
«Così dopo sei mesi e sei giorni mi trovo al manicomio: ora mi domando che criterio han seguito i miei giudici a farmi fare sei mesi di carcere; se son pazzo, perché non mi han portato direttamente al manicomio (tanto più che al delegato avevo raccontato tutto e affermato che non conoscevo la vittima, ed egli di questa confessione ne aveva fatto rapporto che mi fece firmare) appare appurato che ero, i miei fratelli specialmente interessati, anche per l’onore della famiglia, perché non fecero in modo che mi mandassero al manicomio ... non ho mai potuto comprendere come si possa mandare, in osservazione, in un carcere per vedere se è matto un uomo che commette in un momento di sovraeccitazione un omicidio o un ferimento, ciò ripugna il mio buon senso. Il posto naturale è in manicomio, dove ci sono medici specialisti che visitano diverse volte al giorno e curano gli ammalati, e dove dopo attenta osservazione di qualche tempo, possono farsi un criterio esatto se un uomo è matto o no. Invece in carcere dopo due tre visite dei periti, io e i miei compagni, non avessimo che qualche rara visita del medico della prigione, il quale, del resto, non è specialista delle malattie mentali, e che ordinava qualche purga o qualche medicamento atto a guarire le altre parti del corpo, ma non il cervello. L’ultima visita in carcere l’ebbi dal perito, sig. Tomelini, il quale una sera mi fece chiamare, per dirmi (si era ai primi di dicembre) che da un mese circa doveva essere al manicomio; accompagnando questo dire con l’atto di uno che se ne lava le mani».
D’accordo che non basta ragionare bene per non essere matti e neppure scrivere bene, altrimenti non apprezzeremmo le poesie di Alda Merini, né La metamorfosi (1915) di Franz Kafka. Questo libro di Bollorino e Di Petta l’ho letto volentieri e mi ha intrigato moltissimo per le molte penombre e i tanti misteri, di cui forse quelli psichiatrici sono i più facili da rischiarare e da sciogliere. Li per lì mi son domandato: epilessia temporale? Psicosi epilettica? Nooo! Niente lucido intervallo non convulsioni, assenze, personalità vischiosa... Meglio leggere. Per alcuni momenti m’è sembrato di aprire un testo di Tanzi e Lugaro, più discorsivo e meno formale. Poi ho trovato la giusta collocazione audiofonica. Leggendo, in silenzio, seduto in poltrona, codesto diario di Gerolamo Rizzo, ho sentito distintamente le parole scritte da Francesco e Gilberto fondersi in una sola voce, quella di Aldo Giannini che diceva - con calore e passione - la sua relazione. al Congresso SIP di Milano, quella mattinata di martedì 15 ottobre del 1968 alle ore 11 al Palazzo dei Congressi della Provincia [Cfr. Pol. It. Psychiatry on line Italia, di Aldo Giannini Modalità esistenziali e situazioni prepsicotiche schizofreniche 23 marzo, 2019]. Eppoi siamo proprio sicuri che questa specie di spuria volontà testamentaria sia giunta fino a noi se tutte le più fortuite coincidenze astrali non fossero state favorevoli?
Così, d’acchito direi che Francesco Bollorino alla stregua di un cercatore d’oro si è imbattuto in una grossa pepita, trovando in maniera del tutto fortuita il diario scritto di pugno da Gerolamo Rizzo compilato da se medesimo sul proprio disturbo mentale, con parole umane, comprensibili, atrocemente sofferte. Diario celato negli anfratti di una cartella clinica manicomiale sepolta tra cataste polverose. Non stupisce certo il “vissuto di doppio binario”: di qua la mia sofferenza patologica, la mia richiesta d’aiuto disperato, la mia attesa spasmodica e, a coté, da un’altra parte, come fosse “incomunicante”, la narrazione distaccata del soggetto che esperisce il duro realismo della realtà psicosica, la sua stessa sfuggitagli altrove. La sua propria mémeté, di cui si è divenuti “spettatori”, in un divenire che sta lentamente, inesorabilmente peggiorando. Un futuro senza speranza, ammalorativo, raccontato con una strana obiettività, uno pseudo distacco, una critica fredda, nondimeno sufficiente a rivelare puntualmente tutte le contraddizioni delle Istituzioni tutte. Nessuna esclusa di codeste Istituzioni, tipo Asylum (1961), quella che fece scuola, esplorata in incognito dal canadese Erving Goffman (1922-1982). “Istituti” violenti e ottusi che non hanno mai accettato, fino a che non sono stati aboliti (o ridimensionati), nè di essere negate né criticate.
D’altro canto, rileggendo attentamente le fratture contenute nel diario di Gerolamo, non potremmo non cogliere in nuce, un canovaccio de “l’Io diviso” (1955) intuito 46 anni prima che Ronald Laing avesse a scriverlo. So che per molto tempo userò questo libriccino involontario e sapiente, sui fatti della vita, comme livre de chevet. Ci sono già molti passi che mi piace rileggere, anzi sento l’urgenza di andarli subito a rivedere, prima che mi sfugga il richiamo, l’associazione, il dettaglio...
È un piccolo trattato su una “malattia” particolarissima che tutti credono d’intendere immediatamente, quando ci si tocchi il capo alludendo, o sussurrando a bassa voce “infermità mentale”. Ma nessuno sa, nè ha mai saputo, fino ad oggi, che cosa propriamente sia. C’è anche chi giudica illegittimo l’appellativo stesso di “malattia”, perchè non si è mai riusciti a trovare un chiaro sostrato neuro-anatomo-patologico. C’è, invero, anche una tregua generale (non propriamente un accordo strictu sensu) fra psichiatri, neuropsichiatri, neuro-scienziati, psicoanalisti, psicologi clinici, sperimentali e così via, sul fatto che, codesto grave disturbo abiti la mente, ma è nozione comune che esista almeno una mente psichica e una mente neuronale (Bruno Callieri), per tacere di quella neurochimica, che ci porterebbe lontano. Si sa che si tratta di un grave disturbo del pensiero e della condotta, per dirla in termini molto generali, altrimenti definibile come non essere compos sui, padrone di sé, in sentimenti, ecc., ma che rispetto a tutti gli altri disturbi, impegna almeno il triplo delle risorse in termini economici e di caregiving. Tra gli specialisti, la tregua in questione (non quella di Primo Levi che nei giorni della memoria dell’olocausto si riaffaccia prepotente) regge pure sul dato che ci sia una reciproca interdipendenza tra le due menti, tanto che il funzionamento dell’una è impossibile senza l’altra e viceversa. Il minimo, di abbinamento è necessario, per camminare, pensare, mangiare, accettare, rifiutare, scegliere e via dicendo. In una, per potersi tradurre nell’esistenza, nella presenza mondana di ciascuno di noi, col suo destino e le proprie scelte. La semplicità di Gerolamo Rizzo è disarmante: lui che ci è passato e che c’è morto doppiamente, quella roba lì che è giusto il contrario di salute mentale, l’ha chiamata “La mia infelicità”.
La particolarità che rende unica questa singola, eccezionale, dettagliata storia di follia, consiste nel fatto che è il “memoriale” autografo e autobiografico di uno dei tanti “matti” internati nell’ex manicomio di Quarto, da noi, in Italia, cessato, come del resto tutti gli altri, dal 1978. È stata una vera fortuna, perché - come ci spiegano gli Autori - anche le cartelle cliniche dei pazienti di Cogoleto, il manicomio genovese “di rinforzo”, vi vennero confuse e abbandonate alla rinfusa, peggio delle loro vite. Insomma, un tristissimo guazzabuglio generale e colpevole. Non si scherza con la memoria! Dunque, l’eccezionale ritrovamento del “diario”, la sua venuta alla luce - tra le tante carte - è interamente dovuta alla tenacia, al fiuto, all’azione maieutica e appassionata di Francesco Bollorino, come ci racconta molto bene Gilberto Di Petta.
Sul reperimento fortunoso del memoriale si può leggere testualmente «Le cartelle cliniche e, attraverso di esse, le vite di migliaia di pazienti, abitavano grandi scaffali in faldoni polverosi suddivisi per anno, in tre ampi stanzoni al primo piano di un edificio isolato nel grande comprensorio dell’Ospedale Psichiatrico di Cogoleto» e subito dopo la nota 2 avverte che «Oggi l’Archivio delle cartelle cliniche degli ex OPP della Provincia di Genova si trova in un fondo dell’Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto», dunque Quarto e Cogoleto il più antico e il più recente luogo della sofferenza mentale di Genova nel XIX e nel XX secolo.
Ma non basta. Si può dire di più senza tema di esagerare. Incredibile il fiuto di cane da tartufi di Francesco che, manco fosse uno sherpa, in un Nanga Parbat di cartelle di piccoli dei e di vite recluse è andato a pescare proprio quella di Francesco Merlati, l’assassino di Francesco. E pensare che io ho sempre tentato di scovare la cartella clinica del padre di mio suocero uno degli antenati dei miei nipoti, senza riuscirvi. Giuseppe, il nonno di mia moglie che non conobbe mai, era tornato sconvolto e arrabbiato, nel 1918, dalla “Grande guerra” ... “non più un soldo nè un uomo per la guerra!” dissero allora i superstiti della carneficina. Aveva partecipato ai moti rivoluzionari dei comunisti genovesi in sciopero e così fu internato a Quarto. Ma non aveva ucciso nessuno.
La doppia morte di Gerolamo Rizzo. Diario clinico di una follia vissuta. Un giallo italiano della pazzia lucida, proposto da due psichiatri che scavano nella montagna polverosa delle cartelle manicomiali, ora che sono divenuti luoghi di memoria, dove si possono anche trovare contributi dei protagonisti. Basterebbe cercare ancora. Lo stile potrebbe essere quello della formidabile coppia Fruttero e Lucentini, ma la storia non è inventata. La follia è vera ed è raccontata, anzi scritta in perfetto italiano, con acribia di storico medievista dal protagonista medesimo, Gerolamo Rizzo da Genova, un insegnante elementare trentenne, nel momento in cui viene assaltato dai suoi implacabili fantasmi persecutori che gli distruggono la vita. Difficile trovare qualcosa di comparabile. E perchè non un “Murder mystery" di Agatha Christie, o non una “detective story” alla Sherlock Holmes? Forse il giallo non si addice alla storia di Gerolamo. Semmai il nero.
La fantasia galoppa, ed ecco che i luoghi, il crimine, la follia, richiamano alla mente moltissimi temi psicopatologici che, peraltro, dall’insegnante genovese omicida, sono trattati con piena padronanza e proprietà di linguaggio, nel suo “diario”, non per scienza ma per esperienza. Perchè allora non dare anche una capatina alla Prefettura di polizia di Parigi, diretta per una vita da Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934), celebre non solo e non tanto come fotografo, pittore, drappeggiatore, vespillone sublime, altresì esperto di dipendenze da droghe, come hascisc, cloralio, ecc. nonché maestro di Jacques Lacan, il quale quando veniva richiesto di dire il nome del suo maestro lo sbagliava regolarmente, ma anche per aver dato l’eponimo a Les psychoses passionelles, le psicosi deliranti della sfera affettiva tipo satiriasi, ninfomania ed altre parafilie.
Per il fatto che ad un certo punto, Gerolamo Rizzo, si senta osservato, scrutato, controllato da estranei che intrudono, con macchine prima ancora di aver sospettato l’invenzione del macrocacofono, nella disponibilità dei Gibelli, se diamo un’occhiata alla letteratura psichiatrica, scopriamo che Danilo Cargnello cita il caso di Clita una sua paziente operaia che tranquilla in fabbrica si sente nuda, trasparente nel tragitto dalla fabbrica a casa.
Saltiamo di prendere in considerazione la Sindrome di Capgras - tutti i familiari e conoscenti sono i sosia dei sosia - perchè non ci pare proprio il caso. Gerolamo, per quanto se ne sa, risulta tranquillo e appartato, sulle sue, spesso rincuorato.
Mi viene invece in mente un divertente libro di Carmine D’Angelo Lettera di un neurone a sé medesimo, solo che non è proponibile perché, malgrado fosse perito settore anatomo-patologo e primario dell’accettazione del Santa Maria della Pietà, nonché docente di neuropatologia alla “Cattolica” di Roma, era un poeta e un buontempone che si divertiva a pescare col rezzaglio. Ad un certo punto, su da noi, al manicomio della provincia romana, corse voce che con Ugo Cerletti avesse fatto l’elettroshock a un leone depresso del Giardino Zoologico. In effetti, la celebrità internazionale, nata casualmente a Conegliano per via del padre enologo, da pensionato, saliva spesso a visitare l’amico Carmine, ma la storiella del leone depresso è un’antica fake news dei tempi del manicomio.
A questo punto, è utile una piccola digressione storiografica, per meglio apprezzare nella sua rilevante importanza la mémoire del nostro Gerolamo Rizzo. La storia, la grande storia, fino all’inizio del 900 era interessata ai grandi avvenimenti e ai grandi personaggi, re imperatori, condottieri, generali, personaggi religiosi, ecc. A nessuno sarebbe importato sapere la storia del poveretto che abitava al piano di sotto di casa tua, come direbbe Alessandro Barbero, quello strano storico medievista che riempie le platee di oggigiorno come una star della cultura in assoluto e con assoluta legittimità. Difficile trovare, in precedenza un fenomeno di raffronto. Probabilmente, ciò significa che tutti sentiamo la necessità di pensare a cose alle quali non avevamo mai pensato, invece che star li a sguazzare nel negazionismo per ripetere a pappagallo che la shoah non c’è mai stata (anche perchè i testimoni diretti vanno pian piano spegnendosi). O a perdere tempo con domande di storia controfattuale, tipo “Se a Canne avessero vinto i Cartaginesi”. Ma anche, per esempio, a lambiccarsi il cervello per immaginare cosa mangiasse il popolo minuto, quando il presunto traditor della “Meloria”, comandante di mare pisano di fede ghibellina che non disdegnava la guelfa, conte Ugolino della Gherardesca, nel 1289 sollevava la bocca dal suo fiero pasto alla “Torre della Muda”.
C’è stato un tempo recente in cui le cartelle cliniche contenute nei faldoni dell’ex manicomio genovese di Quarto dei Mille, da 700 pazienti, inaugurato nel 1895, furono radunati insieme a quelli appartenuti all’altro ex-O.P.P. genovese di Cogoleto, da 3.500 posti letto, un mastodonte realizzato nel primo decennio del ‘900 come supporto al precedente, sulle amene colline di Pratozanino e con la triste fama di essere il più grande manicomio italiano. Si trattava di un progetto importante di recupero della memoria storica della popolazione ospitata e reclusa nei manicomi d’Italia intitolato “Carte da legare”. Ebbene, proprio da quei propositi e da quel clima presero la rincorsa le indagini, la verifica e la ricerca storica del “documento” di Francesco Bollorino e successivamente la lettura a tutto campo dei contenuti psicopatologici della vicenda - la piccola storia personale - secondo l’indirizzo fenomenologico, filtrato attraverso l’interpretazione psicoanalitica. Ma l’impianto, la solida radice di fondo, a me sembra il modo, la tecnica di Fernand Paul Braudel, Marc Bloch e Lucien Febvre, quelli della rivista francese de “Les annales” che mutarono radicalmente il lavoro dello storico e di leggere la storia partendo dal basso, dal dettaglio.
Per quanto mi riguarda, fui chiamato a partecipare all’iniziativa napoletana, intitolata “Carte da legare” [Cfr. Pol. It. Psychiatry on line Italia di Sergio Mellina. In ricordo di Fausto Rossano (1946-2012)Folia/Follia. Quelle carte da legare del “Bianchi” di Napoli. 6 agosto 2018], promossa da Fausto Rossano sugli archivi delle cartelle cliniche dell’Ospedale Psichiatrico Leonardo Bianchi di cui fu l’ultimo direttore per la dismissione definitiva.
Nondimeno non posso negare di essermi soffermato più volte, negli anni del “Santa Maria della Pietà”, sulle cartelle dei padiglioni per “cronici e tranquilli”. La cosa che mi colpiva maggiormente era la foto segnaletica all’interno della cartella che Giuseppe Francesconi, il mio primario di allora strappava con rabbia e faceva in mille pezzi. All’esterno, in alto a destra con lapis rosso, talvolta c’era scritto e sottolineato “tendenza alla fuga”. Ma la suora mi diceva che era costumanza di un tempo. Invece all’interno si potevano rinvenire documenti personali, lettere mai spedite, frammenti di giornali ed altri indizi che narravano le circostanze dell’internamento, riallacciavano la vita di quell’essere al mondo da cui era stato espulso senza più diritto alcuno, nemmeno di votare: “la morte civile”. Si leggevano spaccati di vita dell’epoca, mode, usanze, parole correnti, avvenimenti famosi, personaggi, scoperte eccezionali.
È proprio il colpo di fortuna capitata a Francesco Bollorino e Gilberto di Petta mi son detto sobbalzando sulla poltrona, man mano che procedevo nella lettura di questo reperto di follia unico e, forse, irripetibile, autocertificata con grande sofferenza e con grande precisione di precipitar di fasi psicopatologiche ... carne viva in corpore vili ... mente assediata da sconosciuti ostili, orecchie lacerate da voci inaudite, superficie corporea, trapassata, violata senza difesa da onde invisibili, una ininterrotta sequenza di mise en abîme dove precipita una meità frantumata. Questo ci racconta la storia di Gerolamo Rizzo che non è uno storico, non riferisce un’anamnesi, ma racconta l’esperienza di cui suo malgrado è protagonista. Penso che ognuno di noi il quale abbia a che fare con le vicende della follia, farebbe carte false per sapere come si vive tormentati dalle allucinazioni, cosa si prova avendo esperienze deliranti. Penso a Morselli G.E. Non il cattedratico di Genova Enrico, il modenese, quello che pur non avendo capito nulla di psicoanalisi ci aveva scritto sopra due libri per denigrarla, inviandone copia a Freud, il quale non si tenne dal rispondergli che gliel’avrebbe spiegata, con calma, quando fosse passato da Genova. No! (G.E.) Giovanni Enrico Morselli (1900-1973) il milanese, il direttore del manicomio di Novara, lo psichiatra reso celebre dalla psicoterapia con una paziente psicotica, “Il caso Elena”, Sulla dissociazione mentale (RSF CXXXV N° 3/2011) e dalla sperimentazione personale con la mescalina [Morselli G. Enrico, 1962 (1936), Contributo allo studio delle turbe da mescalina, in AA.VV., Le psicosi sperimentali, Biblioteca di Psichiatria e di Psicologia Clinica, vol. 5, Milano, Feltrinelli, pp. 35-59].
Io stesso, a seguito di un intervento di cardiochirurgia per la sostituzione della mia valvola aortica calcifica con una biologica porcina, in circolazione extracorporea col cuore appoggiato ho potuto vivere una incredibile sequenza di esperienze psicopatologiche che si alternavano con una vivacità, una coloritura empatica e una reazione “da matto” d’inusitata violenza. Tutti i colleghi a cominciare dal cardiochirurgo Francesco Musumeci, al rianimatore che mi aveva somministrato le droghe allucinatorie a tutti quelli che si erano presi cura di me, malgrado i miei acting out (gli “agiti catastrofici” come scrivono Bollorino e Di Petta), compreso quello di tentare di fuggire strappandomi il catetere, nei tre-quattro giorni terribili del post-intervento, mi hanno poi spiegato bene come rimettere le cose in ordine nella mente sconvolta attribuendo a ciascuna reazione patologica una causa diretta e facilmente spiegabile che però non mi ha mai completamente convinto. Molte volte ho cercato di descrivere queste mie esperienze come disvelamenti di flagranti proiezioni paranoicali, come allucinazioni domotiche, come intuizioni di pericoli o di errori terapeutici a controlli improvvisi di corsia. Alla fine ho però sempre desistito dandomi questa spiegazione convincente. Poiché il materiale di cui son fatte codeste esperienze artificiali e indotte, un sentire al limite della confusione mentale, delle allucinazioni di tutta la sensorialità, delle stimmung deliranti prive di quel coinvolgimento apocalittico da atmosfera di sabato santo, è lo stesso materiale di cui son fatti i sogni e, si dissolve nel momento stesso in cui, svegliandoti, corri a scriverlo nel taccuino che porti sempre a portata di mano.
Sotto questo profilo potrebbe essere molto utile la lettura antropofenomenologica, di cui abbiamo poc’anzi citato Danilo Cargnello, un grande. Potrebbe essere di molto aiuto, infatti, nella interpretazione daseinsanalytica del presente testo, un saggio di Paolo Scudellari della scuola bolognese di Clara Muscatello, che attira l’attenzione sulla Perdita dell’evidenza naturale, (Cortina, Milano 1998), noto cavallo di battaglia di Wolfgang Blankenburg, un Collega cresciuto con filosofi illustri: Heidegger, Szilasi, Fink, e con clinici di pari rilievo come Ludwig Binswanger. «Blankenburg - scrive Scudellari su Comprendre (Il progetto di Wolfgang Blankenburg per una psicopatologia fenomenologica N. 9, 1999) - offre un contributo magistrale e originale al “pensare psichiatrico”, nel suo difficile, ma suggestivo intreccio fra riflessione filosofica e prassi clinica» - e così prosegue - «Bisogna sempre tener conto del fatto - suggerisce Blankenburg nella sintetica presentazione di intenti della sua opera - che il contenuto di analisi fenomenologiche non si lascia sintetizzare in conclusioni comunicabili in termini di formule, all’interno di un sommario. Piuttosto esso si fonda nel percorso di decifrazione del senso della ricerca. Le affermazioni dei pazienti non fungono da prova, né da oggetto di applicazione di una teoria determinata. Il senso specifico dell’ermeneutica fenomenologica consiste piuttosto nel promuovere una interpenetrazione reciproca dell’esperienza e della teoria - nel rendere cioè l’esperienza trasparente alla teoria e nel contribuire a che la teoria raggiunga, attraverso l’esperienza, quella concretezza e quella differenziazione che le sono indispensabili».
In conclusione, sono perfettamente d’accordo con Gilberto Di Petta che «L’idea di pubblicare questo scritto ... va oltre l’interesse scientifico, e il destinatario non è solo tra gli psichiatri e gli psicologi. Questo messaggio nella bottiglia, che ha superato l’oceano della storia, che ha superato il Novecento, va al suo destinatario originale: la gente qualunque, l’uomo comune». Ma c’è di più.
Il libro ha qualità camaleontiche. Mi sono domandato se potrebbe esser letto anche come pura opera letteraria e la risposta è stata positiva. A mio avviso regge il confronto con una qualunque, una a caso, delle Novelle per un anno di Luigi Pirandello.
C’è un gruppo di scrittori russi di metà Ottocento che prende a raccontare di povera gente, impiegati, copisti, minutanti, quello stuolo di piccoli burocrati dell’impero zarista che fanno la fortuna letteraria di un’epoca in cui vige ancora la servitù della gleba, ma va maturando la grande Rivoluzione d’Ottobre del secolo successivo. Nicolaij Gogol' scrive Il cappotto (1842) un racconto grottesco in cui il protagonista è Akakij Akakievič e la cornice San Pietroburgo, ma il successo clamoroso gli verrà dal coevo Le Avventure di Čičikov, poi Le anime morte. Fëdor Dostoevskij pubblica Povera gente (1846), dove si narra l’amore epistolare di due giovani cugini in seconda, Varvara e Devushkin che si raccontano i loro fatti quotidiani, la miseria, le speranze, i sogni. Abitano di fronte, nella stessa strada, in case fatiscenti. Tutt’intorno, una popolazione miserabile malata che muore di fame, ma c’è chi tenta di riscattare l’amato impossibile, sposando un uomo vecchio e ricco che non ama. Un classico. Il romanzo commuove la Russia. Anton Pavlovic Checov , di cui vale la pena ricordare le umili origini e il non trascurabile dettaglio che il nonno Egor Michailovič - dietro versamento di 3.500 rubli al padrone (conte Čertkov) - ottenne il riscatto per se e pei suoi discendenti dalla condizione di servo della gleba, da alle stampe una serie di racconti tra i quali La morte dell’impiegato (1883), un meschinetto reo di avere “asperso” con uno starnuto un generale a teatro.
Ecco, a parte la sua follia, perfettamente descritta, gli eventi narrati nel memoriale pervenutoci da Gerolamo Rizzo, l’insegnante genovese manicomializzato, mi pare non si discostino dalla grande letteratura russa, nè per stile, nè per contenuti.
Si potrebbe anche aggiungere che, Ninetta Gibelli, non è certamente Klara Olsuf'evna la protagonista de Il sosia (1846) di Dostoevskij, ambientato a Pietroburgo, ma come non adombrare nel memoriale tragico del maestro elementare anche il topos letterario del “doppio”, in fondo, un classico delle diffrazioni della follia. I due racconti corrono su binari paralleli. Jakov Petrovič Goljadkin, il protagonista della storia, consigliere titolare di cui viene descritta impareggiabilmente una non dissimile “discesa agli inferi”, gradino dopo gradino, il “nostro eroe”, scrive l’autore, è innamorato di Klara - mentre Gerolamo Rizzo è perseguitato da uomini minacciosi che gli assediano la porta di Campoligure dove trascorre la sua vacanza, affinché la prenda in moglie - che si da il caso sia la figlia del superiore. Cacciato indecorosamente da una festa che si tiene nella casa di Klara, Goljadkin s’imbatte in una figura maschile che gli somiglia in tutto e per tutto e per giunta si chiama come lui, oltre ad aver passato la medesima vicenda ed esser nato nello stesso luogo. Praticamente due Goliadkin uno maggiore e uno minore, una mémeté che si mondanizza a coté e gli cammina accanto, ma gli è ostile, lo sbeffeggia e lo ferisce con sguardi umilianti cogliendolo in tutte le situazioni dove lui soccombe nella caotica, prestigiosa e raffinata vita pietroburghese che si coagula nella Prospettiva Nevskij. Il “minore” dei Goljadkin si coprirà di ridicolo perdendo gradualmente ogni dignità e considerazione di sé, al contrario del “maggiore” che salirà tutti i gradini dell’empireo sociale annientandolo definitivamente. Viene attirato con un inganno ad una grande festa dove lo attende il dottor Rutenspitz, il medico che lo condurrà in manicomio. Confesso di aver molto letto i russi, Dostoevskij e Checov in particolare, da ragazzo, prima comunque di essermi fatto sedurre da Bruno Callieri a studiare la psicopatologia fenomenologica, ma ditemi cosa manca a Gerolamo Rizzo, questo povero maestro genovese per meritarsi un comodo posto di contorno, sulla scia.
ALTRE RECENSIONI ON LINE DEL VOLUME:
Giuseppe Zanda
Giovanni Martinotti
Luigi Benevelli
Massimo Lanzaro









Commenti
LA DOPPIA MORTE DI GEROLAMO RIZZO - Diaro clinico di una follia vissuta
Il nuovo libro di Francesco Bollorino e Gilberto Di Petta
Se non è disponibile su Amazon lo è alla grande su IBIS
Acquistatelo e fate sapere il vostro giudizio!!!
https://www.ibs.it/doppia-morte-di-gerolamo-rizzo-libro-gilberto-di-pett...